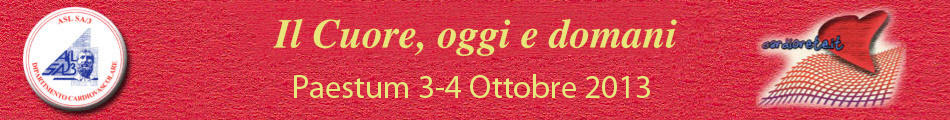
|
L’ Ipertensione Arteriosa dell’Anziano e del Grande Anziano
Roberto Viceconti, Luigi Petraglia,DimitrisChristodoulakis, GiovanniGregorio U.O. UTIC-Cardiologia Ospedale San Luca Vallo della Lucania
Alla domanda : ” Quanti anni ha la Vostra Signoria?” Galileo Galilei rispose: ” Quanti me ne restano ” aggiungendo che : ” I passati non li ho, sì come non si hanno i quattrini spesi ”.
PREMESSA Chi è anziano? · Età > 65 anni · “giovane” anziano (65-74 anni) · anziano fragile (75-85 anni) · grande anziano (> 85 anni)
Categoria Sistolica-Diastolica · Ottimale <120 <80mmHg · Normale 120-129 80-84mmHg · Normale alta 130-139 85-89mmHg · Ipertensione di grado 1 (lieve) 140-159 90-99mmHg · Ipertensione di grado 2 (moderata) 160-179 100-109mmHg · Ipertensione di grado 3 (severa) > = 180 > = 110mmHg
Definizione e classificazione dei livelli di pressione arteriosa secondo le linee guida della European Society of Hypertension (Journal of Hypertension 2003, 21:1011-1053)
L’ipertensione arteriosa, definita dalle linee guida ESC/ESH da valori di pressione sistolica >140 mmHg e di pressione diastolica >90 mmHg, rappresenta uno dei fattori di rischio modificabile per la comparsa delle malattie cardio e cerebrovascolari e si stima che in Italia oltre il 50% della popolazione geriatrica di entrambi i sessi ne sia interessata.L’ipertensione arteriosa è una patologia molto comune nelle persone anziane dei Paesi occidentali, arrivando ad interessare oltre il 60% degli ultrasessantacinquenni e il 70% e più dei soggetti di età superiore a 85 anni. La realtà clinica quotidiana ci pone spesso di fronte al quesito sull’importanza da attribuire ai valori pressori aumentati nei pazienti ultrasettantacinquenni, attualmente considerati i veri anziani. Questi soggetti, che rappresentano il segmento di popolazione in più rapida espansione, appaiono spesso in buone condizioni di salute e quindi con discreta attesa divita (a 75 anni 8,7 anni per l’uomo e 11 per la donna). Numerosi studi clinici ed epidemiologici hanno evidenziato che la prevalenza dell’ipertensione arteriosa aumenta parallelamente con l’aumentare dell’età tuttavia nella popolazione geriatrica dei Paesi sviluppati la forma di più frequente riscontro è l’ipertensione sistolica isolata (ISI).
IPERTENSIONE SISTOLICA ISOLATA Nella classe di ipertesi ultrasettantacinquenni è nettamente prevalente l’ipertensione sistolica isolata(ISI) (definita come PAS > 160 e PAD < 90 mmHg), la cui incidenza, diversamente da quella della diastolica che raggiunge il massimo nella 5°-6°decade, continua ad aumentare con il crescere dell’età. La prevalenza dell’ISI è variabile, oltre che in base alla scelta dei criteri di definizione, anche a seconda del numero delle misurazioni e visite effettuate.
Nello studio
SHEPaumenta
dal 7% tra 60-69 anni, all’ 11% tra 70-79, al 18% tra 80-89
anni. E’ inoltrepiù frequente nelle donne, soprattutto se
obese.E’ ormai acquisito che anche l’ISI, lungi da essere un
semplice meccanismo di compenso per assicurare la perfusione
tissutale in presenza di aumentate resistenze al flusso
ematico, costituisce un importante fattore di rischio
indipendente per gli eventi cardiovascolari, superiore a
quello associato all’ipertensione prevalentemente diastolica ed
è altresì assodato che il rischio assoluto è maggiore
nell’anziano rispetto all’adulto giovane. Per i grandi anziani (> 80 anni) manca invece un’evidenza certa, infatti alcuni studi non mostrano alcuna relazione mentre altri evidenziano addirittura un’associazione inversa tra PA e mortalità.
ACCERTAMENTI Un problema diagnostico specifico può essere costituito dal fatto che non è sempre facile discriminare il danno d’organo dovuto all’ipertensione da quello della semplice senescenza. L’ aumentata variabilità pressoria rispetto agli ipertesi giovani, dovuta alla ridotta capacità dei barocettori arteriosi di tamponare le oscillazioni pressorie, particolarmente ampie per la scarsa distensibilità delle grandi arterie, richiede, prima di iniziare una terapia, soprattutto in presenza di valori non molto elevati, ripetute misurazioni della PA, sia nella stessa visita che in visite successive. Nello studio CASTEL, condotto in Italia su 2254 anziani la prevalenza di ISI, risultata del 25% a 80 anni, si riduceva a 17% dopo 3 mesi di follow-up, in assenza di qualsiasi intervento se non la misurazione ripetuta per 7 volte. Gli anziani sono inoltre particolarmente suscettibili al cosiddetto “effetto camice bianco” e perciò in casi dubbi sarebbe auspicabile ricorrere all’automisurazione domiciliare o al monitoraggio ambulatoriale per 24 ore (MAP), per ottenere informazioni sui valori pressori in ambito non medico ed evitare così di trattare come ipertesi pazienti che non lo sono, esponendoli inutilmente ai possibili effetti collaterali dei farmaci. Il limite di queste metodologie è rappresentato dal fatto che nei pazienti over 75 non sono validati i corrispondenti valori di normalità. Lo studio PAMELA, ad esempio, ha dimostrato che i valori della PA domiciliare e della PA media delle 24 ore sono più bassi di quelli clinici (rispettivamente 130/80 e 120/76) in una popolazione di pazienti di età compresa tra 65 e 74 anni. Questi risultati non sono però estrapolabili alle classi di età superiore. Il MAP può comunque essere utile in casi specifici: sospetto di cali pressori oligosintomatici (confusione mentale !) o notturni, identificazione dei non-dippers, che non presentano il fisiologico calo notturno e richiedono perciò una terapia più mirata, valutazione dell’efficacia della terapia instaurata, in caso di dissociazione tra
LA PRESSIONE ARTERIOSA NEGLI ANZIANI DEL CILENTO.Risultati dello Studio LonCile. Informazioni interessanti si possono evincere dallo Studio LONCILE, una ricerca condotta dal Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania e dal Dipartimento di Antropologia dell’Università La Sapienza di Roma E’ stata valutata la prevalenza di ipertensione arteriosa, la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra, di alterazioni elettrocardiografiche, la distribuzione degli alleli dei genotipi dell’ACE e dell’ APO E , la presenza di patologia associata e la compliance terapeutica. La pressione arteriosa sistolica è risultata di 156,3 + 25,4, rispettivamente di 159,8 + 22,6 nelle femmine e di 151,8 + 28,1 nei maschi (p = 0,009) .La pressione arteriosa diastolica è risultata essere di 83,3 + 11,9, rispettivamente di 84,7 + 12,3 nelle femmine e 81,4 + 11,1 nei maschi ( p = 0,02). La popolazione è stata suddivisa sulla base dei valori di pressione sistolica nei seguenti gruppi: a) soggetti con PAS inferiore a 140 mm Hg: rappresentano il 22,8 5 dei soggetti arruolati nello studio, rispettivamente il 16,6 delle femmine e il 29,7 dei maschi (p= 0,04) b) soggetti con PAS compresa tra 140 mm Hg e 159 mm Hg : rappresentano il 27, 4% della popolazione , rispettivamente il 26,3 % dei soggetti di sesso femmine ed il 29,8 % dei soggetti di sesso maschile (p = non significativa). c) Soggetti con PAS oltre i 160 mm Hg : rappresentano il 49,8 % della popolazione, rispettivamente il 57,1 delle femmine ed il 40,5 % dei maschi (p = 0,02) Sulla base dei valori della Pressione arteriosa diastolica la popolazione è stata suddivisa nei seguenti gruppi: a) soggetti con valori di P.A.D. inferiore a 90 mm Hg: rappresentano il 62, 1 % della popolazione, rispettivamente il 57 % delle femmine ed il 70,3 % dei maschi.(p = 0,07) b) Soggetti con PAD compresa tra 90 e 95 mm Hg : rappresentano il 20,2 % della popolazione, rispettivamente il 23,1 % delle femmine ed il 16,5 % die maschi ( p = non significativa) c) Soggetti con PAD superiore a 95 mm Hg: rappresentano il 17,7% della popolazione, rispettivamente il 19,9 % delle femmine ed il 13,2 % dei maschi ( p = non significativa) ü La prevalenza di soggetti con PAS > 140 mm Hg e/ o PAD > 90 mm Hg è risultata essere del 35,7%, rispettivamente del 29,5 % nei soggetti di sesso femminile e del 43 % nei maschi (p = 0,028). La prevalenza di soggetti con PAS > 160 mm Hg e/o PAD > 95 mm Hg è risultata del 54,9%, rispettivamente del 61,5% nelle femmine e del 46,3 % nei maschi ( p = 0,016). La prevalenza di ipertensione arteriosa – soggetti con PAS > 160 mm Hg e/o PAD > 95 mm Hg o soggetti in trattamento ipotensivo - è risultata essere del 74,7 %, rispettivamente del 82,7 % nelle femmine e del 64,5 % nei maschi( p = 0,000). Gli ipertesi hanno un’età di 83,2 + 5,6 anni mentre i normotesi hanno un’ età di 81,9 + 5,5 anni ( p = 0,087).Il 52,7% degli ipertesi presenta alterazioni elettrocardiografiche. L’elettrocardiogramma anche in questo gruppo di popolazione anziana rappresenta un valido strumento per la documentazione del grado di impegno cardiaco determinato dalla ipertensione arteriosa. (Gregorio 1980). Il 73.9% degli ipertesi, rispettivamente il 76.7% delle femmine e il 69.2% dei maschi, assume farmaci ipotensivi. Il 64.1% dei soggetti che assumono ipotensivi, rispettivamente il 76,7 5 delle femmine ed il 69,2% dei maschi, ha valori di pressione arteriosa superiore ai 160 mmHg di sistolica e/o di 95 mmHg di diastolica. I farmaci utilizzati sono: 1. Calcioantagonisti 28.9% 2. Betabloccanti 8.5% 3. Alfabloccanti 7.2% 4. Aceinibitori 54.9 5. Antagonisti recettoriali dell’Angiotensina 7.2% 6. Diuretici 54.9%
Il 91% assume più di un farmaco. In particolare gli ipertesi dello Studio LonCile assumono: ü Digitale: 23.7% ü Nitroderivati 11.1% ü Antiaritmici 1.9% ü Antiaggreganti 21,7% ü Anticoagulanti 1.9% ü Ipocolesterolemizzanti 0.5% ü Ipoglicemizzanti 9.7% ü Insulina 2.4% Per quanto riguarda la distribuzione dei geni dell’ACE e dell’APO E i soggetti con ipertrofia ventricolare sinistra hanno minore prevalenza del genotipo APOE E2/E4,E3/E4 (p =0,03) e maggiore prevalenza di soggetti con genotipo APO E2/E2,E2/E3;E3/E3 (p = 0,015). I soggetti con ipertrofia ventricolare sinistra presentano anche una minore variabilità R-R nel breve periodo (Figura 10) - 21 + 7,7 ms rispetto ai 46,8 + 37 dei soggetti ipertesi senza ipertrofia v.s. ( P = 0,002), confermando il fatto che nell’ipertensione arteriosa il ruolo delle interazioni neuromediate riveste un ruolo importantissimo (Gregorio 1996).
OBIETTIVI PRESSORI NELL’ANZIANO E NEL GRANDE ANZIANO I livelli pressori da trattare non dovrebbero essere fissati troppo rigidamente ma inseriti nella valutazione globale del singolo individuo. Questa è infatti una tipica situazione clinica nella quale l’esperienza personale e la conoscenza globale del paziente prevalgono sui dati disponibili in letteratura. Tabella 1
Tabella 2
A grandi linee si può dire che una persona over 75 asintomatica con ipertensione non complicata (PAS 160-180 mmHg, PAD 95-110 mmHg) dovrebbe seguire inizialmente le direttive non farmacologiche. Dopo un congruo periodo di follow-up se PAD >90-95 e/o PAS > 160 mmHg (stabilmente), soprattutto in presenza di danno d’organo o di patologie aggravate dall’ipertensione deve essere iniziata la terapia farmacologica. Da segnalare che i benefici del trattamento sono stati finora dimostrati solo per PAS>160 mmHg per cui per valori compresi tra 140-160 mmHg la decisione finale spetta al medico (e anche al paziente). In caso di valori iniziali più alti (PAS > 180 mmHg o PAD > 110 mmHg), di danno d’organo o di pregressi eventi cardiovascolari la terapia può essere iniziata precocemente.
I GRANDI ANZIANI
Anche per
quanto riguarda l’età da trattare non è possibile stabilire
indicazioni troppo rigide, infatti mentre l’età cronologica è un
dato inconfutabile, quella biologica è molto variabile da
paziente a paziente. Con questi limiti possiamo rilevare
che,secondo lo studio EWPHE, l’indicazione alla terapia esiste
fino all’età di 80 anni mentre, seguendo le indicazioni degli
studi SHEP e STOP-Hypertension, il beneficio si osserva fino a
84 anni anche se nello SHEP, come già detto, l’effetto sulla
mortalità totale e cardiovascolare è risultato non significativo
(1).
SINTESI
|