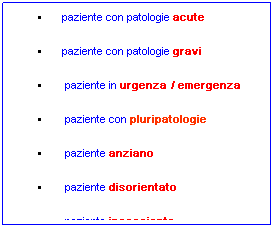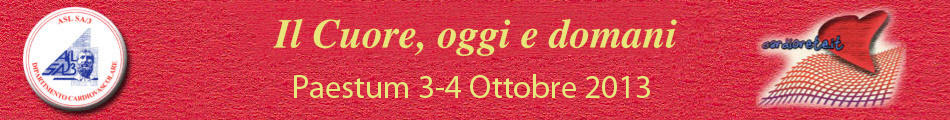
|
Anziano, Grande Anziano, Malattia Cardiovascolare e Rischio Clinico
Quinto Tozzi Agenas ROMA
Non sono ancora del tutto univoche le definizioni di anziano e grande anziano. Ciò è dovuto a possibili diversi criteri di classificazione; se viene presa in considerazione la sola età in genere per “anziano” si intende l’ultrasessantacinquenne e per “grande anziano” chi ha superato gli 80 anni (anche se non sono tutti concordi su questi limiti). Se invece si prende come criterio anche la capacità relazionale ed il grado di autonomia le opinioni diventano ancora meno concordanti. Il concetto di anziano non deve invece essere confuso con quello di “senescenza” cioè, in termini un po’ grossolani, di quanto una persona è vecchia; l’emodinamica, ad esempio a questo riguardo, ci insegna infatti come a volte alcuni pazienti piuttosto giovani hanno delle coronarie con caratteristiche tipicamente senili in termini di elasticità, tortuosità e placche e viceversa a volte troviamo anziani con un albero coronarico assolutamente invidiabile; lo stesso paragone potrebbe essere fatto anche con l’aspetto cerebrale e motorio e per la funzionalità di molti organi. Oggi il concetto di anziano in ambito sanitario è sempre più, giustamente, associato al concetto di “complessità” perché è infatti questa la sua caratteristica dominante sia dal punto di vista clinico che organizzativo (nel senso di complessità dell’organizzazione che se ne deve prendere carico). Tale complessità si concretizza dal punto di vista clinico nelle polipatologie cui è praticamente quasi sempre affetto e nella loro gestione ottimale anche a livello organizzativo. E’ infatti questo un tipico caso in cui la non corretta (cioè inappropriata) organizzazione dei servizi sanitari incide oltre che sugli sprechi anche sull’efficacia e la sicurezza stessa delle cure (anche, è inutile nasconderselo, in termini di esiti cioè mortalità e complicazioni evitabili). Nell’anziano inoltre è particolarmente evidente e concreta, particolarmente in questo periodo di crisi, quell’area grigia di sovrapposizione per alcuni aspetti tra sanitario e sociale che incrementa notevolmente la complessità di gestione globale dell’anziano “paziente”. Dalla varia commistione di questi fattori scaturisce il concetto, altrettanto concreto, di persona “fragile” cioè di persona “particolarmente vulnerabile” sia a condizioni sia clinico assistenziali che di contesto, che cioè non è in grado di affrontare autonomamente tutti problemi legati alla sua condizione sociale e sanitaria. Il concetto di fragilità deve in altri termini essere esteso anche all’aumentato rischio che ha il paziente stesso di commettere errori di carattere sanitario che di subirne sia in ambiente ospedali che nella gestione territoriale.
Non vi è una particolare tipologia di approccio alla gestione del rischio clinico per il paziente anziano e grande anziano; le regole generali e la metodologia sono le stesse sia per gli aspetti di prevenzione degli errori sia per gli strumenti da mettere in atto dopo un evento avverso. Il concetto fondamentale da tenere invece bene in mente è che questa tipologia di pazienti, a parità di altre condizioni, ha un rischio molto più elevato dei pazienti più giovani e di questo ovviamente non si può non tenere conto. Se inoltre consideriamo che, come noto, la popolazione anziana è tendenzialmente crescente ed il contesto in cui tutti noi lavoriamo presenta spesso delle importantissime criticità legate alla carenza di risorse ed a modelli organizzativi sempre meno in grado di affrontare efficacemente la complessità delle situazioni clinico assistenziali è evidente come l’argomento deve avere la massima considerazione in termini di attenzione e di azioni efficaci intraprese. Ovviamente ciò riguarda tutti gli operatori sanitari ma anche tutta la catena gestionale dall’interno delle UO ai massimi livelli aziendali, regionali e nazionali; in altri termini un approccio corretto e con accettabili probabilità di efficacia la gestione del rischio clinico anche nell’anziano non può prescindere da una vera sistematicità dell’approccio metodologico, valutativo, organizzativo e clinico assistenziale. Nell’ambito del risk management vi è una correlazione diretta ed inconfutabile tra complessità e rischio di commettere errori (sia organizzativi che clinici) per cui è altrettanto evidente e dimostrato che il paziente anziano è, già solo per la sua condizione, un soggetto a rischio di errore particolarmente alto e che quindi, per la sicurezza sua e di tutti, gli operatori sanitari necessita di essere affrontato nel modo appropriato cioè con idonei strumenti metodologici e non solo con l’intuizione, l’esperienza ed il buon senso (necessari ma oggi assolutamente non più sufficienti ad affrontare efficacemente questo nuovo contesto). Le malattie cardiovascolari per loro intrinseca natura sono tipiche e praticamente quasi costanti dell’anziano; sempre di più sono infatti gli anziani nei nostri reparti e di essi non si può non tener conto nell’organizzazione delle attività clinico assistenziali e nella programmazione delle attività future. E’ il caso di porsi però, in tutta onestà, anche una domanda scomoda ma necessaria sotto molti aspetti: l’anziano è un ospite gradito (nel senso di facilità di gestione) presso i nostri reparti? La risposta, sempre in tutta onestà, è probabilmente no ovviamente non per cattiveria ma perché non fa piacere a nessuno avere problemi; dato però che l’aumento degli anziani è una delle poche certezze della sanità presente e futura abbiamo tutti già da tempo ed in vari modi iniziato ad organizzarci per affrontare questa grande problematica. I motivi di questa ritrosia li conosciamo tutti: sono pazienti spesso problematici, poco gratificanti professionalmente, complessi, difficili da interpretare e trattare, scomodi, a volte disturbanti, ecc. Le cause di tutto ciò sono molteplici e le due principali sono prima di tutto un problema culturale nel senso che gran parte del personale sanitario non è stato adeguatamente formato a rapportarsi in modo scientificamente corretto con l’anziano e le sue problematiche ed in secondo luogo, ed al precedente correlato, un modello organizzativo e gestionale che non è fatto per pazienti con le caratteristiche dell’anziano (classico esempio l’UTIC); a questo sono praticamente ovunque da aggiungere le diffuse problematiche dei reparti in termini di risorse e carichi di lavoro che rende ancora più gravosa e rischiosa la loro gestione. Problemi importanti che non sono però irrisolvibili ma che hanno la caratteristica di incidere in modo importante sul rischio che hanno questi pazienti di subire un errore e del parallelo e direttamente correlato rischio degli operatori sanitari di commetterlo con tutte le ben note e devastanti conseguenze sulla vita professionale e non.
Per quanto riguarda il rischio di errore questo è legato a molti fattori di cui i più frequenti ed importanti, oltre al contesto organizzativo gestionale ed ai fattori di rischio legati agli operatori sanitari, sono elencati nella Fig. 1.
Fig. 1. Condizioni legate al paziente che favoriscono l’errore; la maggior parte possono essere presenti nei pazienti anziani.
Queste condizioni di rischio variamente rilevanti sono frequentemente presenti, in tutto od in parte, nel paziente anziano. Tra i molti fattori che possono indurre all’errore uno particolarmente importante nell’anziano ed ancor più in genere nel grande anziano è quello relativo alla qualità della comunicazione sanitaria ed in particolare la capacità del paziente di esprimere i suoi problemi e recepire le informazioni provenienti dai vari operatori sanitari con particolare riferimento alla loro comprensione, completezza, veridicità ed attendibilità. La comunicazione con le strutture può invece creare problemi all’accesso ai servizi sanitari e le relative ulteriori problematiche. Tutto ciò ha evidenti e non teoriche ripercussioni sugli esiti delle cure e sulla loro sicurezza. Conoscere e correttamente interpretare l’entità del problema è elemento essenziale per prevenire concretamente questo tipo di errori. L’altro aspetto in cui il rischio di errore negli anziani è particolarmente rilevante è relativo alla terapia farmacologica. Gli errori nell’assunzione dei farmaci sono infatti uno dei più classici errori commessi dagli anziani; ciò è fortemente favorito dalla praticamente quasi costante politerapia, dai coesistenti problemi cognitivi e di comunicazione. A questo si aggiungano a carico delle decisioni cliniche degli operatori sanitari le evidenze scientifiche che per molti farmaci nella popolazione anziana sono meno forti che nelle altre età perché non raramente gli anziani sono esclusi dai trials clinici e dalle metanalisi. Non sempre poi viene preso in attenta e dovuta considerazione sia il problema (perché tale è e molto più importante di quanto si creda) delle interazioni tra farmaci in pazienti anziani ed il politerapia sia degli eventi avversi da farmaci (tema non sempre adeguatamente sviluppato nella cultura e nella prassi dei medici). Tutto ciò aumenta quindi spesso considerevolmente e concretamente il rischio che ha l’anziano di subire errore. L’anziano cardiopatico è quindi è intrinsecamente un soggetto ad alto rischio di errore cui si aggiunge il rischio “normale” di errore proprio di tutte le attività sanitarie. Ciò richiede prima di tutto la corretta conoscenza del problema che dia luogo ad un’attenzione ancora maggiore nella sua gestione clinica, assistenziale ed organizzativa di questi pazienti.
|