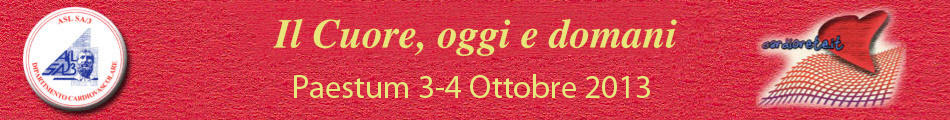
|
LA TERAPIA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA NELL’ANZIANO E NEL GRANDE ANZIANO
Michele A. Tedesco U.O.C. di Cardiologia, A.U.P. Seconda Università di Napoli.
L’ipertensione arteriosa è una patologia molto comune nelle persone anziane dei Paesi occidentali, arrivando ad interessare oltre il 60% degli ultrasessantacinquenni e il 70% e più dei soggetti di età superiore a 85 anni. È stato osservato nei Paesi sviluppati un incremento lineare della pressione arteriosa sistolica di circa 1 mm all’anno fino agli 80 anni, mentre per la pressione diastolica, dopo un picco massimo che si colloca intorno ai 60 anni, si registra un graduale decremento negli anni successivi. Particolarmente frequente nelle persone anziane dei paesi sviluppati è l’ipertensione sistolica isolata, caratterizzata da un patologico aumento della pressione sistolica (PAS), in presenza di valori normali di pressione diastolica (PAD). Questa condizione arriva ad interessare fino al 45% degli ipertesi anziani ed è la principale responsabile dell’incremento della prevalenza di ipertensione arteriosa che si verifica in età avanzata. Questa particolare forma di ipertensione arteriosa sarebbe favorita nella sua insorgenza da un incremento associato all’età della rigidità aortica, che comporta un aumento della velocità di trasmissione dell’onda sfigmica, da cui deriva un incremento della pressione differenziale ed una iperpulsatilità della parete arteriosa. Anche nell’anziano l’ipertensione è essenziale o primaria in più del 90% dei casi. I risultati dello studio ICARe Dicomano hanno dimostrato che pazienti anziani con ipertensione sistolica isolata borderline (PAS 140-159 mmHg e PAD <90 mmHg) presentano dimensioni ed indici di rigidità delle carotidi e massa ventricolare sinistra sovrapponibili a quelli dei pazienti con ipertensione diastolica o sisto-diastolica, nonostante livelli inferiori di PAD e di pressione media. La PP è infatti la variabile emodinamica più strettamente associata alla compliance carotidea. Queste osservazioni possono spiegare come mai in studi longitudinali, a partire da quello di Darnè et al. del 1989, la PP sia risultata predittiva del rischio cardiovascolare più della PAS o della PAD da sole, in soggetti di età adulto-giovanile e, ancora di più, in età avanzata. Due meta-analisi di trial clinici hanno quantizzato il rischio cardiovascolare associato alla PAS e alla PP in anziani con ipertensione sistolica. Secondo una metanalisi di Staessen, che ha raccolto dati relativi a 15693 pazienti arruolati in otto trial, per ogni 10 mmHg di aumento della PAS la mortalità aumentava del 26% (p<0.001), il rischio di ictus del 22% (p<0.001) e quello di eventi coronarici solo del 7% (p=0.37). È interessante osservare che, in questo studio, la mortalità era inversamente correlata alla PAD, a parità di PAS, risultato che conferma implicitamente il ruolo della PP come determinante emodinamico primario del rischio. La seconda metanalisi, basata su circa 8000 pazienti in tre trial, ha riportato che, per ogni 10 mmHg di incremento della PP, la mortalità totale e cardiovascolare, l’incidenza di ictus e quella di eventi coronarici aumentavano, rispettivamente, del 15% (p<0.001), 22% (p<0.001), 17% (p<0.001) e 13% (p<0.05). Sarebbe un grave errore considerare l’ipertensione arteriosa nell’anziano, sia sisto-diastolica, sia sistolica isolata, una condizione in qualche modo fisiologica, normale e benigna, sottovalutandone la natura di rilevante fattore di rischio. In realtà, anche in età senile l’ipertensione arteriosa rimane il principale fattore di rischio modificabile per l’ictus cerebrale e per lo scompenso cardiaco, svolgendo comunque un ruolo considerevole anche nel predisporre all’insorgenza di cardiopatia ischemica, di insufficienza renale e di arteriopatia periferica. Inoltre, il rischio di patologie cardio e cerebrovascolari, che è due-tre volte maggiore negli ipertesi rispetto ai normotesi, è ancora più elevato nei soggetti anziani. Numerosi studi clinici controllati e randomizzati hanno confermato che i benefici della terapia antiipertensiva riguardano anche i pazienti anziani affetti da ipertensione sisto-diastolica o sistolica isolata, in termini di riduzione sia della morbilità e della mortalità per ictus e per malattie cardiovascolari, nonché di una lieve diminuzione della mortalità globale. Nei pazienti ultraottantenni gli eventi cardiovascolari fatali e non fatali combinati, ma non la mortalità globale, subiscono una riduzione per effetto della terapia antiipertensiva. Poiché in questa fascia di pazienti i benefici sono più limitati, la terapia, quando veramente necessaria, deve essere condotta con particolare cautela e gradualità. Salvo casi particolari, la terapia antiipertensiva si propone nell’anziano il raggiungimento graduale di valori di pressione arteriosa inferiori a 140/90 mmHg. In caso di ipertensione sistolica isolata, valori di PAD inferiori a 70 mmHg e soprattutto al di sotto di 60 mmHg sembrerebbero associarsi con un incremento del rischio cardiovascolare e con una prognosi sfavorevole. In molti pazienti, per ottenere un adeguato controllo pressorio si rende necessario impiegare due o più farmaci, in particolare in composizione prefissata. Va detto però che, sulla base dei risultati di diversi studi anche recenti, solo il 25-30% degli anziani ipertesi raggiunge e mantiene i valori pressori che costituiscono l’obiettivo di un trattamento adeguatamente efficace. Ciò comporta un abbattimento del rischio cardio e cerebrovascolare nettamente inferiore rispetto a quello che ci si potrebbe teoricamente aspettare. Il perché di risultati così deludenti trova diverse spiegazioni. In primo luogo il problema dell’ipertensione arteriosa viene probabilmente sottostimato nella sua importanza dopo una certa età. La scelta di intraprendere un trattamento antiipertensivo dipende nell’anziano da più variabili che, nell’insieme, riflettono il profilo di rischio cardiovascolare di ciascun soggetto. Esse sono: i valori di pressione arteriosa; la presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare; la presenza di danno d’organo; la presenza di diabete o di patologie associate che incrementano il rischio cardiovascolare; la presenza di altre malattie non di tipo cardiovascolare, quali le alterate funzioni cognitive o la vera e propria demenza senile (vascolare o degenerativa). La relazione tra l’ipertensione e la demenza divenuta oggetto di studio interessante e stimolante in questi ultimi anni. Infatti se il nesso causale fra demenza vascolare e ipertensione arteriosa è meglio definito, ancora molte ombre sono presenti nel rapporto tra ipertensione arteriosa e demenza di Alzheimer. In uno studio trasversale, di dimensioni limitate ma molto innovativo, è stata dimostrata una correlazione tra elevati valori di pressione arteriosa notturna ed una peggiore performance cognitiva. Quando possibile, il primo passo consisterà nella prescrizione di una terapia non farmacologia, che miri alla modificazione dello stile di vita. Per quanto attiene alla terapia farmacologia, la scelta del farmaco da impiegare per iniziare il trattamento dipenderà dalla presenza di altri fattori di rischio, di segni di danno d’organo e di eventuali patologie associate. Il beneficio del trattamento nell’anziano è stato dimostrato per almeno un composto delle seguenti classi di farmaci antiipertensivi: diuretici; beta-bloccanti; calcio-antagonisti; ACE-inibitori; bloccanti recettoriali dell’angiotensina II. L’intervento terapeutico deve essere graduale, specie nei pazienti in più precarie condizioni generali. è consigliabile iniziare con un solo farmaco a basso dosaggio o con dosi ridotte di un’associazione di due medicamenti. Se necessario, si potranno aumentare progressivamente, ma in modo graduale, le dosi dei farmaci antiipertensivi.
BIBLIOGRAFIA
1. Safar ME. Systolic hypertension in the elderly: arterial wall mechanical properties and the rennin-angiotensin-aldosterone system. J Hypertens. 2005 Apr;23(4):673-81). 2. Pini R, Cavallini M, Bencini F, et al. Cardiovascular remodeling is greater in isolated systolic hypertension than in diastolic hypertension in older adults: the Insufficienza Cardiaca negli Anziani Residenti (ICARE) a Dicomano Study. J Am Coll Cardiol 2002; 40:1283-1289. 3. Staessen JA, Fagard R, Thijs L, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet 1997; 350:757-764. 4. Glynn RJ, Chae CU, Guralnik JM, et al. Pulse pressure and mortality in older people. Arch Intern Med 2000; 160:2765-2772. 5. Pini R, Cavallini MC, Bencini F, et al. Cardiac and vascular remodeling in older adults with borderline isolated systolic hypertension: the ICARe Dicomano Study. Hypertension 2001;38:1372-1376. 6. Darne B, Girerd X, Safar M, et al. Pulsatile versus steady component of blood pressure: a cross-sectional analysis and a prospective analysis on cardiovascular mortality. Hypertension 1989; 13:392-400. 7. Staessen JA, Gasowski J, Wang JG, et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000; 355:865-872. 8. Messerli FH, Kupfer S, Pepine CJ. J curve in hypertension and coronary artery disease. Am J Cardiol. 2005;95(1):160. 9. Kahonen-Vare M, Brunni-Hakala S, Lindroos M, et al. Left ventricular hypertrophy and blood pressure as predictors of cognitive decline in old age. Aging Clin Exp Res 2004;16(2):147-152. 10. de Leeuw FE, Barkhof F, Scheltens P. Alzheimer's disease--one clinical syndrome, two radiological expressions: a study on blood pressure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75(9):1270-1274. 11. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. for the HYVET Study Group Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.
|