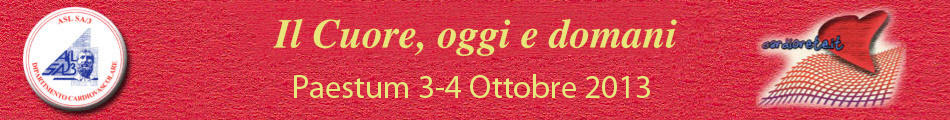
|
Il punto sulla terapia dello Scompenso Cardiaco Acuto nell’ Anziano e nel Grande Anziano
Vittorio Palmieri, Mariarosaria Pagliuca* AORN e di alta specialità “S.G. Moscati” – Avellino; * UOS di Scompenso cardiaco
La fase acuta dello scompenso cardiaco si caratterizza per la presentazione rapida e persistente (acuta) dei sintomi classici dello scompenso cardiaco cronico, ovvero del rapido un incremento della pressione di riempimento dei ventricoli, della congestione polmonare che ostacola gli scambi gassosi, dell’incremento acuto della pressione venosa centrale, e della subottimale perfusione dei tessuti periferici. In tale fase, i momenti “clinicamente” cruciali sono tre: innanzitutto è determinante la diagnosi differenziale (tra le più comuni: processo broncopmenumonico/broncopatia cronica riacutizzata oppure grave anemia, oppure insufficienza renale acuta non su base emodinamica, embolia polmonare; tutte condizioni che possono anche accompagnarsi allo scompenso cardiaco acuto come conseguenza o concausa scatenante); in secondo luogo è importante riconoscere e trattare quanto prima cause scatenanti (tra queste, in primis la sindrome coronarica acuta, le tachiaritmie o bradiaritmie severe,ma anche tra le più frequenti le infezioni polmonari o renali, ovvero l’esacerbazione di broncopatie croniche-asma, il peggioramento della funzione renale su base emodinamica o da uso di FANS o corticosteroidi in pazienti predisposti, l’anemia, o anche patologie più drammatiche e prognosticamente molto gravi come il tamponamento cardiaco, le sindromi aortiche, la cardiomiopatia peri-partum, l’embolia polmonare massiva, la crisi ipertensiva maligna); infine, è determinante riconoscere condizioni che nell’immediato sono associate a prognosi infausta a brevissimo, ovvero la grave ipossia e l’ipotensione (shock) e dunque la disfunzione multi organo progressiva, rapida e grave. L’anziano (età>65 anni, ma si tende a spostare la definizione a>70 anni) ed il grande anziano (età >80 anni), rappresentano “una sfida nella sfida” nel contesto clinico dato, poiché da un lato essi presentano frequentemente comorbiditàfisiopatologicamente e prognosticamenterilevanti (tra i più frequenti l’insufficienza renale cronica, l’insufficienza respiratoria cronica, l’anemia, le valvulopatie),che possono essere cause scatenanti dello scompenso cardiaco o aggravarsi di conseguenza, ma che vanno trattate contestualmente; dall’altro lato, l’anziano ed il grande anziano hanno spesso caratteristiche di fragilità importante (deficit cognitivo, ipo/malnutrizione, instabilità posturale/allettamento, immuno-incompetenza, patologie valvolari concomitanti) che rendono gli interventi terapeutici complessi dal punto di vista del piano assistenziale. La terapia medica classica, basata su diuretici (tradizionali o meno) e vasodilatatori, e talvolta inotropi, determinano tipicamente una risposta “bifasica”, ovvero determinano in media una iniziale risposta positiva, ma nel breve possono esacerbare la fisiopatologia delle comorbidità (peggioramento della funzione renale e resistenza ai diuretici, ipotensione/ipoperfusione tissutale, instabilità emodinamica nella stenosi aortica, incremento del consumo d’ossigeno miocardico in pazienti con sottostante insufficienza coronarica complessa). Per tale motivo, trattamenti quali la ventilazione non invasiva, l’accesso rapido all’angiografia coronarica in emergenza nelle sindromi coronariche acute ovvie o sospette, l’assistenza meccanica al circolo mediante contro-pulsazione,l’ultrafiltrazione, rappresentano trattamenti aggressivi sempre più utilizzati, in concomitanza con quelli farmacologici classi, per contrastare la fase iperacuta dello scompenso cardiaco e le sue conseguenze/comorbidità, e ridurre al minimo la possibilità di una rapida progressione della sindrome della disfunzione multi-organo. Per contro, va attentamente ponderato il rapporto beneficio/rischio per le possibili complicanze (in particolare quelle vascolari), e misurati tali interventi in un contesto di valutazione complessivadel paziente, che tenga conto anche dello stato cognitivo e dell’autonomia funzionale pre-ricovero, e della reale possibilità di “restitutio ad integrum” di tali pazienti.
|