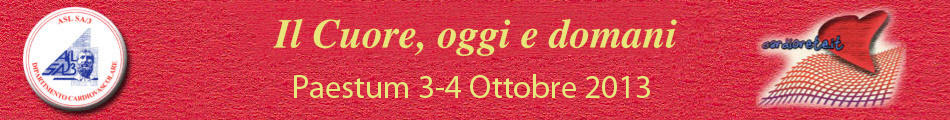
|
4 SCOMPENSO CARDIACO
● Il punto sulla terapia dello Scompenso C. Cronico nell’ Anziano e nel Grande Anziano
● Il punto sulla terapia dello Scompenso C. Acuto nell’ Anziano e nel Grande Anziano
● Miocardiopatia dilatativa e Scompenso Cardiaco nell’Anziano e nel Grande Anziano
● Anemia e Scompenso nell’Anziano e nel Grande Anziano
● Insufficienza renale e Scompenso nell’Anziano e nel Grande Anziano
Il Punto sulla Terapia dello Scompenso Cardiaco Cronico nell’ Anziano e nel Grande Anziano
Sergio Cuomo Cardiologia SUN Presidio Ospedaliero Monadi - Napoli Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero "S. Luca" - Vallo della Lucania
L’Italia, insieme al Giappone, è la nazione con la più alta percentuale di ultra-ssessantacinquenni ( ~ 20%). Conseguenza dell’invecchiamento della popolazione è l’aumento dei tassi di incidenza e prevalenza di malattie croniche, in particolare dello scompenso cardiaco cronico, che rappresenta la più comune evoluzione clinica di molte malattie cardiovascolari. Non sorprende che gli anziani siano i maggiori beneficiari delle risorse sanitarie ed i massimi consumatori di farmaci, come dimostrato anche in Italia da un recente rapporto OSMED (Osservatorio dei Medicinali; Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, 2011). In particolare, i farmaci cardiovascolari, soprattutto quelli per l’ipertensione arteriosa e lo scompenso cardiaco, rappresentano la categoria farmaceutica più prescritta. Eppure, nonostante il peso epidemiologico, le conoscenze sulla terapia dello scompenso cardiaco nell’anziano sono ancora abbastanza limitate. Nell’era dell’evidence based medicine, il giudizio di efficacia dei farmaci deriva quasi esclusivamente dai risultati di trial clinici randomizzati e dalle meta-analisi di questi studi. Tuttavia i trial randomizzati sulla efficacia delle terapie dello scompenso cardiaco tendono ad arruolare pazienti che non sono affatto rappresentativi della popolazione che maggiormente assume queste terapie. Per opportunismo metodologico, il paziente arruolato nei trial è frequentemente di sesso maschile, di media età, non è affetto da pluri-patologie e non è in trattamento con farmaci diversi da quelli oggetto di studio. Anche nei pochi trial disegnati specificamente per valutare le terapie dello scompenso nell’ anziano, i soggetti arruolati non rispecchiano la reale tipologia dei pazienti che si incontrano nella pratica clinica, perché rispetto alla popolazione reale si rileva età meno avanzata, frazione d’eiezione ventricolare sinistra maggiormente depressa, minor presenza di comorbidità, minor numero di farmaci in associazione, minore disabilità fisica e deterioramento cognitivo, minore rappresentazione del sesso femminile. La discordanza tra evidence-based medicine e pratica clinica aumenta ancor più quando ci si riferisce al grande anziano, che è il grande assente nei trial clinici su cui si fondano le raccomandazioni delle Linee Guida. A ben riflettere utilizziamo linee guida elaborate secondo i principi della medicina basata sulle evidenze, ma fondate su evidenze poco basate sulla medicina reale. In parole povere applichiamo empiricamente nella cura dei pazienti anziani conoscenze maturate su popolazioni composte prevalentemente da pazienti mediamente più giovani e molto diversi. La consapevolezza della difficoltà nel trasferire i risultati dei trial randomizzati alla pratica reale, non autorizza tuttavia ad ignorare le raccomandazioni delle linee guida nella cura dell’anziano. L’efficacia nella pratica reale di un trattamento può essere valutata anche con metodologia diversa dai megatrial, ad esempio mediante studi osservazionali ben disegnati, che, a differenza dei trial clinici controllati, possono studiare vaste popolazioni affette da una determinata patologia, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla presenza di comorbidità. Diversi studi osservazionali di elevata qualità, condotti su migliaia di pazienti non selezionati, dimostrano che il beneficio clinico netto conseguito con i vari trattamenti dello scompenso non mostra differenze sostanziali tra pazienti anziani e pazienti più giovani, anche se a prezzo di reazioni avverse alla terapia più frequenti e severe. Non si giustifica, quindi, quanto emerge dall’analisi di svariate banche dati che documenta la sottoutilizzazione nell’anziano scompensato di terapie farmacologiche in grado di ridurre morbilità e mortalità e la variabilità dell’atteggiamento terapeutico in ragione del sesso e dello stato sociale dei pazienti,derivanti dalla non aderenza alle linee guida. Va tuttavia sottolineato come l’approccio assistenziale convenzionale sia frequentemente inadeguato nell’ anziano. Se in teoria il concetto di terapia ottimizzata dello scompenso dovrebbe tradursi nel somministrare al paziente tutti i farmaci che hanno dimostrato nei trial effetto benefico sulla prognosi e qualità della vita, possibilmente alla dose target o alla dose massima tollerata per ciascun farmaco, nella vita reale occorre individuare dei criteri di personalizzazione della terapia, soprattutto nella cura dell’anziano. Se consideriamo che il paziente affetto da scompenso cronico deve assumere un beta-bloccante, un ACE inibitore e molto spesso anche un diuretico, un antialdosteronico, la digitale, un anticoagulante, l’ amiodarone e svariati altri farmaci per il trattamento delle frequenti comorbidità, risulta evidente che “l’armadietto dei farmaci” finisca per essere spesso strapieno. Ciò comporta inevitabili conseguenze sia sull’aderenza che sulla tolleranza alla terapia, per cui spesso non è possibile raggiungere i dosaggi target indicati dai grandi trial. Poco chiare sono le linee di condotta da adottare quando la ridotta tolleranza alla terapia costringe a privilegiare, almeno in termini di posologia, una classe farmacologica rispetto all’altra, così come i criteri da utilizzare nella scelta di una molecola all’interno della stessa classe farmacologica. Altro responsabile della scarsa qualità delle cure nell’anziano è l’ assenza di continuità assistenziale, dovuta all’assenza di programmazione alla dimissione ospedaliera, che avviene spesso dopo degenze troppo brevi, alla mancanza di comunicazione tra i diversi operatori sanitari, all’assenza di un follow-up personalizzato che tenga conto dello stato funzionale globale, delle comorbidità e del contesto socio-ambientale del paziente. Va da sé che un approccio razionale della terapia dello scompenso soprattutto nell’anziano dovrebbe basarsi su un’effettiva integrazione ospedale-territorio, slogan molto inflazionato ma, per motivi più o meno ignoti, mai concretizzato.
|