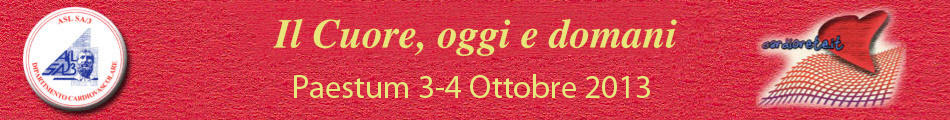
|
L’Anziano e il Grande Anziano dopo Angioplastica Coronarica
Paolo Calabrò Cattedra di Cardiologia Seconda Università di Napoli A.O. dei Colli - Monaldi
I pazienti anziani con infarto miocardico sono ad elevato rischio, tuttavia non esistono studi randomizzati di grandi dimensioni che permettano di conoscere con certezza la miglior strategia di rivascolarizzazione in questi pazienti. L’assenza di informazioni associata alla presentazione clinica spesso atipica e tardiva ed alla frequente co-morbilità hanno contribuito alla importante sottoutilizzazione della riperfusione meccanica in questo gruppo di pazienti. Anche se i risultati immediati dell’angiopalstica coronarica e dell’applicazione di stent endocoronarici hanno ottenuto buon successo angiografico, l’età rimane un fattore prognostico negativo a breve ed a lungo termine. Una strategia invasiva di rivascolarizzazione d’urgenza appare indicata nei pazienti anziani con infarto complicato da shock cardiogeno. L’età rappresenta un fattore di rischio indipendente di mortalità per infarto miocardico acuto ad ST sopraslivellato (STEMI): anche tenendo conto delle variabili cliniche ed angiografiche, i pazienti di età superiore a 75 anni hanno rischio di morte da quattro a nove volte superiore al gruppo più giova-n Nello studio italiano BLITZ la mortalità nella popolazione anziana con STEMI (296 pazienti di età > 75 anni, il 23% della casistica), è risultata cinque volte superiore a quella dei pazienti di età < 75 anni (19.9% vs 3,7%). La tempestiva riperfusione del vaso coronarico correlato all’infarto, si è dimostrata efficace nel ridurre la mortalità. Malgrado l’incidenza ed il rischio più elevati nello STEMI fra i pazienti più anziani, molti studi randomizzati che hanno confrontato la riperfusione meccanica con quella farmacologica, hanno escluso sistematicamente i pazienti anziani e quando inclusi, questi erano scarsamente rappresentati. Di conseguenza, il rapporto rischio/beneficio della terapia di riperfusione o della strategia ottimale di riperfusione negli anziani con STEMI sono poco conosciuti. La mancanza di dati, la frequente presentazione atipica e/o tardiva, l’elevata comorbilità hanno contribuito alla sottoutilizzazione di questa strategia terapeutica in questa popolazione. L’età avanzata è uno dei fattori predittivi di omissione all’uso della terapia di riperfusione in pazienti potenzialmente eleggibili. Purtroppo la ridotta presenza della popolazione anziana è costante in tutti gli studi randomizzati: in 465 studi che hanno arruolato 47778 pazienti con diagnosi di infarto miocardico acuto, gli anziani rappresentavano solo il 5.8% dei casi. Inoltre, l’età avanzata è uno dei fattori predittivi di omissione o sottoimpiego della terapia antipiastrinica ed anticoagulante potente disponibile ai giorni nostri in pazienti anche qui potenzialmente eleggibili. In termini di strategia, è raccomandato e crescente l’ impiego di un approccio sistematicamente invasivo in tutto lo spettro delle SCA, in maniera indipendente dall’ età del paziente. Le dimostrazioni di un vantaggio dell’ angioplastica primaria nel paziente anziano con STEMI sono recenti, come pure le evidenze di un beneficio addirittura preferenziale nel paziente anziano di una strategia precocemente invasiva nella SCANSTE. Ciò tuttavia comporta un impiego maggiore di potenti farmaci antipiastrinici in fase acuta e della duplice terapia antiaggregante piastrinica nel follow-up. Queste sono alcune delle evidenze su efficacia e sicurezza delle terapie antipiastriniche nel paziente anziano. A fronte di importanti peculiarità nell’ assorbimento, distribuzione, metabolismo e propensione a sviluppare effetti dannosi dei farmaci nel paziente anziano [6], le evidenze del rapporto rischio/beneficio dei farmaci antipiastrinici in questi pazienti sono scarse. Nella metanalisi dell’ Anti Thrombotic Trialists’ collaboration, l’ impiego di aspirina in profilassi secondaria ha dimostrato un beneficio qualitativamente simile, ma quantitativamente maggiore nei pazienti anziani rispetto a quelli più giovani, con una riduzione di eventi di circa 20% nel follow-up. La somministrazione di basse dosi di aspirina (75-100 mg), dopo una dose iniziale di 325 mg, è particolarmente indicata nel paziente anziano. Tuttavia, anche queste dosi di aspirina espongono a un eccesso di sanguinamento, rispetto ai controlli, che aumenta con l’ età e con l’ anamnesi di ulcera peptica. Per tale motivo, l’ utilizzo di aspirina in prevenzione primaria non è raccomandata nel paziente anziano, per il sospetto (in assenza di dati specifici) che l’ eccesso di sanguinamento, anche fatale, possa controbilanciare la modesta (in assoluto) riduzione di eventi cardiovascolari. L’ associazione di inibitori della pompa protonica è fortemente raccomandata nei pazienti di età maggiore di 60 anni con storia di ulcera peptica. Per quanto riguarda la duplice terapia antipiastrinica in pazienti con SCA, bisogna rifarsi ai dati dello studio CURE, in cui l’ aggiunta di clopidogrel ad aspirina dopo SCANSTE ha ridotto del 20% il rischio di eventi cardiovascolari, aumentando del 38% il rischio di sanguinamenti maggiori. In termini di rischio relativo, la riduzione è stata inferiore nei pazienti di età >65 anni in confronto a quella osservata nei pazienti più giovani (13% vs 29%). L’ effetto clinico di prasugrel vs clopidogrel nello studio TRITON-TIMI 38 è stato simile a quello dimostrato da clopidogrel vs aspirina nello studio CURE: una riduzione del 19% del rischio di eventi ischemici in pazienti con SCA trattati con angioplastica, a fronte di un aumento del 32% del rischio di sanguinamento maggiore. Tuttavia, nei pazienti di età >75 anni, non si è osservata una riduzione significativa di eventi ischemici, a fronte di un aumento di sanguinamento maggiore, in particolare di quello fatale. Il timing dei sanguinamenti non è tanto acuto (dose da carico di 60 mg), pur in associazione ad altre potenti terapie antitrombotiche tipiche della fase acuta, quanto nel follow-up, ed è soprattutto a carico del tubo gastroenterico: come detto sopra a proposito dell’ aspirina, tale evenienza è particolarmente temibile nel paziente anziano. Per tale motivo, l’ impiego di prasugrel nei pazienti anziani, per lo meno alla dose di 10 mg impiegata nello studio TRITON-TIMI 38, non è attualmente raccomandata, e l’ indicazione ad impiegare dosi di 5 mg, laddove ritenuto utile, non è basata su evidenze cliniche sperimentali. Complessivamente per quanto riguarda prasugrel, si ha a che fare con un farmaco con spettro d’ azione simile, ma più potente e prevedibile (minore variabilità d’ effetto in relazione ad assetto genetico degli enzimi metabolici), rispetto a clopidogrel, essendo pressoché lo stesso il metabolita attivo. Ticagrelor è un inibitore del recettore P2Y12 completamente innovativo, non essendo una tienopiridina (a differenza di clopidogrel e prasugrel), non essendo un pro farmaco (pur avendo metaboliti attivi), ed avendo effetti off-target di ignoto significato clinico, ma associati ad effetti collaterali, peraltro non gravi. Rispetto a clopidogrel, nello studio PLATO ticagrelor ha mostrato una riduzione del 16% del rischio di eventi ischemici nel follow up in un ampio spettro di pazienti con SCA, a fronte di un aumento del 25% dei sanguinamenti maggiori non associati a bypass aortocoronarico. Nei pazienti di età >75 anni, il beneficio in termini di eventi ischemici è stato relativamente minore (pur se statisticamente in linea) di quello osservato nei pazienti più giovani, anche in questo caso con un eccesso di eventi emorragici e in particolare un disturbante (+60%) eccesso di ictus. I dati finora pubblicati con prasugrel e ticagrelor in confronto a clopidogrel nei pazienti anziani sono molto simili sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con la differenza di un eccesso di sanguinamento gastroenterico fatale con prasugrel a fronte di un eccesso di sanguinamento cerebrale fatale osservato con ticagrelor. L’ eccesso di sanguinamento cerebrale fatale osservato con ticagrelor è inatteso, inusuale con i farmaci antipiastrinici, e rimane da essere valutato attentamente negli studi di grandi proporzioni attualmente in corso. Parimenti inattesa è la significativa riduzione di mortalità totale osservata con ticagrelor nella popolazione generale e anche in quella anziana, in cui l’ effetto pare particolarmente importante, ancorchè non spiegato (9.8% vs 12.4%, HR aggiustato 0.77, IC 95% 0.60-0.98). Per quanto riguarda gli anti GPIIb/IIIa, dati di metanalisi dimostrano una ridotta efficacia di questi farmaci nei pazienti anziani con SCA, con un importante eccesso di sanguinamenti. In termini di efficacia, le ragioni di questa tendenza possono risiedere nell’ intervento tipicamente più tardivo nel paziente anziano con STEMI (e quindi nella minore efficacia anti trombotica degli anti GPIIb/IIIa), come pure nella relativamente minore probabilità di andare incontro a PCI dopo utilizzo upstream nella SCANSTE, eventualità a cui è legato il beneficio degli anti GPIIb/IIIa. Tuttavia, anche i dati dello studio ISAR-REACT 2, che hanno mostrato un chiaro beneficio dall’ impiego di abciximab in pazienti con SCANSTE sottoposti a PCI, limitano questa efficacia ai pazienti di età inferiore ai 70 anni. Va tuttavia inoltre ricordato come, tra le variabili che influenzano il risultato della rivascolarizzazione meccanica negli anziani, un ruolo rilevante abbia l’esperienza del centro in cui viene trattato il paziente, determinata dal numero di procedure eseguite in pazienti con sindromi coronariche acute.In conclusione, le informazioni disponibili sugli anziani trattati con PTCA sono assai carenti. L’età rimane un fattore prognostico negativo, anche per la presenza di co-morbilità cardiache ed extracardiache.La valutazione della miglior strategia per ottenere una riperfusione efficace (angioplastica primaria immediata, trasferimento per eseguire la riperfusione meccanica anche quando è previsto un ritardato arrivo al centro di interventistica, trombolisi) così come l’uso di terapie aggiuntive in questi pazienti richiede studi prospettici randomizzati di ampie dimensioni specificatamente strutturati. Dai dati disponibili il vantaggio della riperfusione meccanica sembra evidente soprattutto nei pazienti con shock cardiogeno
|