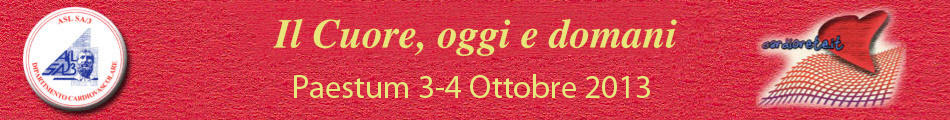
|
5 VALVULOPATIE
● La valvulopatia mitralica nell’Anziano e nel Grande Anziano: epidemiologia e clinica
● La valvulopatia mitralica nell’Anziano e nel Grande Anziano: problematiche cardiochirurgiche
● La valvulopatia aortica nell’Anziano e nel Grande Anziano: epidemiologia e clinica
● La valvulopatia aortica nell’Anziano e nel Grande Anziano: problematiche cardiochirurgiche
La valvulopatia mitralica nell’Anziano e nel Grande Anziano: epidemiologia e clinica
Cesare Baldi, Marco Di Maio, Maria Vincenza Polito Elisabetta Bellino,Costantina Prota Angelo Silverio, Pietro Giudice. S. C. Cardiologia Interventistica-EmodinamicaDipartimento Medico-Chirurgico di CardiologiaA.O.U.” S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” - Salerno
I progressi della medicina e delle condizioni socio-sanitarie hanno determinato un incremento del numero di persone appartenenti alle fasce di età più avanzata. In Italia, le stime ISTAT prevedono un aumento della popolazione al di sopra degli 80 anni dai 3.6 milioni del 2011 ai 9.3 milioni nel 2065. L’invecchiamento della popolazione comporta una maggiore prevalenza di cardiopatie strutturali, di ipertensione arteriosa, di aritmie (fibrillazione atriale soprattutto), di malattia aterosclerotica. Tra le cardiopatie strutturali ad alta prevalenza in età avanzata, l’insufficienza mitralica (IM) occupa uno spazio epidemiologico rilevante e mostra un crescente impatto clinico per la frequente evoluzione verso la disfunzione ventricolare sinistra ed il conseguente quadro di scompenso cardiaco cronico (SCC); in tarda età la ridotta distensibilità del ventricolo sinistro è relativamente comune ed è in grado da sola di condizionare la comparsa dei segni dello SC diastolico che sopra i 70 anni può arrivare a rappresentare il 50% di tutti i pazienti con scompenso; appaiono inevitabili pertanto le conseguenze negative, in termini di compromissione della qualità della vita ed in ultima istanza di scompenso e di morte, prodotte nel paziente anziano dal sovraccarico cronico di volume della IM severa in una condizione fisiopatologica già caratterizzata da un impoverimento della popolazione di miocitifunzionanti e da uno sbilanciamento nella struttura cardiaca verso lasua impalcatura fibrosa.
ü Quali peculiarità del paziente anziano? Spesso, in tarda età, la patologia del cuore si presenta in associazione con altre malattie che hanno colpito altri distretti nell’ambito di un contesto di grande fragilità globale; un atto terapeutico complesso e ad alto costo in una persona molto anziana in scompenso per IM severa , con limitata aspettativa di vita, richiede sempre una valutazione difficile e ponderata. Questo scenario clinico impone un approccio multidisciplinare integrato, in grado di effettuare scelte personalizzate: diversi specialisti devono essere coinvolti e condividere le fasi della diagnosi, della valutazione, del processo decisionale e del trattamento.Tutto questo si può realizzare a condizione che cardiologo clinico, cardiochirurgo, cardiologo interventista e geriatra siano abituati a dialogare all’interno di un gruppo multidisciplinare (Heart Team) per scegliere l’ opzione strategica più idonea alla soluzione del problema del paziente. Nella popolazione anziana il peso delle malattie croniche appare nettamente aumentato, ed il loro impatto clinico tende a moltiplicarsi perché spesso coesistono accanto alla patologia dominante in quadri definiti di comorbosità o multimorbosità. Il termine di comorbosità indica “l’esistenza o la comparsa di ogni distinta entità clinica aggiuntiva durante il decorso di una specifica malattia (malattia indice) per la quale il paziente sia seguito”. La comorbosità non ha relazione eziologica con la diagnosi primaria, in ciò distinguendosi dalle complicanze, che della malattia indice o del suo trattamento sono sequele. Più di recente, è stato proposto il concetto di multimorbosità, ovvero “la concomitanza di più malattie acute e croniche in un soggetto”, in cui scompare il riferimento alla malattia indice: in effetti, questa definizione meglio descrive quanto comunemente si osserva nel paziente anziano, in cui spesso il clinico non riesce ad individuare una patologia dominante e si trova a fronteggiare più forme morbose allo stesso tempo. Comorbosità e multimorbosità interferiscono con tutti i momenti dell’approccio clinico, a partire da quello diagnostico, e rappresentano dunque elementi centrali della complessità delpaziente anziano; la contemporanea presenza di molteplici condizioni morbose rende spesso atipica la manifestazione di esordio di ogni singola malattia e, come tale, rappresenta fonte comune di errori diagnostici. Ancora, co- e multimorbosità rendono assai complesso l’approccio terapeutico, che nell’anziano ben di rado può aderire completamente alla medicina basata sull’evidenza e alle sue linee guida, in genere sviluppate in soggetti più giovani e senza sostanziali patologie associate. Purtuttavia non è possibile cogliere appieno la complessità del paziente anziano e del suo stato di salute globale senza considerare gli aspetti cognitivi e quelli funzionali. Nell’approccio all’anziano, la valutazione dello stato funzionale, premessa all’adozione di interventi finalizzati al mantenimento e al recupero della massima autonomia, è parte essenziale e compito specifico della valutazione multidimensionale geriatrica. Mentre nell’adulto la disabilità è espressa dall’incapacità lavorativa, nell’anziano il suo riconoscimento coincide con l’incapacità di attendere autonomamente ad attività di base della vita quotidiana (Basic Activities of Daily Living, BADL), quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, mantenere la continenza, usare la toilette, compiere trasferimenti in ambito domestico (anche con l’utilizzazione di ausili); non sorprende che, se il grado di disabilità esprime in modo sintetico l’effetto combinato delle variazioni indotte dall’invecchiamento “normale” e dalle malattie associate la misura della disabilità migliora la capacità di formulare la prognosi, indipendentemente dalle singole diagnosi cliniche. La valutazione funzionale ha un ruolo centrale per identificare gli anziani disabili nelle attività di base della vita quotidiana e quelli fragili. La fragilità è espressione del progressivo esaurimento delle riserve funzionali e si traduce nella progressiva inefficienza dei meccanismi di mantenimento dell’omeostasi biologica e si manifesta con la riduzione della performance fisico-funzionale. Malattie acute e croniche possono contribuire alla fragilità riducendo le riserve funzionali e portando alla luce deficit fino a quel momento compensati. In conclusione, l’approccio all’anziano, che spesso è caratterizzato da un intreccio di multimorbosità, disabilitàe fragilità, è particolarmente complesso perchènon può limitarsi alla valutazione ed al trattamento dellasola malattia d’organo, ma deve procedere con una prospettiva di valutazione globale.
ü Quale peculiarità della IM severa nella popolazione anziana? In una indagine effettuata per misurare il “carico” delle valvulopatie nella vita reale, Nkomo ha utilizzato sia i dati provenienti da studi di popolazione, generati con l’ esecuzione di esami ecocardiografici sistematici su campioni della popolazione generale, sia dati provenienti da studi di comunità, raccolti invece a partire da esami ecocardiografici effettuati per la formulazione di diagnosi in pazienti che presentavano un qualche sospetto clinico. E’ stato dimostrato che la prevalenza delle valvulopatie è fortemente legata all’avanzare dell’età, con un andamento della relazione non lineare ma regolarmente incrementale sevalutata per fasce di età progressivamente crescenti di 10 anni ciascuna; che,tra le valvulopatie, la IM mostra il valore di prevalenza maggiore rispetto alle altre; che non tutte le valvulopatie vengono riconosciute e conseguentemente trattate, come viene dimostrato dalla differenza significativa del loro riconoscimento tra gli studi di popolazione e quelli di comunità; che quella meno riconosciuta è proprio la IM rispetto alla stenosi aortica, verosimilmente per il minore clamore della sua presentazione clinica; che, infine, è stata documentatanel sesso femminile una riduzione nel riconoscimento della IM per una ricorso all’indagine ecocardiografica nelle pazienti anziane meno frequente rispetto ai pazienti maschi. All’interno dell’Euro HeartSurveystudy,Mirabel ha condotto una indagine circoscritta alla sottopopolazione di 396 pazienti con IM severa e sintomatica; nel 49% dei casi, i pazienti non vennero sottoposti ad intervento chirurgico e la analisi multivariata documentò che i predittori più potenti della decisione di rifiutare l’opzione chirurgica risultarono l’età avanzata, la presenza di comorbidità e il valore di FE. Anche i pazienti di età compresa tra i 70 e gli 80 anni sono stati rifiutati alla chirurgia sebbene il rischio del ricorso all’intervento di correzione in questa fascia di età non apparisse proibitivo; in realtà sia la crescente aspettativa di vita nei paesi industrializzati sia la valutazione comparativa degli esiti in storia naturale di questi pazienti rispetto a quelli avviati alla correzione chirurgica non giustificano la decisione di non operare questi pazienti, in tale fascia. La presenza di una pesante comorbidità, attestata da un indice di Charlson elevato, appare invece coerente con la decisione di rifiuto della correzione, perché un alto indice mostra un impatto sfavorevole sulla aspettativa di vita e si associa ad un elevato rischio operatorio. La soluzione di una insufficienza mitralica severa associata a sintomi rimane la chirurgia, ma le condizioni in cui essa può essere realizzata anche in una popolazione anziana senza un elevato rischio operatorio non sono poi così frequenti; in questa ottica appare cruciale la adeguata valutazione del rischio operatorio attraverso l’uso di score di rischio che proprio nella popolazione anziana rimane esposto a grossi problemiinterpretativi. I due score più utilizzati fino ad ora sono l’EuroSCORE logistico e l’STS score. L’EuroSCORE logistico, leggermente più specifico per la patologia coronarica, tuttavia è stato ripetutamente dimostrato che nei pazienti più compromessi tende a sovrastimare il rischio fino a 3 volte. L’STS score, in confronto, si basa su di una casistica più ampia, ed è più preciso nella patologia valvolare e nei pazienti ad alto rischio. Entrambiquesti score hanno limiti importanti, quando vengono applicati nel singolo paziente molto anziano:il rischio non è specifico per la fascia di età (essendo ricavatoda esperienze cliniche riguardanti prevalentemente pazientipiù giovani) e non è stratificato per le pratiche interventistichee per le diverse patologie; infine, molte variabili non sono considerate(aorta a porcellana, funzionalità epatica, irradiazione,fragilità, ecc.). Questi score di rischio garantiscono una capacità discriminativa relativamente buona, cioè una adeguata capacità nel distinguere lo strato dei pazienti a basso rischio da quello ad alto rischio, ma non mostrano una pari accuratezza di valutazione della mortalità operatoria nel singolo paziente per una insufficiente capacità calibrativa, dovuta alle differenze ancora significative che sussistono tra il rischio atteso e quello osservato, evidenti soprattutto per l’EuroSCORE logistico che mostra di sovrastimare il rischio operatorio nel paziente ad alto rischio. Queste considerazioni riducono la affidabilità che può essere riservata ad un singolo numero generato dallo score e da utilizzare nel processo decisionale,e pongono il problema di incrementare la performance predittiva degli score di rischio attraverso ripetute procedure di calibrazioni e di validazione (è il caso dell’EuroSCORE II per l’ EuroSCORE logistico), attraverso la integrazione di nuove variabili che nella popolazione anziana vadano a valutarne le capacità funzionali e cognitive e lo stato di fragilità fino alla costruzione di score di rischio specifici per il sottogruppo della popolazione anziana. In età avanzata esistono fondamentalmente due tipi di IM di grado severo in grado di provocare un quadro di SCC conclamato: l’insufficienza primaria di tipo degenerativo, che si realizza nella condizione organica del prolasso mitralico complicato, meno frequente, e l’insufficienza secondaria di tipo funzionale, che si realizza come risultato del rimodellamento ventricolare tipico della disfunzione ventricolare postischemica o della cardiomiopatia dilatativa idiopatica, che è la forma più frequente. La correzione chirurgica della IM degenerativo-organica rimane la soluzione più appropriata e la opzione riparativa, quando è fattibile, si presenta associata a risultatimigliori della opzione sostitutiva. Le prospettive della correzione chirurgica nella IM funzionale appaiono, invece, ancora controverse in età avanzata: la mortalità operatoria è più elevata che nella forma primaria e la prognosi a lungo termine è gravata da una sopravvivenza minore per il peso esercitato da una maggiore comorbidità. In realtà questo della chirurgia della IM funzionale rimane un terreno povero di indicazioni robuste quando vengano valutate secondo le prospettive della evidencebased medicine: il solo studio randomizzato che ha confrontato la rivascolarizzazione da sola nei confronti della rivascolarizzazione combinata con la riparazione mitralica ha dimostrato che l’esecuzione delle tecniche riparative migliora gli end point surrogati della classe funzionale e della FE ma non è stato disegnato per valutare il loro impatto sulla sopravvivenza; la maggior parte degli studi non è stata in grado di dimostrare un reale miglioramento della prognosi a lungo termine dopo la correzione chirurgica della IM funzionale; infine non esistono studi randomizzati di confronto dei risultati a lungo termine della riparazione verso la sostituzione valvolare, anche se una metanalisi effettuata su studi retrospettivi suggerisce risultati migliori, in termine di sopravvivenza a lungo termine, della chirurgia riparativa rispetto alla chirurgia sostitutiva. I limiti della correzione chirurgica della IM funzionale nel paziente anziano hanno promosso lo sviluppo di tecniche alternative, in particolare nel settore della riparazione percutanea. Il sistema di impianto MitraClip, un dispositivo applicabile per via transcatetere e derivato dalla tecnica chirurgica di riparazione edge to edge, è stato oggetto di uno studio randomizzato, l’EVEREST II trial(Endovascular Valve Edge-to-EdgeREpairSTudy) che ha dimostrato, in una popolazione di pazienti con una quota di IM funzionale pari ad 1/3 del totale, risultati soddisfacenti sia in termini di sicurezza che in termini di efficacia, con una incidenza di successo procedurale, definito in accordo con la presenza di un rigurgito residuo ≤2+, di circa il 75%. Grazie alla legittimazione all’uso in clinica basata sui dati EVEREST, negli ultimi 3 anni sono stati pubblicati numerosi registri condotti in Europa su popolazioni di pazienti noneligibili per lo studio EVEREST, o per evidente inoperabilità o per alto rischio chirurgico, e che presentavano caratteristiche relativamente simili per età > 70 anni, valori di FE< 35% e di EuroSCORE logistico > 30; i risultati di questi studi, in parte prospettici in parte retrospettivi, documentano, nel paziente anziano e grande anziano con IM prevalentemente funzionale, una buona efficacia nel medio termine,in particolare per miglioramento dei sintomi, della qualità di vita, e della funzione VSin a fronte di un bassissimo rischio operatorio (mortalità intraospedaliera 2%, a 12 mesi 12%). Al momento attuale sono in corso due studi relativamente simili con disegno prospettico, randomizzato, multicentrico, progettati, il RESHAPE in Europa ed il COAPT negli Stati Uniti, con l’obiettivo di stabilirel’efficacia e la sicurezza della MitraClip nei confronti della terapia chirurgica standard in pazienti sintomatici affetti da insufficienza mitralicafunzionale e disfunzione ventricolare sinistra.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al.;Joint Task Force on the Management ofValvular Heart Disease of the European Societyof Cardiology (ESC); European Associationfor Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).Guidelines on the management of valvularheart disease (version 2012). Eur Heart J2012;33:2451-96. 2. van den Akker M, Buntinx F, Metsemakers JF, Roos S, Knottnerus JA. Multi morbidity in general practice: prevalence, incidence, and determinants of co-occurring chronic and recurrent diseases. J ClinEpidemiol 1998;51:367-75. 3. Applegate WB, Blass JP, Williams TF. Instruments for the functional assessment of older patients. N Engl J Med 1990;322:1207-14. 4. Ferrucci L, Guralnik JM, Baroni A, Tesi G, Antonini E, Marchionni N. Value of combined assessment of physical health and functional status in community-dwelling aged: a prospective study in Florence, Italy. J Gerontol 1991;46:M52-6. 5. Makary MA, Segev DL, Pronovost PJ, et al. Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients. J Am CollSurg 2010;210: 901-8. 6. Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, Gottdiener S, Scott CG, Enriquez-Sarano M. Burden of valvular heart diseases: a populationbased study.Lancet2006;368:1005-11. 7. Mirabel M, Iung B, Baron G, et al. What are the characteristics of patients with severe, symptomatic, mitral regurgitation who are denied surgery? Eur Heart J 2007;28:1358-65. 8. Chikwe J, Goldstone AB, Passage J, et al. A propensity score-adjusted retrospective comparison of early and mid-term results of mitral valve repair versus replacement in octogenarians. Eur Heart J 2011; 32:618-26. 9. Vassileva CM, Boley T, Markwell S, Hazelrigg S. Meta-analysis of short-term and long-term survival following repair versus replacement for ischemic mitral regurgitation. Eur J CardiothoracSurg 2011;39: 295-303. 10. Whitlow PL, Feldman T, Pedersen WR, etal.; EVEREST II Investigators. Acute and 12-month results with catheter-based mitralvalve leaflet repair: the EVEREST II (Endovascular Valve Edge-to-Edge Repair) High RiskStudy. J Am CollCardiol 2012;59:130-9. 11. Baldus S, Schillinger W, Franzen O, et al.; German Transcatheter Mitral Valve Interventions (TRAMI) Investigators. MitraClip therapy in daily clinical practice: initial results from the German Transcatheter Mitral Valve Interventions (TRAMI) registry. Eur J HeartFail 2012;14:1050-5.
|