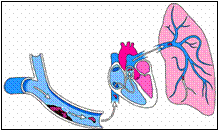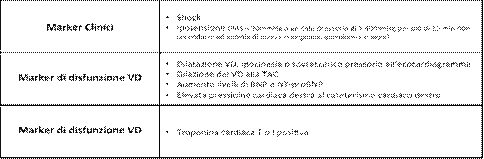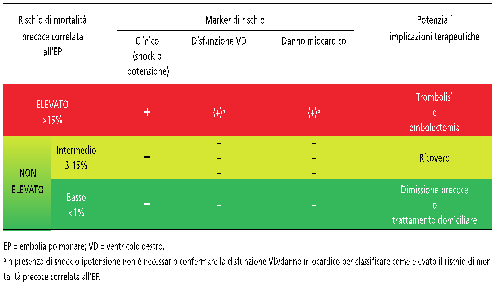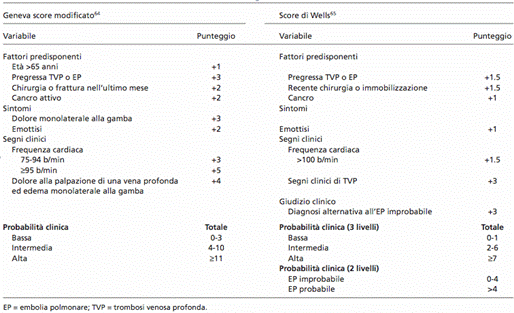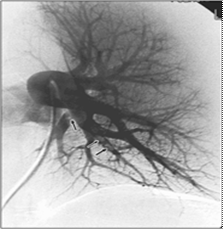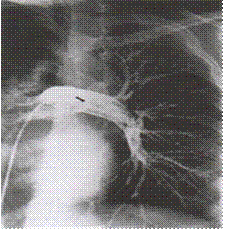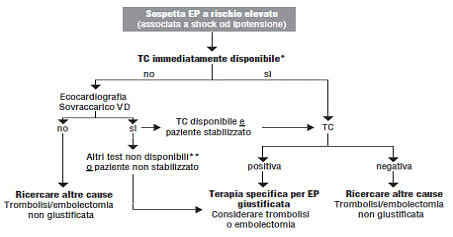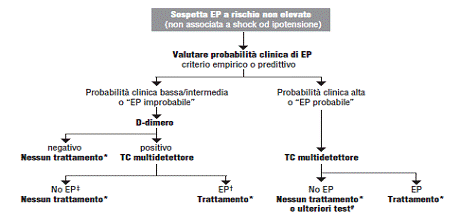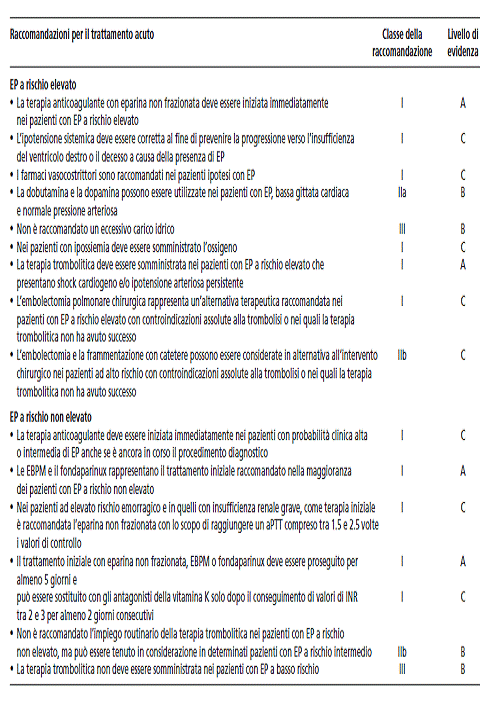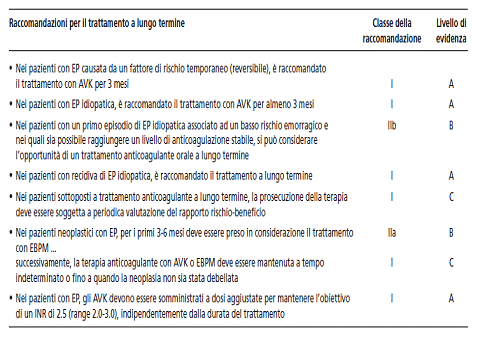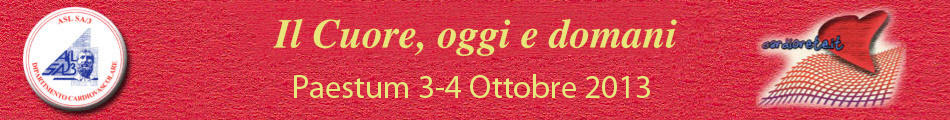
|
L’ Embolia Polmonare nell’Anziano e nel Grande Anziano
Antonio Aloia, Filippo Gatto, Onorina Rizzo, Giovanni Gregorio U.O. UTIC Cardiologia, Ospedale S. Luca, Vallo della Lucania, ASL Salerno
L’Embolia Polmonare è un’emergenza cardiovascolare dovuta ad un’ostruzione del letto vascolare polmonare causata da un embolo o da altro materiale che raggiunge i vasi polmonari attraverso il sistema circolatorio, questo stato di cose può indurre un grave scompenso acuto del ventricolo destro.
E’ la terza causa di morte dopo l’infarto miocardico e lo stroke. Rappresenta l’1% delle cause di morte intraospedaliera, con un’incidenza stimata di un caso per mille nella popolazione generale non stratificata per età. L’incidenza raddoppia ogni decade: è rara prima dei 40 anni, sicuramente più frequente sopra i 65 anni, interessa più frequentemente il sesso maschile che il femminile, ed è solo lievemente inferiore a quella dello stroke. Negli Stati Uniti, si ritiene che l’embolia polmonare e la sua causa principale, la trombosi venosa profonda, siano responsabili di 110 000 ricoveri ospedalieri ogni anno, nei pazienti di età > 65 anni. I tassi annuali di incidenza, per 1000 persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni, sono rispettivamente di 1,3 per l’embolia polmonare e di 1,8 per la trombosi venosa profonda. Queste percentuali aumentano di pari passo con l’età. Secondo stime anglosassoni, confermate da recenti italiane, l’ 1% della popolazione ospedaliera presenta una manifestazione di tromboembolismo venoso. L’incidenza totale per ogni età della malattia tromboembolica negli Stati Uniti è stata stimata in circa 600000-750000 casi l’anno con 200000-300000 ricoveri ospedalieri, mentre in Italia si stima che ogni anno si verifichino 60.000 nuovi casi. Un terzo degli episodi è fatale e la quasi totalità dei decessi avviene precocemente entro 1 ora dall’esordio dei sintomi. L’aumento dell’età media della popolazione ed il più elevato numero di pazienti che hanno una prolungata sopravvivenza in corso di malattie, neoplastiche, cardiache o polmonari, farà sì che nel prossimo futuro l’incidenza di tale severa patologia possa aumentare. Nell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania sono state ricoverarti dal 1 gennaio 2010 al 31 maggio 2013, 64 pazienti, così distribuiti: 16 nel 2010, 15 nel 2011, 22 nel 2012 e 11 fino al 31 maggio 2013. Dei 64 pazienti 42 erano femmine e 22 maschi, con un’età media di 72 anni. I pazienti con età maggiore di 65 anni sono stati 47. I ricoveri sono stati effettuati nelle seguenti U.O. : CRTI 10, UTIC 30, Medicina Generale 2, Medicina Urgenza 16, Ostetricia 1, Chirurgia d’Urgenza 2, Chirurgia Vascolare 2, Urologia 1. PRESENTAZIONE CLINICA Poiché i sintomi e i segni dell’embolia polmonare sono aspecifici, e la presentazione clinica può essere variabile, la malattia può essere sovrastimata o sottostimata, in particolare negli anziani. Nei pazienti affetti da malattie cardiache e respiratorie, il rischio di misconoscere questa condizione è particolarmente elevato. Per tale ragione una valutazione clinica attenta e accurata nel paziente con sospetto di embolia polmonare, in particolar modo se sono presenti fattori di rischio, può portare ad una corretta diagnosi. La sintomatologia è estremamente variabile ed è la giusta conseguenza dell’entità dell’impegno vascolare. Nelle forme non massive i sintomi più frequenti sono rappresentati dalla dispnea, dal dolore toracico, mentre la sincope è più frequente nelle forme massive. Talora il paziente può lamentare anche dolore di tipo pleurico, causato da infarto polmonare o da embolia dei rami distali con conseguente irritazione pleurica. Una tachicardia inspiegata, l’improvvisa comparsa di tosse secca, specie notturna, possono essere gli unici elementi clinici che possono far orientare verso una microembolizzazione polmonare. L’interessamento di vasi di maggior calibro si manifesta invece con la comparsa di dispnea grave ed improvvisa, mentre un dolore toracico simil anginoso, da verosimile ischemia del ventricolo destro, è spesso espressione di una maggiore compromissione emodinamica. Un episodio sincopale o una grave ipotensione fino allo shock sono infine espressione di una embolia polmonare massiva e si associano a segni e sintomi di ipoperfusione quali cianosi periferica e/o oliguria. La tabella 1 indica sintenticamente i principali markers per la stratificazione del rischio nell’ embolia polmonare Tabella I
L’immediata valutazione clinica al capezzale del paziente della presenza o meno dei markers clinici consente di stratificare il rischio in elevato e non elevato
Criteri clinici predittivi di embolia polmonare: score di Wells e il Geneva modificato
DIAGNOSI La diagnosi di embolia polmonare è difficile. Per poter fare diagnosi di embolia polmonare bisogna innanzitutto sospettarla, ma dal momento che i segni e i sintomi sono aspecifici è necessario avvalersi di una serie di dati strumentali. Elettrocardiogramma: in genere, i reperti elettrocardiografici sono aspecifici; il 33% dei pazienti con embolia polmonare ha un ECG normale; è importante per escludere la presenza di IMA e pericardite, può essere normale nelle forme sub-massive. Le anomalie più frequenti sono: tachicardia sinusale persistente; presenza di S1-Q3 con ST sottoslivellato in D2 (prominenza dell’onda S nella derivazione I, dell’onda Q nella derivazione III e inversione dell’onda T nella derivazione III) suggerisce un’embolia polmonare, questo quadro di sovraccarico delle sezioni di destra ed eventuale ipertrofia è accompagnato, in genere, da alte onde R di voltaggio decrescente da V1 a V4 con sottoslivellamento del tratto ST ed onde T negative; onde P polmonari; BBdx completo o incompleto di recente insorgenza; contrazioni premature atriali e/o ventricolari, fibrillazione atriale parossistica di recente insorgenza, ipertrofia con sovraccarico ventricolare destro Emogasanalisi: l’embolia polmonare spesso provoca un’ipossiemia arteriosa, dovuta alla riduzione del rapporto ventilazione/perfusione che si instaura in seguito alla chiusura delle vie aeree e alla broncocostrizione nei segmenti polmonari adiacenti all’embolo. Vi contribuiscono anche gli shunt ematici intrapolmonari e la riduzione della tensione di ossigeno nel sangue venoso misto. Raramente, si può verificare uno shunt ematico destro-sinistro attraverso un forame ovale pervio, causato dall’ipertensione atriale destra conseguente a un’embolia polmonare massiva. Il riscontro di un gradiente alveolo-arterioso elevato è aspecifico nella popolazione anziana e non viene utilizzato quasi mai per la diagnosi di embolia polmonare acuta. D’altro canto, un gradiente alveolo-arterioso di ossigeno normale non consente di escludere la diagnosi. Pertanto all’emogasanalisi si evidenzia un' ipossiemia (PaO2 < 80 mmHg) con un' ipocapnia (PaCO2 < 40 mmHg) e tendenza all' alcalosi respiratoria per l' iperventilazione del paziente. L’ipossiemia è un reperto molto frequente in corso di embolia polmonare, ma circa il 20% dei soggetti con EP (specie quelli giovani) presentano una normale pressione parziale di ossigeno. Rx torace: è utile per escludere la presenza di altre patologie: pneumotorace, polmonite, edema polmonare acuto, atelettasia. Nell' embolia polmonare può essere normale; solo in alcuni casi senza infarto polmonare può fornire elementi utili: improvvisa interruzione dell' ombra di un ramo arterioso con iperdiafania della relativa zona polmonare, dilatazione del tronco dell' arteria polmonare e del ventricolo destro con possibile ingrossamento ilare, atelettasia basale a piastra. In caso d'infarto polmonare non prima di 24-36 ore dal fatto acuto può mostrare opacità rotondeggianti, lineari, di rado tipicamente triangolari, localizzate più frequentemente nei lobi inferiori soprattutto a destra. Talora le opacità si accompagnano ad un versamento pleurico che può mascherare l' infarto (più frequente a destra) o l' innalzamento dell' emidiaframma omolaterale. Le immagini dell'infarto persistono per 8-12 settimane, a differenza di quelle dell’emorragia polmonare che scompaiono dopo una settimana, e poi si riducono a lievi strie fibrotiche o scompaiono del tutto. Altre caratteristiche compatibili con EP sono il versamento pleurico (38%, con la caratteristica di essere piccolo, spesso interessante solo l’angolo costo-frenico), l’atelettasia subsegmentaria, l’infiltrato polmonare; raramente si osserva la oligoemia ( Westermarkís sign. 11 %), l’oligoemia regionale con dallo stesso lato lo slargamento dell’arteria polmonare (Fleischerís sign). Ecocardiogramma: può risultare di notevole utilità nella diagnosi di embolia polmonare. Con l’ecocardiogramma potremmo trovare: un ingrandimento del ventricolo destro ed ipocinesia della parete libera; un aumentato rapporto RV/LV (causato dal bulging del setto nella cavità ventricolare sinistra); un anormale movimento diastolico del setto interventricolare (SIV) verso la cavità ventricolare sinistra (sovraccarico di pressione acuto del ventricolo destro) od un movimento sistolico paradosso del SIV (sovraccarico di volume acuto del ventricolo destro) reversibili col migliorare delle condizioni cliniche; dilatazione dell'arteria polmonare; dilatazione e mancato collasso inspiratorio della vena cava inferiore (segno che precocemente si normalizza col miglioramento delle condizioni cliniche), un aumentato rigurgito tricuspidalico (di solito a velocità intorno a 3-3,5 m/sec) significativamente correlato con l'aumento delle pressioni in arteria polmonare. L’entità della compromissione funzionale del ventricolo destro risulta il fattore prognostico dotato di maggior potere predittivo di mortalità a breve termine. Nessuno dei reperti ecocardiografici appare caratterizzato da elevata sensibilità e solo la diretta visualizzazione dell’embolo a livello dell’arteria polmonare, con l’ecocardiografia transesofagea, consente di fare diagnosi di certezza di embolia polmonare. In pazienti con shock o ipotensione l’assenza di segni ecocardiografici di sovraccarico o disfunzione del VD consente effettivamente di escludere l’embolia polmonare quale causa di instabilità emodinamica. Per quanto riguarda tutte le situazioni intermedie (che costituiscono in realtà la maggior parte delle forme di embolia polmonare), il ruolo dell’ecocardiografia nella diagnostica dell’embolia polmonare merita di essere pienamente valutato, soprattutto nell’ambito di studi clinici prospettici, in particolare al fine di identificare pazienti con embolia polmonare che possano beneficiare di un trattamento trombolitico piuttosto che della terapia eparinica nonostante l’assenza di ipotensione sistemica o di shock. Dosaggio D-dimero: il D-Dimero (DD), è un prodotto di degrado della fibrina; esprime la attivazione della trombina e della fibrinolisi. Può essere misurato con metodi quantitativi (ELISA) o serniquantitativi (latex e simili, utilizzando monoclonali). Mentre i test quantitativi in ELISA hanno bisogno di 5-6 ore per poter arrivare al risultato, i test semiquantitativi richiedono solo 20-30 minuti. Il DD ha un valore predittivo negativo del 98% contro però una specificità del 35%, legata al fatto che la coagulazione può essere attivata da molte condizioni come il cancro, infezioni, malattie epatiche, scompenso cardiaco, interventi chirurgici, malattie infiammatorie. Numerosi sono i motivi che rendono problematici il dosaggio del DD e la sua interpretazione clinica probabilistica nei pazienti che si presentano con sintomi, nei pazienti che si presentano asintomatici per TVP non è considerato utile dosare il DD in quanto: l) la presenza di altre malattie attivanti la coagulazione rendono il DD positivo, 2) dipende dal tempo di comparsa dei sintomi, perchÈ anche se ci troviamo di fronte ad un paziente che non presenta patologia concomitante dopo 10 gg dall’evento trombizzante il DD risulta a1 95% negativo, pur in presenza di malattia. Circa il 60% dei pazienti di età < 50 anni con sospetta diagnosi di embolia polmonare ha un’alterazione dei valori di d-dimero. Per contro, il 92% dei pazienti di età > 70 anni ha una concentrazione di d-dimero alterata, probabilmente a causa di patologie concomitanti. Di conseguenza, se il test del d-dimero è negativo, la presenza di una trombosi venosa profonda o di un’embolia polmonare è improbabile, ma il riscontro di un test positivo non è di alcuna utilità nei pazienti > 70 anni. Pertanto un test del D-dimero negativo con un metodo altamente specifico consente di escludere con sicurezza la presenza di embolia polmonare. L'eco color Doppler venoso, deve essere subito disponibile per non rallentare il processo di conferma diagnostica, può documentare una TVP dell' asse femoro-iliaco, sensibilità 93%, specificità 98%.
La scintigrafia polmonare ventilatoria e perfusionale, La scintigrafia polmonare ha un ruolo chiave nella diagnostica dellíembolia polmonare, essendo un esame non invasivo, ampiamente valutato in grandi trial clinici. talora di difficile esecuzione la ventilatoria per le condizioni critiche del paziente che non permettono una corretta esecuzione dell'indagine e per le difficoltà tecniche legate all' indagine stessa. Una scintigrafia ad alta probabilità di embolia (difetti di perfusione con ventilazione normale) non necessita di angiografia per la conferma diagnostica. Una scintigrafia normale esclude la diagnosi di embolia. Una scintigrafia a probabilità intermedia o bassa necessità di controllo angiografico.
La TC spirale del torace con m.d.c. permette di identificare embolie anche nelle arterie polmonari di IV ordine. E' una metodica di rapida esecuzione che si va sempre più diffondendo nella diagnostica della TEP.
L' angiografia polmonare, meglio se digitale a sottrazione d'immagini, è una flebografia ascendente con mezzo di contrasto per lo studio della cava inferiore e della vascolarizzazione polmonare. E' il gold standard per la diagnosi di embolia polmonare. Le indicazioni riguardano: 1) pazienti con scintigrafia polmonare scarsamente diagnostica ma con quadro clinico altamente sospetto, 2) pazienti in cui sia indicato il trattamento trombolitico o l' embolectomia, 3) pazienti in cui sia necessario confermare la diagnosi per un notevole rischio emorragico legato all'impiego del trattamento anticoagulante per via sistemica.
T C spirale polmonare: è una metodica eccellente per l’identificazione degli emboli polmonari nelle arterie polmonari di calibro maggiore (sensibilità, 94%; specificità, 94%; valore predittivo positivo, 93%; valore predittivo negativo, 95%). La TC spirale Ë in grado di riconoscere gli emboli a livello dei tronchi polmonari ed a livello delle arterie segmentarie che vengono evidenziati come difetti di riempimento. Recenti affinamenti nella tecnica può portare la risoluzione anche a livello sub-segmentario. La percentuale degli emboli sub-segmentari Tale tecnica è sicuramente meno complessa della angiografia polmonare e sicuramente di più rapida esecuzione. La sensibilità e specificità per i trombi segmentali e centrali è alta (92%)
STRATEGIE DIAGNOSTICHE
Embolia Polmonare a Rischio Elevato
Embolia Polmonare a Rischio Non Elevato
TERAPIA
BIBLIOGRAFIA
Linee guida pere la diagnosi e il trattamento dell’embolia polmonare – G. Italiano Cardiologia 2009; 10 (5); 303 – 347
Task Force on Pulmary Embolism, European Society of Cardiology Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolis.. Eur Heart J 2000; 21: 1301-36
Braunwald Trattato di Medicina Cardiovascolare Piccin Editore
|