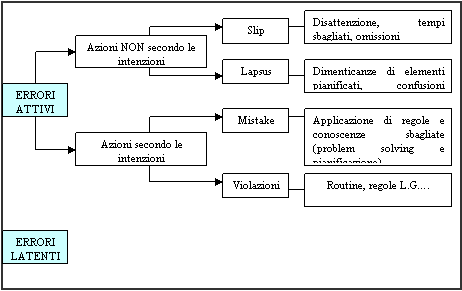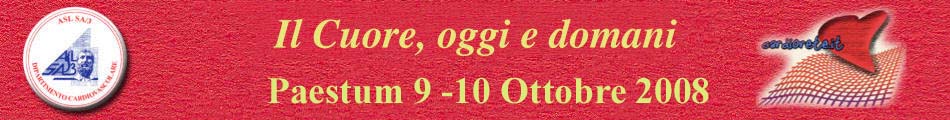
|
NURSING E RISCHIO CLINICO
Elisabetta Simonetti Area Infermieristica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Ancona
Introduzione Il tema del rischio clinico si pone come argomento di rilevante severità che interessa vari settori della sanità ed ha un forte impatto sociale. Il sistema sanitario è un sistema complesso per diverse variabili coinvolte, quali la specificità dei singoli pazienti, la complessità degli interventi, le esperienze professionali multiple, i modelli gestionali diversi. Partendo dalla considerazione che l’errore è una componente inevitabile della realtà umana, diventa fondamentale riconoscere che anche il sistema può sbagliare creando le circostanze per il verificarsi di un errore, che restano latenti fino a quando un errore dell’operatore non le rende manifeste. Nella complessa macchina della sanità, a volte l’errore non è del medico ma dell’infermiere; nonostante non siano disponibili dati precisi sul numero degli errori commessi dagli infermieri, si è consapevoli che molti errori nelle somministrazioni di farmaci, le infezioni contratte durante la degenza ospedaliera, le cadute, le ulcere da pressione sono sicuramente imputabili in buona parte al comportamento negligente degli infermieri.[1] Non si può però non considerare la carenza di risorse umane come una tra le principali cause latenti presenti in un sistema o in un’organizzazione, che possono condurre al verificarsi di errori o di eventi avversi.
Rischio clinico Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte.[I] Le istituzioni sanitarie hanno pertanto il dovere di fornire la massima protezione possibile dai danni – conseguenti a errori umani o a errori di sistema- che si verificano nei processi di cura.[2] L’errore umano può essere definito come il fallimento della sequenza di azioni mentali o di attività pianificate per ottenere un obiettivo desiderato. Reason delinea tre diverse tipologie di errore (Tabella 1): - errori di esecuzione che si verificano a livello di abilità (slips): azioni compiute diversamente da come pianificate: “sa ma non lo fa”; - errori di esecuzione provocati da un fallimento della memoria (lapses): “non ricorda”; - errori non commessi durante l’esecuzione pratica dell’azione (mistakes): errori di pianificazione di strategie. Generalmente si considera l’errore solo come diretta conseguenza della azione dell’operatore sanitario; non sempre, tuttavia, la produzione di un danno o di una lesione può essere ricondotta esclusivamente all’azione degli operatori. E’ il caso degli incidenti riconducibili a cause organizzative, per i quali l’evento è il risultato della combinazione e dell’intreccio dell’azione dell’operatore e di condizioni latenti. Quindi si possono distinguere gli “errori attivi” che sono commessi direttamente dall’operatore e determinano un effetto negativo quasi immediato sull’assistito, dagli “errori latenti”, che interessano l’organizzazione, la quale è direttamente coinvolta nel processo di gestione dei rischi, poiché dietro ogni errore attivo troviamo, e vanno ricercate, le cause di errore latente attribuibili al sistema e alla gestione organizzativa.[II] [3]
Tabella 1 – Classificazione dell’errore umano.
Attualmente il focus dell’attenzione si sposta dalla ricerca dell’errore attivo a quello dell’errore latente, riconoscendo nelle carenze del sistema la responsabilità dell’esito non voluto dell’azione intrapresa. Questi errori sono metaforicamente descritti da Reason come “patogeni”, che rimangono latenti all’interno dell’organismo, incapaci di per sé di causare una sintomatologia conclamata, ma che, in connessione con altri fattori eziologici e in condizioni facilitanti, possono dare origine a un evento patologico. Allo stesso modo in tutte le organizzazioni sono presenti elementi potenzialmente dannosi: quanto più essi sono numerosi, tanto più probabile sarà il verificarsi di una combinazione scatenante. Da questa visione sistemica nasce l’idea che il verificarsi di un incidente sia frutto di una concatenazione di eventi che hanno superato tutte le difese che erano state messe in atto. Reason ha cercato di chiarire il significato di errore latente utilizzando una anologia con il formaggio svizzero: ogni fetta di formaggio rappresenta uno strato difensivo dell’organizzazione. Questi strati nelle organizzazioni complesse sono diversi: alcuni sono basati sull’affidabilità dei sistemi ingegnerizzati, altri sull’affidabilità umana, altri ancora sono dipendenti da controlli e procedure. Ognuno di questi strati dovrebbe idealmente essere privo di punti critici, ma in realtà in ognuno c’è – come appunto in una fetta di formaggio svizzero – una serie di buchi che sono in grado di aprirsi, chiudersi, spostarsi al variare delle prospettive adottate in quella determinata parte del sistema. La presenza di questi buchi in diversi strati di per sé non è sufficiente per il verificarsi di un incidente che accade solo in quelle particolari situazioni in cui questi si trovano allineati e permettono la cosidetta traiettoria delle opportunità. Non tutti gli errori latenti producono un errore attivo, né tutti gli errori provocano un danno; perché il danno si verifichi, devono sussistere condizioni tali da permettere all’errore di superare tutte le barriere di sicurezza tecniche e organizzative predisposte all’interno della struttura per contenere gli effetti di possibili errori.[4] [5]
Professione e responsabilità Un’analisi della letteratura internazionale sulla sicurezza in ambito sanitario e, sugli errori degli operatori sanitari, in special modo degli infermieri, evidenzia che la casisitica più frequente proviene dagli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito, Canada e Australia. La Quality of Health Committee dell’Institute of Medicine (IOM) ha redatto nel 1999 un rapporto in cui si stima che il numero delle morti che si verificano a causa di errori degli operatori sanitari sia compreso tra le 44.000 e le 98.000 unità all’anno. Oltre al costo in termini strettamente economici, è necessario tenere in considerazione i costi indiretti – e difficilmente stimabili - rappresentati dalla sfiducia che i cittadini danneggiati sviluppano nei confronti del sistema sanitario. Anche l’Italia ha avviato in anni recenti un percorso orientato alla ricerca di qualità e sicurezza in ambito sanitario, con particolare attenzione al problema dell’errore umano. Il Tribunale dei Diritti del Malato riferisce che il 30,3% dei contatti che il Progetto Integrato di Tutela ha avuto nel 2001 sono relativi a sospetti errori di diagnosi e terapia.[6] Un’indagine condotta da nove State Boards of Nursing ha permesso di identificare gli errori più frequenti, classificati poi in una tassonomia che racchiude otto categorie. Le otto categorie di errori infermieristici che rappresentano un largo range di possibili errori e fattori contrbutivi o causativi[7] sono le seguenti:
Nursing e carenza infermieristica In letteratura sono pubblicati numerosi articoli che tentano di dimostrare gli esiti della carenza infermieristica sul paziente. Lo studio di Needleman et al.[8] ha dimostrato che tra i pazienti delle medicine un numero più elevato di ore erogate dagli infermieri qualificati, in proporzione alle ore totali di assistenza, e un più alto numero di ore erogate in assoluto erano associati ad una minore frequenza di insorgenza di eventi avversi fra i pazienti. Lo studio di Aiken et al.[9] ha riscontrato una relazione statisticamente significativa tra livelli assistenziali e mortalità intraospedaliera e conseguente a complicanze. Questi studi dimostrano che l’assistenza erogata dagli infermieri in condizioni ottimali ha un ruolo importante nella prevenzione degli eventi avversi, nella prevenzione /gestione delle complicanze, nella guarigione in tempi più rapidi e nella prevenzione delle morti correlate all’ospedalizzazione. Inoltre, aumenta la soddisfazione degli infermieri per il proprio lavoro e rappresenta un deterrente verso l’abbandono della professione.
Conclusioni Un sistema sanitario credibile e affidabile non può permettere che le attività di pertinenza, complesse e difficili, possano determinare accidentalmente il peggioramento delle condizioni di salute dei pazienti e un conseguente aumento dei costi per le famiglie e la collettività. Molti degli episodi di danni reversibili o irreversibili a carico dei pazienti trattati nelle condizioni consuete di cura sono causati dalle carenze del sistema organizzativo, più che dall’incompetenza dei singoli operatori sanitari, e quindi sono attribuibili a chi ha la responsabilità di garantire un’organizzazione efficace ed efficiente.[10] Dal momento che in ogni organizzazione complessa l’errore e la possibilità di un incidente non sono eliminabili, devono essere utilizzati tutti gli interventi possibili affinchè siano, per lo meno, controllabili. E’ fondamentale favorire le condizioni lavorative ideali e porre in atto un insieme di azioni che renda difficile per l’uomo sbagliare ed, in secondo luogo, attuare delle difese in grado di arginare le conseguenze di un errore che si è verificato. Gli approcci al problema degli eventi avversi in sanità si focalizzano sul comportamento umano che attribuisce l’incidente ad un comportamento aberrante e sulle condizioni nelle quali accade l’errore, inteso come il risultato di un fallimento di un insieme di elementi umani, tecnologici e relazionali, fortemente interconnessi, interattivi e finalizzati ad un obiettivo comune.[11] Il rischio clinico può essere controllato attraverso iniziative di Risk Management che devono prevedere strategie di lavoro che includano la partecipazione di numerose figure che operano in ambito sanitario e devono essere articolate e comprendere tutte le aree in cui l’errore si può manifestare, nell’interezza del processo clinico-assistenziale del paziente. Finchè l’errore continuerà ad essere visto come una colpa, sarà difficile riuscire a cambiare la situazione; per modificare un atteggiamento di questo tipo il primo passo è l’accettazione stessa dell’errore, come inevitabile; tale obiettivo si può raggiungere con la formazione e la gestione delle competenze dei professionisti della sanità, affinchè il risultato sia quello di prevenire l’errore e di introdurre un cambiamento culturale ed elevare quindi la consapevolezza degli operatori su un tema delicato come quello del rischio clinico.[12]
Parole chiave: rischio clinico, assistenza infermieristica
Bibliografia
[I] Kohn, Corrigan, Donaldson,1999 [II] Fonte: Ansa; www.ansa.it - “In Italia si stimano 90 morti al giorno per errori”, Roma 17 settembre 2004. [1] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Nursing malpractice: gli errori degli infermieri nella pratica professionale. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni McGraw Hill, 2006;115-38 [2] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Il risk management. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni Mc Graw Hill, 2006; 58 [3] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Il risk management. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni Mc Graw Hill, 2006; 92 [4] Ministero della Salute Dipartimento della Qualità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei principi etici di sistema. Ufficio III Risk management in sanità. Il problema degli errori. Commissione Tecnica del Rischio Clinico D.M. 5 marzo 2003. Roma, marzo 2004. [5] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Il risk management. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni Mc Graw Hill, 2006; 92-4 [6] Agenzia Regionale Sanità Toscana. La sicurezza degli utenti. In: Nursing: proposta per un progetto regionale. Bozza n. 1.1, 13 dicembre 2003; 8 [7] Mangiacavalli B. Professione e responsabilità. Federazione Nazionale Collegi IPASVI [8] Needleman J, Buerhausn P, Stewart M, Zelewinsijy K. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. N England J Med, 2002; 22:1715-21 [9] Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski, Silber JH. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction, JAMA, 2002; 16:1987-93 [10] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Il risk management. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni Mc Graw Hill, 2006; 82-3 [11] Ministero della Salute Dipartimento della Qualità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei principi etici di sistema. Ufficio III Risk management in sanità. Il problema degli errori. Commissione Tecnica del Rischio Clinico D.M. 5 marzo 2003. Roma, marzo 2004. [12] Del Poeta G, Mazzufero F, Canepa M. Il risk management. In: Il risk management nella logica del governo clinico. Milano: Edizioni Mc Graw Hill, 2006; 113 |