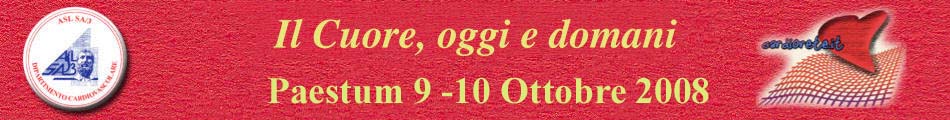
|
SCOMPENSO CARDIACO ACUTO:La problematica ricerca di un appropriato percorso assistenziale
Gerolamo Sibilio, Sabato Tortorella, Antonio Vitolo, Luigi Cavuto Dipartimento Clinico di Malattie Cardiovascolari Asl Na 2 -U.O. di UTIC-Cardiologia P.O. “S.M. delle Grazie” - Pozzuoli
Visti i dati epidemiologici - trend in crescita di pazienti affetti da Scompenso Cardiaco (S.C.) e l’aumento esponenziale della spesa sanitaria - è necessario prevedere un’organizzazione del percorso assistenziale di tipo multidisciplinare, con una rete gestionale integrata per la cura di questa patologia, ottimizzando l’impiego delle risorse e la sinergia tra ospedale e territorio (1). Gli obiettivi dell’iter assistenziale sono stati indicati in una recente Consensus Conference in cui sono state coinvolte le più importanti Società Scientifiche ed il Ministero della Salute (2). Gli obiettivi prioritari sono: · ritardare la comparsa e la progressione della disfunzione ventricolare Sn. e dello S.C.; · prevenire le recidive; · ridurre i ricoveri ospedalieri; · garantire un’assistenza specifica al paziente anziano fragile; · fornire un’assistenza di tipo palliativo al paziente con S.C. terminale. Lo S.C. è una patologia in cui hanno un ruolo centrale, nello sviluppo organizzato della rete assistenziale, varie professionalità (cardiologo, internista, medico di medicina generale, personale infermieristico) che abbiano acquisito competenze specifiche sul problema nella fase acuta, post-acuta e stabile. Lo specialistica ospedaliero gestisce le fasi di ricovero per scompenso acuto di nuova insorgenza o instabilizzato, utilizzando protocolli diagnostico-terapeutici differenti.Il percorso ospedaliero deve essere personalizzato in rapporto alla tipologia dell’ospedale. Un aspetto controverso nella pratica clinica è la scelta del luogo di cura. IL PS/DEA rappresenta lo snodo iniziale del percorso del paziente con S.C. acuto. In questa sede vengono eseguiti il primo inquadramento diagnostico, la stratificazione del rischio ed i trattamenti di urgenza. I pazienti possono essere suddivisi schematicamente a seconda della tipologia del rischio (3): a) pazienti a basso rischio (“non congestione - non ipoperfusione”): attivazione sistematica dell’osservazione breve in PS/DEA con eventuale dimissione a domicilio; b) pazienti a rischio intermedio (“congestione - non ipoperfusione”): ricovero in degenza ordinaria -Medicina, Geriatria, Cardiologia, Riabilitazione degenziale- dove effettuare terapia farmacologica, stabilizzazione clinica e, quindi, dimissione; c) pazienti ad alto rischio (“congestione ed ipoperfusione”): vanno indirizzati nelle unità di terapia intensiva (UTI) e semintensiva (USI), dove è possibile eseguire monitoraggio ecgrafico ed emodinamico, contropulsazione aortica, ultrafiltrazione, ventilazione non invasiva. La terapia farmacologica, in tale setting di pazienti, è prevalentemente infusionale (4-5). Dopo la stabilizzazione clinica, il paziente può essere dimesso o trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Tuttavia la scelta del reparto di degenza, nella pratica clinica, è generalmente condizionato dalla disponibilità dei posti letto nelle differenti strutture ospedaliere; i percorsi intraospedalieri, pertanto, non possono non tenere conto delle diverse realtà locali (disponibilità di risorse strumentali ed organizzative dei reparti di Medicina Interna, presenza di UU.OO. di Medicina di Urgenza e/o Cardiologia Riabilitativa). In linea di principio la maggiore dotazione tecnologica rende più razionale l’invio (iniziale) alla Cardiologia di pazienti con necessità di monitoraggio e/o terapia invasiva. I trasferimenti interni (UTIC, Cardiologia, Medicina, Riabilitazione) dovrebbero essere favoriti da opportuni accordi/protocolli gestionali interni. In pratica, dopo una iniziale stabilizzazione clinica con monitoraggio e terapia intensiva e breve degenza in ambito cardiologico, i pazienti potrebbero completare il programma di cura in Strutture interntistiche. Ciò consentirebbe una appropriatezza dei ricoveri in UTIC, con maggiore disponibilità dei posti letto per acuti e riduzione dei costi ospedalieri. E’ ovvio che durante la degenza la gestione del paziente con S.C. acuto deve essere multidi-sciplinare, con precoce attivazione delle consulenze specialistiche (geriatra, nefrologo, neurologo,, ecc.), in relazione alle specifiche esigenze. I criteri della dimissione dopo uno S.C. acuto non sono soltanto clinici, ma devono prendere in considerazione le caratteristiche culturali del paziente, il contesto socio-sanitario, la presenza e la qualità del supporto familiare e la disponibilità di assistenza domiciliare integrata (ADI). Un aspetto preminente è l’indirizzo del paziente all’ambulatorio dello S.C. per : 1) un primo controllo post-dimissione in caso di labilità clinica; 2) problematiche attive (indicazione ad AICD o trapianto cardiaco); 3) presa in carico in caso di S.C. avanzato. Un ulteriore, ma non meno importante, elemento è la dimissione che deve essere intesa come strumento centrale della continuità assistenziale. La lettera di dimissione dopo S.C. acuto deve contenere indicazioni sul “piano igienico-terapeutico” di mantenimento e controllo a domicilio, con coinvolgimento del MMG (6). Questi rappresenta una figura indispensabile, per la perfetta conoscenza di tutte le problematiche mediche del malato e del suo contesto socio-familiare. E’ utile, pertanto, fornire al cardiopatico con S.C. strumenti di autocontrollo in forma di diario, ma è senza dubbio necessario condividere sempre con il MMG tutti gli aspetti delle cure in post-dimissione.
Bibliografia
1) Gheorghiade M, Zannad F, Sopko G, et al: Acute heart failure syndromes: current state and framework for future research Circulation 2005; 112: 3958-68 2) Consensus conference. il percorso assistenziale del paziente con scompenso Cardiaco G. Ital Cardiol; 7 (6): 387-432 3) Nohria A, Tsang SW, Fang JCJ et al : Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict ouctomes in patients admitted with heart failure J Am Coll Cardiol 2003; 41:1797-804 4) Smith WR, Poses RM, Mc Clish DK, et al:Prognostic judgments and triage decisions for patients with acute congestive heart failure Chest 2002; 121:1610-7 5) Opasich C, Tavazzi L.:Riflessioni sul problema organizzativo dell’assistenza al paziente con scompenso cardiaco cronico G. Ital Cardiol 1998; 28:913-9 6) Raval AN Marchiori GE, Arnold JM.:Improving the continuity of care following discharge of patients hospitalized with heart failure : is the discharge summary adequate? Can J Cardiol 2003; 19: 365-70 |