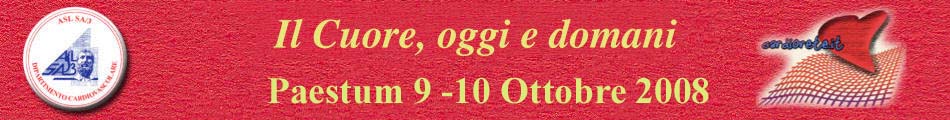
|
Il trattamento percutaneo della stenosi valvolare aortica DELL’ANZIANO: dalla valvuloplastica a palloncino alla sostituzione valvolare
Gennaro Santoro SS Emodinamica A.O. Careggi Firenze
Introduzione al problema La stenosi valvolare aortica è la patologia valvolare di più frequente riscontro nei paesi occidentali e la sostituzione valvolare aortica è l’intervento di chirurgia valvolare più eseguito. La prevalenza di stenosi aortica sintomatica aumenta con l’età: a 75 anni il 2,5% della popolazione e a 80 anni l’8,1% sviluppano una stenosi aortica di grado moderato severo. Il costante aumento nella popolazione italiana di ultraottantenni rende facilmente prevedibile un incremento del numero di pazienti affetti da stenosi valvolare aortica severa nel corso dei prossimi anni. La storia naturale della stenosi aortica è ben nota e strettamente correlata all’insorgenza dei sintomi. Nel paziente con stenosi valvolare severa asintomatico la mortalità annua è inferiore all’1%, mentre nei pazienti sintomatici per insufficienza cardiaca, sincope o angina pectoris la sopravvivenza non supera in genere i 2, 3 e 5 anni rispettivamente. Attualmente la sostituzione chirurgica della valvola è l’unica terapia in grado di modificare la prognosi di questi pazienti, tuttavia, specialmente i pazienti molto anziani presentano spesso un rischio cardiochirurgico molto elevato o sono inoperabili in relazione all’età stessa o per la poli-patologia tipica del paziente geriatrico. Mentre al di sotto dei 70 anni la mortalità peri-operatoria in molti centri è inferiore all’1%, al di sopra degli 80 anni il valore sale all’11% nei primi 30gg dall’intervento. Nei pazienti ultraottantenni emergono inoltre con frequenza non trascurabile serie complicanze post-operatorie quali ictus (4-8%), disfunzione renale (11%) e sindrome da bassa poratata (16,5%). Il registro europeo dei pazienti affetti da valvulopatia (Euro Heart Survey) ha permesso di dimostrare che circa 1/3 dei pazienti affetti da stenosi aortica severa sintomatica non riceve alcun trattamento, principalmente a causa della co-morbidità che rende proibitivamente alto il rischio chirurgico. La prevalenza elevata della malattia, la sua associazione con età avanzata e elevato rischio operatorio , ha promosso l’interesse per un approccio alternativo: La valvuloplastica aortica percutanea : la dilatazione con palloncino della valvola aortica stenotica è un intervento praticato da molti anni e che per molto tempo è stata l’unica scelta terapeutica nei pazienti non operabili. L’intervento si è dimostrato efficace nel ridurre in acuto il gradiente transvalvolare e quindi nel determinare un miglioramento clinico a breve termine. Tuttavia la valvuloplastica ha il limite che la restenosi è pressoché costante nell’arco degli 8-12 mesi successivi. Si tratta quindi di una misura palliativa che non può essere una valida alternativa alla sostituzione chirurgica, e che richiede il re-intervento percutaneo nell’arco di 12-18 mesi. L’impianto di protesi aortica percutanea: la possibilità di impiantare un sistema valvolare protesico aortico per via percutanea ha aperto nuovi orizzonti nel trattamento di questi pazienti non candidabili alla sostituzione valvolare aortica chirurgica. Il gruppo francese di Alain Cribier, sfruttando l’esperienza decennale di valvuloplastiche aortiche, ha effettuato su un paziente il 16 aprile 2002 il primo impianto percutaneo di una bioprotesi valvolare aortica in pericardio equino montata su palloncino e sviluppata ad hoc (protesi Cribier-Edwards). I buoni risultati dei primi casi hanno promosso una fervida attività sperimentale nella ricerca e sviluppo di nuove valvole e nuovi sistemi di impianto. Alla valvola montata su palloncino Cribier-Edwards si è affiancata la valvola CoreValve di pericardio bovino inserito in uno stent autoespandibile di nitinolo. Negli ultimi tre anni sono stati trattati con tecnica percutanea circa 2200 pazienti nel mondo con percentuali di successo dell’impianto superiori al 95% e con risultati clinici molto incoraggianti sia in acuto che al follow up a medio termine (mortalità a trenta giorni intorno all’8%). In particolare l’intervento si caratterizza per la breve durata della degenza post-operatoria (dimissione in media dopo 4 giorni), senza necessità di ricovero in terapia intensiva.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Le due protesi valvolari aortiche attualmente in commercio hanno caratteristiche differenti : la Cribier-Edwards (fig.1) è costituita da una valvola biologica suturata su uno stent espandibile su pallone ed il sistema di trasporto ha un diametro di 22 F e può essere impiantato per via femorale arteriosa previa arteriotomia chirurgica oppure per via trans-apicale previa toracotomia ed esposizione dell’apice cardiaco; la CoreValve (fig. 2,3) è una protesi biologica montata dentro uno stent autoespandibile (fig 4,5) ed il sistema di trasporto è di 18F e può essere impiantata per via arteriosa femorale in modo percutaneo (fig 6) o per via succlavia previa arteriotomia chirurgica. Questa ultima può quindi essere impiantata anche senza anestesia generale quando è possibile l’accesso femorale. Il successo tecnico dell’impianto è legato alla corretta selezione anotamica dei pazienti.Più complessa è la selezione clinica dei pazienti che richiede una stretta collaborazione fra cardiologi, cardiochirurghi, cardioanestesisti, geriatri. Necessario è capire quanto non solo in termini di sopravvivenza ma anche in termini di qualità l’intervento sia utile ai nostri pazienti che allo stato attuale è costituito da pazienti ad alto rischio o inoperabili e quindi nella quasi totalità pazienti ultra ottantenni, con gravi comorbilità. Il fine quindi deve essere quello di dare una “vita migliore” ai nostri “vecchi”.
Bibliografia 1) Cribier A, Eltchaninoff H, Tron C. First human transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis in a case of severe calcific aortic stenosis [in French]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2003;52:173–175. 2) Hanzel GS, Harrity PJ, Schreiber TL, O’Neill WW. Retrograde percutaneous aortic valve implantation for critical aortic stenosis. Catheter Cardiovasc Interv. 2005;64:322–326. 3). Webb JG, Chandavimol M, Thompson CR, Ricci DR, Carere RG, Munt BI, Buller CE, Pasupati S, Lichtenstein S. Percutaneous aortic valve implantation retrograde from the femoral artery. Circulation. 2006;113: 4) Laborde et al Percutaneous Implantation of an Aortic Valve Prosthesis . Catheterization and Cardiovascular Interventions 2005;65:171-174 5)Grube et al.First Report on a Human Percutaneous Transluminal Implant of a Self-Expanding Valve Prostheses for Interventional Treatment of Aortic Valve Stenosis Catheterization and Cardiovascular Interventions 2005;66:465-469 6)Grube et al Percutaneous Implantation of the CoreValve Self-Expanding Valve Prosthesis in High Risk Patients with Aortic Disease. The Siegburg First-in-Man Study , Circulation 2006;114:1616-1624 7)Grube et al Percutaneous Aortic valve replacement for severe aortic stenosis in high- risk patients using the second and current third-generation self- expanding CoreValve prosthesis. J Am Coll Cardiol, 2007; 50:69-76, 8)Todd K. Rosengart, Ted Feldman, Michael A. Borger et al .Percutaneous and Minimally Invasive Valve Procedures. A Scientific Statement From the American Heart Association Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, Council on Clinical Cardiology, Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Group, and Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation Mar 2008 |





