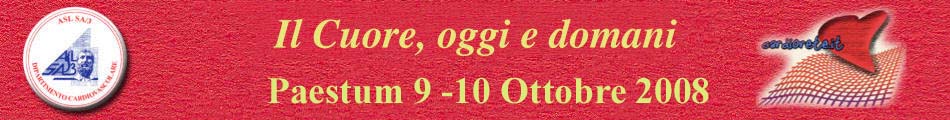
|
DOPO L’EVENTO DALLA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO ALLA TERAPIA
Carmine Riccio – Marco Malvezzi Caracciolo U.O. Cardiologia Riabilitativa Dipartimento di Cardiologia A.O. San Sebastiano Caserta
Il tema della gestione del cardiopatico dopo l’evento ha subito in questi anni una sorta di disaffezione da parte della cardiologia, tutta incentrata sulla gestione della fase acuta e sulla ottimizzazione della rete assistenziale delle prime ore dopo l’evento. Pertanto si sono diffusi percorsi assistenziali agili, indirizzati a deospedalizzare rapidamente i soggetti trattati per cardiopatia acuta ed a basso rischio, anche sotto la spinta della motivazione economica dei rimborsi per DRG: l’esempio più tipico è quello dell’infarto miocardico acuto con programma di dimissione precoce. Nella fase attuale sono in forte diffusione modelli di organizzazione orizzontale dei percorsi assistenziali, come la rete interospedaliera per l’assistenza all’infarto miocardico acuto, mentre è carente la formulazione di modelli di assistenza verticali, specifici per i pazienti ad alto rischio ed in grado di accompagnare il loro percorso in modo graduale dalla terapia intensiva fino alla ripresa di un ruolo nella comunità. Ciò penalizza proprio quei gruppi di pazienti con peggior prognosi, rischiando di non incidere sulla loro mortalità e morbilità a distanza e sulla frequenza delle riospedalizzazioni. La cardiologia non ha però ancora saputo identificare percorsi specifici per i pazienti trattati per una patologia acuta ad alto rischio, la cui permanenza in ospedale sia solo leggermente più lunga senza presentare però le necessarie specificità e senza essere seguita da una fase postospedaliera realmente protetta. In questo modo viene disatteso il ruolo centrale della Cardiologia nella cura del paziente ad alto rischio: è invece proprio in questa necessità di riorganizzazione culturale ed organizzativa dell’assistenza, basata su una clinical competence specifica nelle UTIC, sulla capacità di una stratificazione prognostica dinamica e sulla costruzione di strutture che assicurino la gradualità delle cure, che la Cardiologia italiana deve e può trovare spazio per affermare il suo ruolo centrale nel governo clinico dell’assistenza. Per portare a termine questo processo di maturazione sarà determinante la capacità delle società scientifiche cardiologiche di porsi come interlocutori e come consulenti delle istituzioni per la programmazione e per il controllo dell’outcome e della performance delle strutture. In realtà le società scientifiche hanno pubblicato, e periodicamente rivisto, linee guida per la gestione del paziente dopo l’evento, ma come spesso accade, non sempre sono uniformemente applicate. Esiste, ad esempio il problema della stratificazione prognostica nel paziente che ha avuto una SCA, trattata con rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica. Se da una parte l’esame ecocardiografico mantiene il suo ruolo centrale nella definizione della funzione residua, che risulta ancora oggi il più affidabile predittore prognostico, va ridisegnato il ruolo del test da sforzo o di altri test provocativi. Risulta chiaro, ormai, che l’ergometria ha una bassa sensibilità e specificità nell’individuare fenomeni di restenosi, circa il 60%, in pratica poco più del lancio della monetina. Sappiamo anche dell’elevato numero di tests ergometrici positivi solamente per segni, che ci hanno condotto a fare procedure coronarografiche risultate assolutamente negative per restenosi e pertanto inutili e potenzialmente dannose. Bisogna quindi definire dei percorsi diagnostici che riportino al centro la clinica. Farsi guidare dalla sintomatologia del paziente, laddove chiaramente di tipo anginoso, il paziente va indirizzato a coronarografia senza ulteriori indagini; nel caso in cui esistessero dei dubbi sulla natura ischemica dei sintomi riferiti, il paziente va sottoposto ad un test provocativo. La scelta tra eco-stress e scintigrafia, essendo sostanzialmente sovrapponibile la loro accuratezza in questo tipo di pazienti, deve essere effettuata, a mio avviso, in base alle caratteristiche del singolo paziente e all’esperienza specifica del centro che lo esegue. Un altro problema è rappresentato dalla ottimizzazione della terapia. Non esistono dubbi sul fatto che una terapia combinata con antiaggreganti, aspirina e clopidogrel, statine, betabloccanti, ace-inibitori e omega 3 rappresenti il top oggi disponibile. Ma che senso ha prescrivere questa terapia, sicuramente efficace ma ad alto costo, senza valutarne gli effetti, senza aggiustare la posologia in base alla risposta del paziente? Quanti pazienti, in assenza di specifiche indicazioni, sospendono un farmaco raccomandato per la comparsa di un qualche effetto collaterale o semplicemente perché non gli era stato specificato per quanto tempo doveva assumerlo? Quanti drammatici casi di restenosi intrastent si sono verificati per una inappropriata sospensione della terapia con il clopidogrel, magari per una banale estrazione dentaria? Una gestione di questo genere è sicuramente fallimentare, comportando gravi conseguenze per la salute dei pazienti associate a enormi sprechi di risorse. Ma la gestione del dopo evento è fatta anche di counceling alimentare, di attività fisica, di assistenza psicologica. C’è da chiedersi se la Cardiologia Ospedaliera ha il tempo, il personale, le competenze per poter affrontare un programma così strutturato di prevenzione secondaria? L’invio di questi pazienti ai centri di Cardiologia Riabilitativa consente di risolvere al meglio il problema. La maggior parte dei pazienti, a basso rischio e senza comorbilità di rilievo, possono essere inseriti in programmi ambulatoriali o di day hospital, riservando invece i programmi ai pazienti complessi, con gravi comorbidità, e quindi ad alto rischio. In realtà questo percorso non viene ancora attuato se non in una piccola percentuale di pazienti, come confermato dai dati dell’Isyde 2008 che evidenziano che soltanto il 23% dei pazienti che afferiscono ai centri di riabilitazione è stato colpito da una SCA o è stato trattato con angioplastica coronaria. La cardiologia Riabilitativa può inoltre proporsi come interlocutore privilegiato con il territorio, sviluppando sinergie di collaborazione con i medici di medicina generale e con la specialistica territoriale che consentano di “seguire” il paziente, ottimizzando e perpetuando i brillanti risultati che oggi vengono ottenuti nella fase acuta della cardiopatia ischemica. |