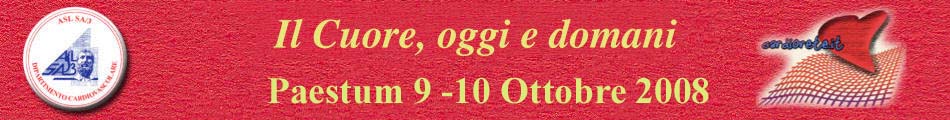
|
L'UTILIZZO APPROPRIATO DELLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E STRUMENTALE NEL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO
E. Murena S. Tortorella Unità Operativa di Cardiologia- UTIC Ospedale S. Maria delle Grazie Pozzuoli ASL NA 2 Per i medici di medicina d'urgenza, per i cardiologi consulenti o direttamente impegnati in PS, una della maggiori sfide quotidiane è rappresentata dalla capacità di diagnosticare accuratamente e di ricoverare i pazienti con dolore toracico (DT) secondario ad una sindrome coronarica acuta (SCA) con l'obiettivo nel contempo: a) di non dimettere i pazienti con SCA in corso ( sottogruppo minimo ma gravato da elevata mortalità a breve termine- 2 - 4 %); b)di evitare ricoveri osservazionali e precauzionali in pazienti con DT non legato ad una causa coronarica.Mentre si osserva una riduzione della prevalenza delle malattie cardiovascolari nei paesi occidentali, si assiste ad un incremento del numero dei cittadini che si rivolge ad un DEA per un episodio di DT; tutto ciò probabilmente dovuto ad un timore sempre maggiore che il semplice sintomo del dolore possa essere foriero di accidenti coronarici anche fatali, per cui si abbassa sempre di più la soglia di attenzione a cui si comincia ad invocare il supporto del medico.La gestione clinica dei pazienti con DT è pertanto, piuttosto complessa, con notevoli implicazioni organizzative, medico legali ed economiche. La difficoltà della valutazione è dovuta al fatto che più del 50% di coloro che afferiscono al PS con DT di incerta origine e con sintomi tipici, non presenta una SCA e , d'altro canto, circa il 50- 65% dei pazienti in cui sarà diagnosticato un infarto ( IMA), non presenta alterazioni diagnostiche all'ECG di base. I dati clinici ed ecgrafici rilevabili all'ingresso hanno bassa sensibilità ( 18-65%) e bassa specificità ( 69% ) per SCAE', peraltro, fondamentale e di inmportanza vitale una diagnosi precoce con una associata ed immediata stratificazione del rischio per assicurare un trattamento più idoneo ( invasivo v/s conservativo)e la destinazione del reparto di degenza più appropriato ( UTIC-Cardiologia- Medicina).
I MARCATORI DI DANNO MIOCARDICO I marcatori biochimici vengono misurati per rivelare o escludere la necrosi miocardica. Le troponine Te I, la creatinchinasi (CK)- MB e la Mioglobina sono quelli più usati. I pazienti con IMA di norma mostrano una elevazione delle Troponine entro 6 ore dall'inizio dei sintomi. A sette ore, CK-MB e Troponina T hanno un valore predittivo negativo più elevato rispetto alla Mioglobina. Attualmente la Troponina e' il solo biomarcatore con un ruolo ben stabilito per la diagnosi ed anche utilizzabile per una indicazione prognostica.Sono proteine strutturali dell'apparato contrattile della miocelulla e vengono rilasciate in seguito a necrosi del miocita e cominciano ad elevarsi dopo due - quattro ore dall'inizio dei sintomi ed il risultato proveniente da un laboratorio centralizzato perviene entro 60/90 minuti, mentre i metodi “POINT OF CARE” forniscono valori entro 15/20 minuti, tuttavia con una sensibilità analitica inferiore e con il rischio di non riconoscere pazienti con minima/ modesta elevazione.E' importante sottolineare che, data l'estrema variabilita del sintomo dolore con conseguente difficoltà a datarne l'inizio, è fondamentale considerare l'ammissione del paziente come “TEMPO ZERO”, da cui far partire la sequenza di misurazione del biomarcatore.L'elevazione persiste per giorni ( la T fino a 14 gg) ma è comunque dipendente dall'entità del danno miocardico. Tale danno non rappresenta sempre una necrosi da IMA.Requisito fondamentale per il sospetto di una SCA è un incremento della Troponina con caratteristiche “incrementali / decrementali”o “incrementali” rispetto ad un valore basale gia elevato. L' elevazione della troponina può essere dovuta ad altre cause che sono rappresentate da: Embolia Polmonare, Scompenso Cardiaco Acuto, Mio- Pericardite, Malattie Infiltrative ecc.La Troponina rimane in assoluto il Marker di riferimento ( I A ) per la diagnosi di IMA; gli altri due Markers hanno un impatto sull'iter diagnostico decisamente inferiore: CK-MB-MASSA è il riferimento nel caso in cui le Troponine non siano disponibili (I A), altrimenti il loro dosaggio non è necessario ( utile soltanto per la diagnosi di Re- IMA precoce). LA MIOGLOBINA consente la diagnosi precoce di IMA ed è scarsamente miocardiospecifica.( aumenta nei traumi muscolari e nell'insufficienza renale ) mantiene un elevato valore predittivo negativo per IMA in pazienti che si presentino nelle prime tre ore con caratteristiche di basso rischio e bassa prevalenza di coronaropatia . Il suo utilizzo routinario non viene raccomandato.CPK totale, CK-MB- attività, LDH, SGOT sono da considerarsi obsoleti.
E.C.G. In un paziente che afferisce al PS con DT, un elettrocardiografo è il primo ed immediato strumento che ci consente, attraverso una attenta lettura ed interpretazione dell'ECG, un iniziale orientamento diagnostico ed anche prognostico. L'ECG, in un soggetto con cardiopatia ischemica accertata, ci puo fornire indicazioni mirate nell'immediato sul quale sia il miglior percorso terapeutico e la più opportuna sede di ricovero del nostro paziente. Di fronte ad un ECG decisamente patologico, non si deve ovviamente attendere i risultati dei biomarcatori, intervenendo in tempi rapidi con la terapia appropriata. All'altro estremo in un soggetto con anomalie aspecifiche della ripolarizzazione e/o ECG non diagnostico, ma con diagnosi dubbia di ischemia, si può attivare un piano diagnostico – terapeutico ( PDT) con un iniziale osservazione breve ( OBI) sino a 12 ore con ECG seriati o monitoraggio “in continuo”. Per poter cogliere le possibili minime alterazioni l'ECG deve essere eseguito entro 10 minuti dall'ammissione sé il dolore è in atto, ed il più precocemente possibile sé cessato ( I A). Lungo è l'elenco di situazioni che possono simulare l'ischemia acuta/ IMA : a) peri-miocardite, b) ripolarizzazione precoce, c) BBS, d) embolia polmonare e) pre- eccitazione ventricolare ,f) ipercaliemia, g) emorragia subaracnoidea, h) sindrome di Brugada. Un limite importante è legato alla latenza della comparsa delle alterazioni specifiche per cui diviene necessario eseguire ECG seriati ( I C ) o un monitoraggio continuo (IIA Evidenza B), quando il primo tracciato non è diagnostico. Il mancato riconoscimento in PS di caratteristiche “ ischemiche” ad alto richio in pazienti con DT puo arrivare sino al 12% e comporta una mancata terapia antiischemica e riperfusiva, contribuendo ad aumentare il tasso di mortalità intraospedaliero ( 7.9%) vs (4.9%) in pazienti con corretta valutazione dell'ECG. Il sopraslivellamento del tratto ST è il marker più sensibile e specifico (90%) di IMA, ma è presente solo nel 30-40% dei casi .Il sottoslivellamento del tratto ST indica ischemia miocardica, ma la sua capacità di identificare un IMA è bassa (50%). l'inversione simmetrica dell'onda T è un segno non specifico nei pazienti con DT. La comparsa di una nuova onda Q all'ECG all'ingresso è diagnostica per IMA nel 90%. Un ECG normale / non diagnostico orienta verso una bassa percentuale ( 2-4%) in coloro che svilupperanno un IMA.
TECNICHE DI IMAGING
XGRAFIA TORACE: ( I C) In circa il 25% dei pazienti sono presenti reperti significativi comprendenti: cardiomegalia, polmonite, edema polmonare. Il suo valore non è stato mai valutato in pazienti definiti a basso rischio.
ECOCARDIOGRAMMA: (II A – Evidenza B ) Fornisce importanti informazione per la DD con altre patologie C. V. ( embolia polmonare, dissezione aortica, tamponamento cardiaco).Utile in pazienti con DT in atto, con ECG non diagnostico e in pazienti in stato di shock . Alta sensibilità (93%) per IMA; bassa specificità dovuta ad inclusione di pazienti con segni di pregresso IMA.
SCINTIGRAFIA: ( II A Evidenza B ) Assume valore diagnostico in pazienti con ECG e Marker non diagnostici: è stata largamente studiata con la possibilità di acquisire già inizialmente un' area a “rischio miocardico”, non modificabile anche in caso di riperfusione. Limiti della metodica sono costituiti da : a) pochi centri dotati in loco ( < ¼ ) b) necessità di iniettare il tracciante radioattivo nell'area del DEA. c. limitazione per artefatti in alcune categorie di pazienti.
TEST ERGOMETRICO: ( II A Evidenza A ) Utile in pazienti con DT e probabilità pre- test intermedia di malattia coronarica. Duplice scopo: a) valutare la presenza di ischemia inducibile b) stratificare la prognosi. In assenza di controindicazioni cardiache ed exstra cardiache, un TE diagnostico negativo per ischemia inducibile, con un carico lavorativo di almeno 6 METS o 85% della F.C. Massimale per l'età, appare in grado di evitare ricoveri inappropriati e consente la dimissione del paziente in elevato grado di sicurezza con un test eseguito a 12 – 18 ore.
TAC – MULTISLICE ( II B Evidenza C ) In caso di pazienti con DT e bassa prevalenza di malattia coronarica la metodica avrebbe una buona capacità di escludere la malattia in presenza di un risultato negativo, ma , in caso di positività, è alta la probabilità di incorrere in un falso positivo, con ovvie ricadute in termini di coronarografie inutili. L'esperienza clinica ancora iniziale unita alla considerevole radioesposizione rendono ancora non proponibile l'applicazione estensiva della metodica per escludere la coronaropatia severa in pazienti con DT a basso rischio.
CONSIDERAZIONI FINALI L'Utilizzo mirato ed appropriato delle metodiche di laboratorio e strumentali non può prescindere da una attenta valutazione clinica come parte integrante di un piano diagnostico- terapeutico. Al personale infermieristico, attraverso il TRIAGE, viene affidata la valutazione iniziale del paziente a) annotazione dei parametri vitali, b) incannulamento vena periferica ,c) esecuzione entro 10 minuti di un ECG ed immediata interpretazione da parte del medico di PS, d) collegamento al monitor- defibrillatore ,e) eventuali prelievi per marcatori. Questo primo step è propedeutico per un orientamento diagnostico volto a definire la probabilità di una SCA come causa determinante dei sintomi lamentati dal paziente, rispetto alle possibilità di altre patologie CV o non CV. E' auspicabile nonché opportuno che tali strumenti diagnostici vengano inseriti in un percorso di valutazione del DT nei singoli ospedali, che sia condiviso e validato dalle figure professionali che si trovino a gestire il paziente già dal territorio ( medici di base 118) nel DEA, ( medici di urgenza ) fino alla Medicina, Cardiologia- UTIC e laboratori di emodinamica ed ottenendo una formale istituzionalizzazione delle Direzioni Sanitarie Locali. Il fine ultimo è cercare di ridurre gli errori e massimizzare l'efficacia con l'inserimento di indicatori di verifica a distanza di 6 -12 mesi del protocollo operativo con una prestabilita riduzione dei ricoveri impropri e dimissioni inappropriate.
|