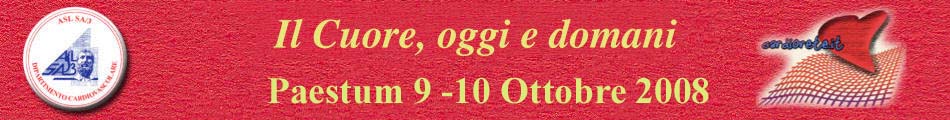
|
Conquiste e sfide della ricerca in cardiologia A. Maseri Fondazione Italiana per il Tuo Cuore – HCF Dal tempo in cui mi sono affacciato alla cardiologia i progressi sono stati enormi. Non avevamo i mezzi per diagnosticare con certezza se una lesione valvolare causava una predominante stenosi o insufficienza né per verificare se la risposta ad un test da sforzo era o non era ischemica. E’ stata la ricerca clinica fisiopatologica a farci uscire da quel “medio evo” identificando i guasti che dovevano essere diagnosticati. Ora si pone la sfida della prevenzione dei guasti ma le attuali strategie di prevenzione hanno già sfruttato le potenzialità fornite dalle attuali conoscenze. Un salto di qualità verrà dalla applicazione della ricerca di base in casistiche di pazienti fenotipicamente omogenei, selezionati da accurate osservazioni cliniche tra quelli che hanno più caratteristiche distintive anamnestiche, cliniche, bioumorali, rispetto a quelle tradizionalmente attese. Scoprire che cosa rende “diversi” alcuni pazienti rivelerà meccanismi di malattia e di protezione ancora ignoti e renderà possibile lo sviluppo di nuovi target terapeutici. La diagnosi e correzione dei guasti La ricerca clinica fisiopatologica ha permesso di identificare e quantizzare i “guasti” responsabili dei disturbi che conducono i pazienti dal cardiologo. I mezzi diagnostici si sono poi progressivamente affinati e le strategie terapeutiche per ripararli o correggerli sono diventate sempre più efficaci. Per i pazienti molto sintomatici la scomparsa o riduzione dei disturbi fornisce la prova dell’efficacia della terapia caso per caso, senza la necessità di trails clinici. Il successo nella correzione dei “guasti” cardiovascolari ha stimolato una sfida molto più ambiziosa: la loro prevenzione. La prevenzione di eventi cardiovascolari avversi è valutata in termini statistici, in studi controllati randomizzati in doppio cieco: i trial clinici.
I Trials clinici ed oltre I trials clinici non stanno più producendo risultati eclatanti né nella prevenzione dell’aterotrombosi né in quella dello scompenso: alcuni risultano negativi, altri dimostrano benefici statisticamente significativi solo in sottogruppi e, comunque, con riduzioni modeste del numero totale di eventi. Come uscire da questa fase di stallo? Per rispondere a questa domanda è utile analizzare: 1. la strategia sulla quale sono basati i trials; 2. i limiti dell’attuale approccio statistico alla prevenzione cardiovascolare; 3. un approccio patofisiologico per la prevenzione cardiovascolare sul modello di quanto avviene per la prevenzione dell’anemia; 4. la rivalutazione dell’osservazione clinica.
1. Strategia degli attuali trials Attualmente i trials clinici sono disegnati per valutare la riduzione incrementale del rischio composito di eventi avversi prodotto da nuovi trattamenti, rispetto al placebo, in gruppi di pazienti molto ampi, già trattati in maniera ottimale secondo le linee guida. Tuttavia i trattamenti sono indicati dalle linee guida, proprio perché si sono dimostrati efficaci, quindi un’ulteriore importante riduzione del rischio appare possibile solo identificando nuovi target terapeutici specifici, non ancora bersaglio dell’attuale trattamento “ottimale”. Nuovi target terapeutici possono essere individuati adottando strategie di ricerca clinica innovativa.
2. I limiti dell’attuale approccio “statistico” alla prevenzione I risultati delle attuali strategie sono stati: - l’identificazione di indicatori prognostici che permettono di stratificare gli individui in gruppi a rischio medio progressivamente crescente e la produzione delle carte del rischio; - una riduzione del rischio medio di eventi che, con trattamenti combinati, può raggiungere il 50%. Questi risultati sono successi importanti e le attuali strategie di prevenzione debbono essere implementate al meglio nella pratica clinica. Ma non possiamo limitarci a questo, beandoci dei nostri successi, paghi dei risultati ottenuti, perché il bicchiere è pieno solo a metà. Dobbiamo accingerci a riempire la metà vuota del bicchiere, accettando umilmente di non poter spiegare tutto con quello che abbiamo scoperto fino ad ora. Dobbiamo uscire dai paradigmi che ci hanno condizionato fino ad ora e considerare due limiti intrinseci di questa strategia preventiva, su base statistica che sono sistematicamente sottaciuti: - una riduzione del rischio del 50% implica automaticamente che il restante 50% avrà un evento nonostante il trattamento “ottimale” - l’identificazione di un gruppo di individui con un rischio elevato, per esempio del 30%, implica automaticamente che il 70% di quello stesso gruppo non avrà un evento. Al momento attuale non abbiamo modo di identificare né il 50% che avrà un evento nonostante il trattamento “ottimale” e che necessiterebbe quindi di una prevenzione aggiuntiva efficace, né il 70% che non avrà un evento e che potrebbe essere rassicurato invece di ricevere anch’esso il trattamento “ottimale”, valido per la media. Se fossimo in grado di identificare questi due sottogruppi potremmo riservare il trattamento “ottimale” per quei pazienti nei quali esso evita realmente gli eventi avversi.
3. Un approccio patofisiologico alla prevenzione E’ possibile riparare o correggere “guasti” che causano gravi disturbi anche senza conoscere con precisione i meccanismi fisiopatologici che li causano. La terapia diuretica è efficace nello scompenso e l’angioplastica primaria è efficace nell’infarto acuto indipendentemente dalle possibili cause di queste due sindromi. Proprio come nella grave anemia una trasfusione è efficace indipendentemente dalle sue possibili molteplici cause. Tuttavia una prevenzione specifica dei “guasti” richiede la precisa conoscenza e diagnosi delle loro varie componenti patogenetiche. Un esempio classico è proprio fornito dalla prevenzione dell’anemia che è diventata possibile grazie all’identificazione dei suoi svariati meccanismi patogenetici: per esempio la deficienza di ferro e di vitamina B12 sono prevenute dalla correzione delle cause della loro rispettiva deficienza. Gli ematologi sono riusciti ad identificare una serie di descrittori (nell’anamnesi, nei globuli rossi, nei parametri ematoclinici) che caratterizza meccanismi patogenetici causali specifici, e che permette una diagnosi, precisa con la conseguente possibilità di trattamenti mirati. Un approccio patofisiologico alla prevenzione delle varie sindromi cardiovascolari non è attualmente possibile perché, per quasi tutte, manca ancora un insieme di descrittori sufficiente per caratterizzare meccanismi causali diversi, all’interno della stessa sindrome clinica, con la stessa specificità con cui si riconoscono le varie cause dell’anemia. Inoltre la crescente diffusione dei trials clinici e la produzione di linee guida determinano una standardizzazione della gestione dei pazienti secondo protocolli codificati. Sempre più spesso, al fine di semplificare ed uniformare le scelte terapeutiche e preventive, vengono definite linee guida e protocolli che includono uno spettro di pazienti sempre più ampio. Così viene disincentivata l’attenzione per i casi che deviano dai comportamenti più comuni ed attesi sulla base dei dati medi disponibili. Tuttavia le scoperte che permetteranno una prevenzione più mirata personalizzata saranno frutto di nuove osservazioni cliniche.
4. La rivalutazione dell’osservazione clinica Attualmente siamo indotti a focalizzare la nostra attenzione sul valore predittivo medio degli indicatori di rischio e sulla risposta media alla terapia. Tuttavia, per scoprire nuovi meccanismi di protezione di malattia dobbiamo studiare i pazienti che più deviano dal comportamento e dalla risposta attesa, più comune. Scoprire la causa di questa deviazione dal comportamento prevalente è una tappa fondamentale per sviluppare forme di terapia e prevenzione più razionali. Due esempi illustrano questa nuova strategia di ricerca che HCF si accinge a promuovere. - Tra i pazienti che hanno un grosso infarto miocardico sarà illuminante scoprire perché nei mesi e anni successivi alcuni sviluppano scompenso recidivante mentre altri con un infarto simile restano sempre in classe NYHA 1 o 2 - Tra i pazienti con criteri MADIT 2 per l’impianto di un defibrillatore negli anni successivi, alcuni non hanno alcuna scarica appropriata altri ne hanno molteplici. Verranno selezionati i pazienti che all’esordio appaiono del tutto simili e che avranno un’evoluzione estremamente opposta. Entreranno in protocolli elaborati dai rispettivi gruppi di studio e saranno seguiti attentamente fino all’esito. Assieme a questi esempi paradigmatici HCF incoraggerà la segnalazione di tutti i casi che una curiosa osservazione clinica rileverà come molto inusuali. La rete del Centro Studi li segnalerà per esplorare se ne esistono altri simili sviluppando così casistiche di comportamenti inusuali che entreranno in protocolli ad hoc per studi di ricerca di base.
|