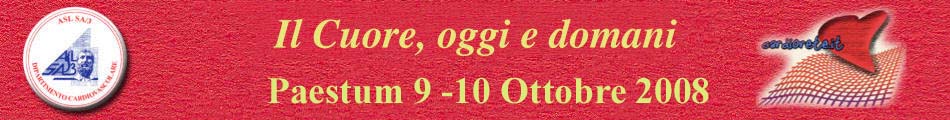
|
L' ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE: QUANDO ESEGUIRLA, QUANDO NON ESEGUIRLA.
Valentino Ducceschi U.O. UTIC – CARDIOLOGIA Ospedale San Luca Dipartimento Cardiovascolare ASL SA 3 Vallo della Lucania .
La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia che si incontra nella pratica clinica, responsabile di oltre un terzo dei ricoveri dovuti a disturbi del ritmo cardiaco. Si stima che rispettivamente 2.2 e 4.5 milioni di cittadini negli Stati Uniti e nella Comunità Europea siano affetti da FA parossistica o persistente, senza contare poi che negli ultimi 20 anni si è osservato un incremento del 66% delle ammissioni in ospedale per fibrillazione atriale. Pertanto, ben si comprende come la FA costituisca un problema per le risorse economiche della sanità nei paesi più avanzati, soprattutto per le ripetute ospedalizzazioni che richiede ed in minor misura per la spesa farmacologica che comporta. Si calcola che annualmente il costo complessivo per pz ammonti a circa 3000 euro, per una spesa globale dell' Unione Europea di crca 13.5 miliardi di euro. L' incidenza della FA aumenta progressivamente con l' età, passando dallo 0.1% negli individui di età inferiore ai 40 anni, a circa il 2% nei soggetti maggiori di 80 anni. Inoltre, tale aritmia si associa ad un sensibile incremento del rischio di stroke, di scompenso cardiaco e di mortalità : secondo una stima recente, .quest' ultimo risulta almeno raddoppiato nei pz con FA. Pertanto, l' ablazione transcatetere mediante radiofrequenza della FA si propone come valida alternativa alla terapia farmacologica in pz selezionati, soprattutto per il minor dispendio di risorse che alla fine comporta e la migliore qualità di vita che assicura. Essa va riservata a quei pz con FA parossistica o persistente primitiva con episodi frequenti (almeno tre all' anno), refrattari a terapia farmacologica (almeno un farmaco antiaritmico a dosi piene) o che lo richiedano per motivi particolari (determinate categorie professioneli, sportivi agonisti, pz intolleranti alla terapia farmacologica etc.): Le dimensioni dell' atrio sx non costituiscono, entro certi limiti, un fattore limitante l' indicazione all' ablazione, purchè non si tratti di ingrandimento atriale secondario a cardiopatia valvolare . Lo stesso dicasi per l' età avanzata del pz: generalmente, il limite è posto a 75 anni, ma si deve tener conto anche delle condizioni generali dell' individuo. Infine, nei pz con FA e disfunzione sistolica ventricolare sx non vi è controindicazione alla procedura ablativa, anzi sembrerebbe che questa tipologia di pz sarebbero quelli che traggono maggiori benefici dalla procedura. Controverso è tuttora l' impiego di questa metodica nel trattamento delle forme cronicizzate di FA. La tecnica ablativa attualmente maggiormente seguita perchè corroborata dalle evidenze clinico-sperimentali è definibile "ibrida", in quanto mira ad eliminare eventuali foci "trigger", localizzati sembrerebbe soprattutto nelle vene polmonari, ed a modificare il substrato atriale, riducendo con lesioni lineari eseguite su entrambe le camere atriali la massa "disponibile" a fibrillare. Recentemente, inoltre, è emerso anche il ruolo non trascurabile svolto dal sistema nervoso autonomo nella genesi della fibrillazione atriale, con forma favorite sia dall' ipertono simpatico che da quello vagale: di qui i tentativi di localizzare dapprima e successivamente di ablare i cosiddetti plessi ganglionati. Da queste premesse, si evince come il successo a lungo termine della procedura di ablazione nelle FA parossistiche e/o persistenti sia dato dalla corretta individuazione del meccanismo elettrogenetico della FA, in altri termini dalla comprensione di quale fattore giochi un ruolo preponderante (trigger, substrato, sistema neurovegetativo?) A titolo speculativo, è ipotizzabile che quanto più l' aritmia sia "radicata", come nel caso di forme persistenti ricorrenti - senza voler arrivare alle croniche, tanto più sia dipendente da alterazioni non più solo elettriche, ma morfostrutturali degli atri, cioè del substrato. Da ultimo, l' approccio ablativo alla fibrillazione atriale non va raccomandato, oltre che nei casi che non rispecchino le condizioni suddette, anche in quelli in cui la turba del ritmo sia secondaria a cause note non cardiache (ipertiroidismo, anemia, disionie) o cardiache ma a genesi diversa (canalopatie, malattia del nodo SA etc.)
|