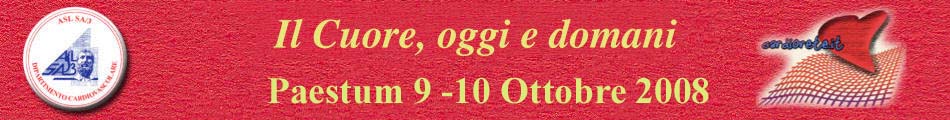
|
ANALISI MULTIFATTORIALE DEI FATTORI DI RISCHIO PER MORBILITA’ E MORTALITA’ NELLA CHIRURGIA DEL TRONCO COMUNE
Maurizio Cotrufo Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche 2° Università di Napoli Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare e Trapianti A.O. Monadi Napoli
Il tronco comune rappresenta il primo tratto della coronaria sinistra. Origina dal seno di Valsalva sinistro e decorre verso sinistra, anteriormente e verso il basso, tra il tronco dell’arteria polmonare e l’auricola dell’atrio sinistro. La lunghezza del vaso in genere non supera 1 cm. Il suo diametro varia a seconda del sesso e della superficie corporea, essendo nel sesso maschile 4.5 ± 0.5 mm e in quello femminile 3.9 ± 0.5 mm. Sono riconoscibili in esso tre porzioni diverse dal punto di vista anatomico, con importanti ripercussioni anche sulla fisiopatologia: l’ostio che origina dalla parete aortica, la porzione intermedia e il segmento distale che si biforca dando origine all’ arteria discendente anteriore e alla circonflessa. Nel 30% dei casi da' origine ad un terzo ramo intermedio. Per la peculiare situazione anatomica che vede la porzione ostiale circoscritta da fasci muscolari perpendicolarmente orientati provenienti dalla tonaca media dell’aorta, non vi può essere nelle fasi iniziali dello sviluppo della placca ateromasica in tale sede una dilatazione funzionale e compensatoria della parete arteriosa, risultando subito in un restringimento del lume con riduzione di flusso. Inoltre il tronco comune è un’ arteria molto ricca in tessuto elastico e questo lo rende unico in tutto l’albero coronarico. Questi fattori anatomici ed istologici possono spiegare il vasospasmo spontaneo o indotto del tronco comune durante le procedure interventistiche diagnostiche o terapeutiche. Una stenosi del tronco comune viene definita critica in base al criterio angiografico se comporta una riduzione del lume superiore al 50%. La prevalenza di lesioni critiche del tronco comune è stata riportata attorno al 9% nei pazienti sottoposti a chirurgia coronarica, 5% nei pazienti con angina cronica, 7% nei pazienti con infarto miocardico acuto. Tommaso e coll. hanno riportato un’incidenza di stenosi isolata del tronco comune dello 0,15%, similmente all’incidenza riportata da Miller e coll. Tra i 21.545 pazienti adulti studiati da Topaz e coll., che sono stati sottoposti ad angiografia coronarica, in 16 (0,07%) si è riscontrata una lesione stenotica isolata significativa (≥50%) del tronco comune. La causa principale di malattia del tronco comune è l’aterosclerosi. Aortite sifilitica, artrite reumatoide e arterite di Takayasu sono state riportate come cause di malattie coinvolgenti l’ostio del tronco comune. E’stata descritta un’aortite da radiazioni coinvolgente l’ostio coronarico nei pazienti che hanno subito terapia radiante mediastinica per linfomi e che in seguito hanno lamentato sintomi da angina pectoris. E’ stato dimostrato che la malattia calcifica della valvola aortica con calcificazioni estese può determinare l’ ostruzione dell’ostio del tronco comune. Per il passato, la malattia valvolare e la sostituzione valvolare aortica sono state responsabili di ostruzione ostiale. Lo stent di una bioprotesi, cosi come l’impianto di una protesi meccanica la cui misura sia stata sovrastimata possono ostruire l’ostio coronarico. Un’altra causa di lesione ostiale del tronco comune dopo sostituzione protesica di valvola aortica è il danno prodotto dalle cannule di perfusione coronarica usate durante la procedura chirurgica per la somministrazione della soluzione cardioplegica. La maggior parte di questi problemi correlati alla chirurgia sono ora molto infrequenti. Altra causa di lesione iatrogena è quella indotta dall’esecuzione di un angiografia o un’angioplastica per stenosi dell’arteria coronarica di sinistra. I meccanismi di sviluppo includono lesioni intimali con successiva proliferazione fibrocellulare causate dai cateteri guida o palloni dilatanti. Inoltre può verificarsi la dissezione del tronco comune prodotta acutamente durante la procedura di angioplastica e ciò può verificarsi sia se il tronco comune è il vaso bersaglio e sia se è il vaso di passaggio. Questa è una complicanza rara ma che frequentemente richiede l’esecuzione in emergenza di un bypass aortocoronarico. L’uso corrente di cateteri guida a punta flessibile può ridurre l’incidenza di questa complicanza e ridurre il trauma da catetere. Infine il tronco comune può essere interessato dall’avanzamento retrogrado di una restenosi post-PCI che si estende al segmento prossimale adiacente. Il gold standard per la diagnosi della malattia coronarica resta l’angiografia. Sebbene ad oggi la diagnosi di stenosi coronarica è imprescindibile dall’esecuzione di una coronarografia, è stata rilevata una correlazione insoddisfacente tra l’interpretazione angiografica e lo studio istologico. In particolar modo l’angiografia sottostimerebbe le lesioni diffuse del tronco comune e quelle localizzate all’ostio e alla biforcazione distale, sia per motivi anatomici ( la brevità del tronco comune specie in caso di malattia diffusa rende difficile l’identificazione di segmenti normali di riferimento), sia funzionali (esiste un rimodellamento “positivo” correlato alla crescita della placca con dilatazione della parete del vaso per preservare le dimensioni del lume), sia per una significativa variabilità inter e intra osservatore esistente nella valutazione angiografica. Per rispondere a queste problematiche alcuni autori hanno proposto l’utilizzo degli ultrasuoni intravascolari ( IVUS ) nei pazienti con refertazione angiografica di malattia del tronco comune ambigua o non conclusiva. L’IVUS fornisce un’immagine a sezione trasversale dettagliata delle arterie coronarie in vivo e consente uno studio dei cambiamenti dimensionali e anatomici che si verificano nell’arteria coronarica in corso di malattia aterosclerotica e dell’architettura della placca non altrimenti possibile. Se la diagnosi di malattia ostruttiva del tronco comune è confermata spesso è raccomandato un intervento chirurgico urgente. Ko e coll. hanno notato che 21 di 1.217 pazienti con ostruzione del tronco comune non sottoposti a rivascolarizzazione in emergenza sono deceduti in meno di due giorni dopo l’angiografia coronarica. I fattori predittivi di morte precoce post angiografia in pazienti con malattia del tronco comune sono l’età avanzata, III o IV classe NYHA, angina instabile di breve insorgenza, elevata pressione ventricolare tele- Tabella 1: Caratteristiche cliniche dei 351 pazienti del campione
diastolica, bassa frazione d’eiezione e significativa malattia dell’arteria circonflessa sinistra. Casistica del Centro Dalle cartelle cliniche dei pazienti operati di rivascolarizzazione coronarica dal 01 gennaio del 2001 al 31 dicembre del 2007 presso la Cattedra di Cardiochirurgia del Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie della Seconda Università di Napoli, sono stati raccolti retrospettivamente i dati clinici pre, intra e post operatori di 351 pazienti (84.6% di sesso maschile) di età media di 64±9.8 anni affetti da malattia coronarica del tronco comune della coronaria sinistra isolata o associata a malattia coronarica periferica. I dati ottenuti sono stati informatizzati in un database clinico dedicato. Le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti sono illustrate nella tabella 1. Risulta chiaro che si tratta di una popolazione estremamente eterogenea per il fattore età con un ampio range di distribuzione: anche se il valore medio è conforme ai valori attesi, circa il 13% della popolazione è costituito da ultrasettantacinquenni. La patologia è quasi esclusiva al sesso maschile. Per quanto riguarda i fattori di rischio specifici (tabella 2), la prevalenza di pregressi IMA e/o di IMA in atto è molto consistente (>40%) e sebbene il numero dei pazienti con severa disfunzione basale del ventricolo sinistro (F.E<35%) non è superiore a quello di casistiche generali di riferimento, una ulteriore quota di pazienti con funzione ventricolare basale preservata presentava segni e sintomi di angina instabile o di sindrome coronarica acuta in evoluzione che hanno richiesto un esteso uso di presidi (eparina in infusione continua, nitrati in infusione continua, contropulsazione aortica) nella fase pre-operatoria. In ciò si concretizza l’elevato valore medio dell’Euroscore con oltre il 50% della popolazione collocato in area di Tabella 2: Fattori di rischio cardiaci
rischio medio- alto. Interessante eterogeneità si è osservata nella distribuzione delle lesioni aterosclerotiche: alla presenza comune di una severa coronaropatia periferica (oltre il 50% dei pazienti presentava all’esame angiografico una malattia di 2 o 3 vasi coronarici associata alla lesione sul tronco comune ed il 23% con lesioni estese alla periferia distale) si associa un consistente numero di pazienti (16%) con lesioni critiche del TCCS >90% anche senza lesioni periferiche (12.3%). Di conseguenza, il numero degli interventi eseguiti in regime di urgenza/emergenza è risultato molto consistente (>70%). La mortalità ospedaliera è risultata essere del 8% (28/351 pazienti) e riconosce in più dell’80% dei casi una causa cardiaca primaria. L’analisi univariata sul rischio di mortalità a breve termine identifica nell’età avanzata, nel sesso femminile, nelle elevate categorie di rischio Euroscore, nella Tabella 3: Variabili operatorie
ridotta FE, nell’infarto miocardico pregresso, nella sindrome coronarica acuta, nella entità severa della stenosi del TC (70-90%), nell’associazione con lesioni su coronaria destra, nella indicazione chirurgica di emergenza, nel numero di anastomosi prossimali eseguite e nei tempi di CEC i fattori prognostici primari di rischio statisticamente significativi; fattori di rischio secondari sono stati identificati nella incompleta rivascolarizzazione della piastra ischemica e nel limitato uso del graft in mammaria interna sinistra. Non è stata notata inferenza statistica significativa per ciò che concerne la sede di lesione del TCCS e per il tipo ed estensione della malattia coronarica associata sebbene, nella casistica generale, l’assenza di una coronaropatia periferica sia stata una condizione anatomica generalmente favorevole rispetto a tutte le altre possibilità (tabelle 2-3). L’analisi multivariata logistica condotta sulle variabili risultate significative all’analisi univariata riconosce, all’ultimo step, l’età avanzata (OR 1.06), il sesso femminile (OR 3.1) e la indicazione chirurgica di emergenza (OR 4.7) come variabili indipendenti fortemente significative e predittive sul rischio cumulato di mortalità della popolazione. Rilevante è il valore protettivo della normale funzione ventricolare pre-operatoria (OR 0.92). E’ da notare che le variabili menzionate sono tutte comprese nel modello Euroscore e che nell’analisi finale tale variabile è stata sottratta per l’evidente effetto di ridondanza statistica. A scopo descrittivo si precisa però che la mortalità osservata nella categoria di rischio elevato è risultata essere del 18,3% a fronte del confortante 3.7% delle categorie a rischio basso e medio indipendentemente dal tipo di presentazione anatomica coronarica e clinica. Complicanze post-operatorie lievi o gravi (tabella 4) sono insorte in circa il 18% dei pazienti con una incidenza più frequente della sindrome da bassa gittata post-operatoria o di IMA (15.6%); l’incidenza di complicanze invalidanti (stroke ed IRA) ha raggiunto in media valori inferiori al 5%. L’adozione di una temporanea assistenza ventricolare mediante contropulsatore aortico, per il raggiungimento di una stabilizzazione emodinamica dei pazienti nelle fasi peri-operatorie, si è resa necessaria nel 18% dei casi. Il tempo medio di degenza totale è stato significativamente più lungo rispetto a quelli di ampie casistiche di riferimento ma
Tabella 4: Complicanze
Tabella 5: Analisi multivariabile su rischio di mortalità ed evento cardiaco
in linea con il riscontro dell’elevata incidenza di eventi cardiaci combinati riscontrate in questa popolazione (87/351; 24.8%). L’analisi multivariata sul rischio di evento cardiaco cumulato riconosce le variabili età avanzata (OR 1.04), sesso femminile (OR 3.07) e sindrome coronarica acuta (OR 2.25) come fattori indipendenti di rischio significativi. Anche in questo caso la normale funzione ventricolare pre-operatoria risulta in un significativo fattore protettivo (OR 0.93).
Discussione e Conclusioni I risultati più importanti emersi da questo studio confermano dati già emersi dalla ampia letteratura sul rischio chirurgico associato alla chirurgia coronarica. Nonostante i progressi compiuti nelle strategie di protezione e rivascolarizzazione miocardica il trattamento delle coronaropatie coinvolgenti il TCCS presenta un rischio più elevato e consistente di eventi cardiaci complessivi perioperatori e di mortalità. Il gruppo di pazienti scelto per questo studio però ha presentato peculiari motivi di interesse a causa della spiccata eterogeneità di fattori demografici, clinici ed anatomici che non ha reso possibile una efficace analisi dei sottogruppi per una notevole frammentazione dei dati. Nel complesso sono emersi fattori già noti che esprimono il rischio generico e specifico di una popolazione esposta all’area di competenza cardiochirurgica come dimostrato dalla efficace stratifi-cazione operata dal modello predittivo Euroscore in uso presso la nostra divisione. Non sono emersi fattori anatomici di distribuzione ed entità di lesione aterosclerotica chiaramente associabili ad un incremento del rischio chirurgico. Occorre però segnalare che due tipologie di presentazione anatomica coronarica hanno dimostrato, singolarmente considerate, caratteristiche peculiari: la malattia isolata del TC, anche con stenosi critica, indipendentemente dalla sede anatomica e dalla entità della lesione è generalmente associata ad una buona prognosi chirurgica; viceversa, ed in maniera inattesa, una stenosi significativa ma non critica del TC (70-90%) indipen-dentemente dalla sede anatomica ma in presenza di malattia periferica anche non critica è associata ad un incremento di mortalità e degli eventi complessivi cardiaci. Questi due elementi non sono in contraddizione perchè associati nella casistica esaminata a diverse presentazioni cliniche. Nel gruppo di pazienti con stenosi significativa del TC e malattia periferica si concentrano una serie di fattori di criticità clinica come un incremento significativo delle sindromi coronariche acute, spesso associate ad una ridotta funzione ventricolare, un più largo uso di presidi (nitrati in infusione continua, uso di IABP) e conseguentemente un maggior numero di interventi eseguiti in regime di urgenza od emergenza con esito in rivascolarizzazioni incomplete. Viceversa i pazienti con malattia isolata del tronco comune anche critica hanno generalmente avuto una fase clinica preoperatoria più stabile, presentano di sovente una funzione ventricolare nella norma, raramente subiscono rivascolarizzazioni incomplete. Si potrebbe ipotizzare che la distribuzione o l’entità delle stenosi angiografiche siano il riflesso della quantità di riserva coronarica funzionale complessiva o regionale che nella clinica si sono palesate nelle sindromi acute e nell’instabilità emodinamica. Gli elementi di criticità sono quindi rappresentati nel modello da quelle condizioni cliniche di urgenza od emergenza indifferibile che fungono da comune denominatore e che sono chiaramente associati ad un incremento di incidenza degli eventi complessivi a dispetto di una eterogenea anatomia delle lesioni coronariche. Determinante è invece il ruolo della disfunzione ventricolare sinistra acuta o cronica: il ruolo protettivo svolto dalla normale funzione ventricolare racchiude in sintesi tutte le condizioni cliniche riscontrate in grado di determinare una ridotta frazione d’eiezione del ventricolo sinistro: esaurimento della riserva coronarica, pregressi infarti ripetuti, IMA in atto, impossibilità anatomica di rivascolarizzazione della intera piastra ischemica; tali condizioni ricorrono più di frequente nei pazienti anziani, con una lunga storia di cardiopatia ischemica sintomatica, che giungono al tavolo operatorio dopo i fallimenti della terapia medica ed con un quadro coronarografico di diffusa malattia aterosclerotica. Per ciò che concerne il sesso femminile in questo gruppo di pazienti la stima del rischio attribuisce un odds ratio di circa 3.1 rispetto ai corrispettivi pazienti maschi compresi nel campione con una frequenza relativa dei decessi del 32.1%; la letteratura medica specifica si è spesso confrontata con risultati simili ed è attualmente incerto se il sesso femminile, nei vari case-mix, rappresenti un fattore demografico rilevante ai fini della prognosi dei pazienti coronaropatici; bisogna rilevare però che, quando in ampie casistiche si è confrontata la prognosi dei pazienti riguardo alla variabile sesso correggendo statisticamente i dati in relazione all’indice di massa corporea ed all’età, non si sono accertate differenze statisticamente significative. La più alta frequenza relativa dei decessi dei pazienti di sesso femminile nei dati grezzi è quindi stata messa in relazione al fattore anatomico coronarico che, a parità di indice di massa corporea ed età, conferisce al sesso femminile uno svantaggio in termini di run-off distale nelle coronarie native in rapporto alle entità ed alla distribuzione delle stenosi coronariche ed ai flussi attraverso i grafts. In conclusione i risultati della chirurgia di rivascolarizzazione coronarica in un setting prevalentemente di urgenza/emergenza chirugica e su pazienti eterogenei con quadro estremo di cardiopatia ischemica è da considerarsi soddisfacente anche se la nostra analisi ha solo in parte identificato fattori clinici modificabili con interventi tecnici ipotizzabili. Attualmente riteniamo che la migliore strategia sia la preservazione di una normale funzione ventricolare sia con un uso più esteso dei presidi terapeutici (anche invasivi) e sia con l’adozione scrupolosa di metodi di protezione miocardica intraoperatori soprattutto nei pazienti di età avanzata e di sesso femminile o con ridotta funzione ventricolare. Riteniamo infine che l’analisi della casistica abbia chiaramente dimostrato che il riferimento anatomico può essere fallace nella prognosi ospedaliera se estrapolato dal rischio chirurgico generico o dalla clinica e che un approccio attendistico nel timing chirurgico non apporti al paziente sostanziali benefici anche nei casi apparentemente stabili dal punto di vista clinico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||