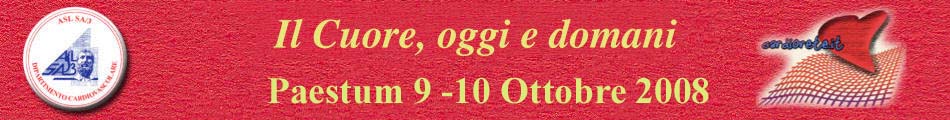
|
La Sindome Tako-Tsubo: come riconoscerla come trattarla
Rodolfo Citro, Marco M. Patella, Gennaro Provenza, Luigi Petraglia, Giuseppe Bottiglieri, Ilaria Caso, Giovanni Gregorio. U.O. UTIC-Cardiologia, Osp. S. Luca, Vallo della Lucania
Definizione La sindrome tako-tsubo (TTS) è un entità nosologica caratterizzata da disfunzione ventricolare sinistra transitoria e reversibile solitamente indotta da uno stressor emotivo e/o fisico. Le caratteristiche clinico-elettrocardiografico-laboratoristiche (dolore toracio e/o dispnea, anomalie della ripolarizzazione ventricolare ed aumento degli enzimi miocardiospecifici) simili a quelle di un infarto miocardio acuto, l’hanno resa, e la rendono ancora, spesso sottodiagnosticata e confusa con una più classica sindrome coronarica acuta. I criteri diagnostici, che ci permettono di differenziarla dalla sindrome coronarica acuta, sono : presenza di un evento scatenante, lieve aumento degli enzimi di miocardionecrosi, assenza di coronorapatia significativa , anomalie della cinetica segmentaria estese a territori non irrorati da una singola coronaria e recupero completo nel giro di settimane o mesi della funzione sistolica ventricolare sinistra.
Cenni storici ed epidemiologici Nel 1991 una sindrome caratterizzata da disfunzione ventricolare sinistra come conseguenza di uno stress fisico e/o emotivo veniva descritta, nella letteratura giapponese, con il termine di “takotsubo cardiomyopathy” (1) , per la somiglianza ventricolografica del ventricolo sinistro con il vaso usato dai pescatori giapponesi per catturare i polipi. Fino alla fine degli anni ’90 questa sindrome veniva descritta solo nella letteratura giapponese. A partire dall’inizio di questo decennio anche la letteratura occidentale ha cominciato ad interessarsene con un numero crescente di pubblicazioni e definendola anche con termini diversi, transient left ventricular apical balloning and broken heart sindrome (4). Il termine stress cardiomyopathy sembra essere particolarmente adatto in quanto sottolinea l’importanza del fattore precipitante (lo stress psico/fisico) e la collega con la conseguente disfunzione ventricolare sinistra. La TTS colpisce molto frequentemente le donne in età post-menopausale
Patogenesi Molte sono le tesi proposte in letteratura circa la patogenesi della TTS. Il link con un evento stressante ha focalizzato l’attenzione su un possibile ruolo centrale della catecolamine; in effetti molti studi hanno evidenziato come esista un loro aumento nel plasma nei pazienti con SC. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che la SC può essere scatenata dall’attività ormonale di tumori catecolamino-secernenti o dall’infusione di catecolamine esogene. Diverse, inoltre, sono le teorie su come le catecolamine possano portare ad una transitora disfunzione ventricolare sinistra “stunning “ miocardico.
Reperti clinici I pazienti con SC si presentano spesso con un quadro clinico sovrapponibile a quello di un infarto miocardico acuto (dolore toracico e/o la dispnea), ma anche, e non di rado, anche in edema polmonare acuto e/o shock cardiogeno o con tachicaritmie ventricolari). Sono stati riportati in letteratura anche casi di ictus cardioembolico, di formazione di trombi apicali, di rottura della parete libera del ventricolo sinistro e di pericardite. L’evento scatenante può essere rappresentato da uno stress fisico e/o emotivo, anche se in alcuni casi non è possibile individuarne alcuno. Diversi stressor emotivi e/o fisici possono rappresentare l’evento scatenante della TTS. Tra i più frequenti riportati in letteratura sono la perdita di persone care, liti, le perdite finanziarie, un intenso sforzo fisico, gli incidenti stradali. L’evento scatenante, tuttavia , può essere rappresentato anche da altre emergenze medico-chirurgiche come una crisi respiratoria, l’ipoglicemia, uno stato ipotensivo da emorragia gastrointestinale o da anche procedure endoscopiche o chirurgiche. Nella nostra esperienza abbiamo riportato anche casi indotti da infusione di ergonovina nel post-partum (5) e conseguenti a sindrome da annegamento (6,7).
Quadro clinico strumentale e laboratoristico I pazienti con TTS possono presentarsi con varie anomalie elettrocardiografiche sovrapponibili a quelle che compaiono in una sindrome coronarica acuta, similitudine che spesso induce ad intraprendere l’iter diagnostico-terapeutico tipico di una sindrome coronarica acuta ( studio coronarografico urgente, fibrinolisi , etc) (9). Tra di esse molto frequente è la presenza di sopraslivellamento del tratto ST, specie nelle derivazioni precordiali, in assenza di sottoslivellamento speculare. Altre anomalie di comune riscontro sono l’inversione dell’onda T nelle precordiali, la comparsa di onde Q patologiche o complessi QS e la mancata progressione dell’onda R nelle precordiali (6). L’inversione dell’onda T può essere sia la presentazione elettrocardiografica iniziale, soprattutto nei pazienti con la forma classica di TTS ovvero con “left ventricular apical balloning” ma più spesso rappresenta l’evoluzione del sopraslivellamento del tratto ST o di un ECG iniziale non diagnostico, potendo permanere anche per alcuni mesi dopo la fase acuta. Un’altra anomalia molto spesso presente è l’allungamento dell’intervallo Q-Tc, che però di solito non è responsabile di aritmie ipercinetiche tipo torsione di punta (6-9) L’aumento degli enzimi di miocardio necrosi è di minore entità e con una più rapida discesa nel range di normalità rispetto a quello visto nell’infarto miocardico acuto, e non è proporzionale all’entità delle anomalie della cinetica segmentaria all’ecocardiogramma (6-9). Il quadro ecocardiografico mostra una ridotta frazione d’eiezione (FE) del ventricolo sinistro (di solito <40%), con una peculiare distribuzione delle dissinergie contrattili, consistente in a-discinesia dei segmenti medio-apicali, con spessore di parete conservato, ed ipercontrattilità dei segmenti basali. La FE e le anomalie contrattili ritornano normali in un tempo variabile da alcuni giorni ad alcuni mesi. Nella TTS vi è un graduale recupero della funzione ventricolare sinistra che si completa entro 4-6 settimane. Quando ciò non accade deve essere presa in considerazione una diagnosi alternativa (6) Il quadro clinico, elettrocardiografico e laboratoristico porta quasi sempre, ove possibile, all’esecuzione di un’angiografia coronarica, nella quale non vengono evidenziate ostruzioni coronariche significative Il quadro ventricolografico più frequente è rappresentato dall’ipercontrattilità dei segmenti basali con a-discinesia dei segmenti medi ed apicali (transiente apical balloning) , tuttavia, in un minor numero di casi, viene evidenzita una a-discinesia dei segmenti medi ed una ipercontrattilità di quelli apicali e basali. In quest’ultimo caso di parla di “transient midventricular ballooning”, di solito i pazienti sono più giovani e vanno incontro meno raramente a compromissione emodinamica.
Trattamento La terapia deve essere guidata dal quadro clinico iniziale e dal grado di compromissione emodinamica. Alcuni autori propongono di utilizzare la terapia anticoagulante orale per la prevenzione della formazione di trombi nella forma più classica di TTS (6). Spesso vi è ostruzione all’efflusso ventricolare sinistro e ciò controindica l’uso di agenti inotropi, facendo propendere verso l’uso del contropulsatore nei pazienti con instabilità emodinamica., altrimenti potrebbe essere utile l’uso di betabloccanti. Non ci sono evidenze in letteratura sull’uso, dopo il completo recupero della funzione ventricolare sinistro, di ACE-inibitori e beta-bloccanti. La prognosi della TTS è generalmente favorevole (mortalità ospedaliera 3,7%) e rare sono le recidive (1,7%) (9)
Considerazioni conclusive In pochi anni la TTS è divenuta un’entità nosologica ben definita. E’ necessario che i medici, e non solo i cardiologi, considerino questa sindrome in pazienti con quadro clinico suggestivo di sindrome coronarica acuta. Inoltre sono necessari ulteriori studi per meglio definire la patogenesi di questa sindrome al fine di individuare i fattori predisponenti.
BIBLIOGRAFIA
1. Satoh H, Tateishi H, Uchida T, et al.: Takotsubo-type cardiomyopathy due to multivessel spasm. In Clinical Aspect of Myocardial Injury: From Ischemia to Heart Failure [in Japanese]. Edited by Kodama K, Haze K, Hon M. Tokyo: Kagakuhyouronsya; 1990:56–64. 2. Tsuchihashi K, Ueshima K, Uchida T, et al.: Transient left ventricular apical ballooning without coronary artery stenosis: a novel heart syndrome mimicking acute myocardialinfarction. Angina Pectoris-Myocardial Infarction Investigations in Japan. J Am Coll Cardiol 2001, 38:11–18. 3. Park JH, Kang SJ, Song JK, et al.: Left ventricular apical ballooning due to severe physical stress in patients admitted to the medical ICU. Chest 2005, 128:296–302. 4. Wittstein , Acute Stress Cardiomyopathy, Current Heart Failure Reports 2008, 5:61–68 5. Citro R, Pascotto M, Provenza G, Gregorio G, Bossone E. Transient left ventricular ballooning (tako-tsubo cardiomyopathy) soon after intravenous ergonovine injection following caesarean delivery. Int J Cardiol. 2008 Aug 14. [Epub ahead of print] 6. Citro R, Patella MM, Bossone E, Maione A, Provenza G, Gregorio G. Near-drowning syndrome: a possible trigger of tako-tsubo cardiomyopathy. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2008 May;9(5):501-5. 7. Citro R, Previtali M, Bossone E. Tako-tsubo cardiomyopathy and drowning syndrome: is there a link? Chest. 2008 Aug;134(2):469. 8. Citro R, Galderisi M, Maione A, Innelli P, Provenza G, Gregorio G. Sequential transthoracic ultrasound assessment of coronary flow reserve in a patient with Tako-tsubo syndrome. J Am Soc Echocardiogr. 2006 Nov;19(11):1402.e5-8. 9. Gianni M, Dentali F, Grandi AM et al. Apical balloning syndrome or takotsubo cardiomyopathy: a sistematic review. European Heart J, 2006; 27: 1523-29. 10. Ogura R, Hiasa Y, Takahashi T, et al.: Specific findings of the standard 12-lead ECG in patients with ‘Takotsubo’ cardiomyopathy: comparison with the findings of acute anterior myocardial infarction. Circ J 2003, 67:687–690.
|