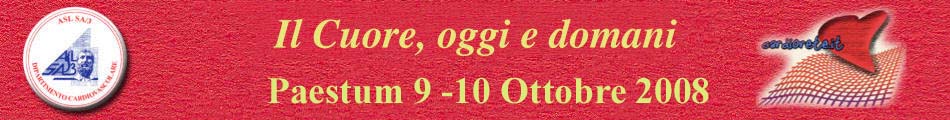
|
Resincronizzazione cardiaca:le indicazioni certe e quelle possibili
Andrea Campana Dipartimento “Cuore”Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona SALERNO
Lo scompenso cardiaco è tra le più importanti cause di morte nei paesi industrializzati. La prevalenza è di 3-20 casi per 1000 soggetti, raggiungendo i 100 casi per 1000 nell’età>65 anni; l’incidenza annuale è di 1-5 nuovi casi per mille, raddoppiandosi per ogni decade di età oltre i 45 anni (1,2,3). Tali dati spiegano come lo scompenso cardiaco sia responsabile del 5-10% di tutte le ospedalizzazioni; in particolare, si stima che in Italia, ogni anno, vengano ricoverati 65000 pazienti con questa diagnosi (3). Il 30% circa dei pazienti con scompenso presenta una compromissione funzionale cardiaca di grado avanzato ( classe III-IV NYHA), con prognosi infausta a breve-medio termine: la mortalità annuale è del 24.8% nei soggetti in classe NYHA III e del 36.7% in quelli in classe IV; inoltre, mentre nei pazienti in classe NYHA II la mortalità risulta essere prevalentemente di tipo improvviso aritmico, nelle classi più avanzate essa è legata alla progressione della disfunzione ventricolare (4). Benché la progressiva introduzione nella terapia dello scompenso di farmaci come gli ACE-inibitori, i beta-bloccanti, lo spironolattone, abbia migliorato la sintomatologia dei pazienti scompensati, la loro prognosi rimane deludente; per tale motivo vi è stato un crescente interesse scientifico sui fattori clinici e strumentali che potessero ricoprire un ruolo nel deterioramento della meccanica cardiaca, come ad esempio i ritardi della conduzione; il blocco di branca sinistra (BBS) è presente in oltre il 30% dei pazienti in classe III-IV NYHA(5) ed è responsabile di importanti alterazioni della cinetica ventricolare sinistra e della sincronia di contrazione tra i due ventricoli (6). Sulla base di tali considerazioni fisiopatologiche, era stato ipotizzato che la stimolazione artificiale precoce della parete ventricolare sinistra potesse essere capace di ripristinare l’attivazione sincrona tra setto e parete libera, con ripercussioni positive sulla meccanica ventricolare, agendo anche sulla componente funzionale dell’insufficienza mitralica, a sua volta determinata dall’asincrona contrazione dei muscoli papillari. I primi tentativi di stimolare il ventricolo sinistro furono effettuati mediante elettrodo epicardico da Cazeau e Coll. nel 1994 (7); successivamente, Daubert e Coll. introdussero la stimolazione transvenosa del ventricolo sinistro in una casistica di 47 pazienti con QRS>150 msec, denominando tale approccio “terapia di resincronizzazione cardiaca” ( CRT) (8). Studi in acuto dimostrarono effetti senza dubbio favorevoli sui parametri emodinamici di funzione sistolica ventricolare sinistra; successivi “trials” controllati evidenziavano benefici sui sintomi, sulla morbilità e sulla mortalità; tali benefici apparivano correlati alla durata basale del QRS e alla ottimizzazione degli intervalli A-V e V-V, benchè studi con ampie casistiche evidenziassero una percentuale non trascurabile di “non responders” (9). Partendo da tali premesse, l’attenzione dei ricercatori si è andata concentrando sulla ricerca di parametri ecocardiografici in grado di definire accuratamente il grado di dissincronia elettromeccanica, localizzando la parete ventricolare più ritardata; sono stati individuati numerosi indici di ritardo intra ed interventricolare, misurati con ecocardiografia tradizionale, “Doppler Myocardial Imaging”, “Strain Imaging” ed ecocardiografia tridimensionale. L’uso di tali parametri, insieme alla presenza di fattori clinico-elettrocardiografici, consistenti nella presenza di BBS con durata del QRS tra 120 e 150 msec, frazione di eiezione ventricolare sinistra (FE) ridotta (30-35%) e sintomi di insufficienza cardiaca nonostante terapia medica ottimizzata, è servito ad individuare i pazienti con indicazione alla CRT. Tuttavia, uno studio multicentrico recente ha dimostrato che, benché alcuni parametri potessero predire in maniera statisticamente significativa un miglioramento clinico e lo sviluppo di un rimodellamento inverso del ventricolo sinistro, la sensibilità e la specificità di essi appariva piuttosto modesta; i risultati del PROSPECT suggeriscono che le varie misure ecocardiografiche usate in questo studio per definire la dissincronia ventricolare, sono state inefficaci nel distinguere i “responders” dai “ non responders” e non dovrebbero costituire un elemento decisivo nel processo di “decision making” (11). A fugare ogni dubbio sulla consolidata importanza della CRT, una recente metanalisi su sei grandi studi, ha dimostrato che essa riduce la mortalità per ogni causa del 28% e la riospedalizzazione per peggioramento dell’insufficienza cardiaca del 37% in pazienti con scompenso cronico ( 12). Le linee-guida 2008 dell’ American College of Cardiology/American Heart Ass./ Heart Rhythm Society indicano la terapia di resincronizzazione in Classe I con livello di evidenza A per i pazienti con sintomi gravi di insufficienza cardiaca che abbiano FE ≤ 35%, un QRS di durata ≥ 120 msec, ritmo sinusale ed una classe funzionale NYHA III o IV nonostante una terapia medica ottimale (13). Tale tipologia di pazienti è quella dalla quale ci si aspetta il migliore risultato dalla CRT; difatti, in questo caso, la stimolazione biventricolare viene guidata dall’attività sinusale, potendo ottenere, in tal modo, un aggiustamento non solo dei tempi di attivazione V-V, ma anche la non trascurabile opportunità di regolare un intervallo A-V ottimale. Tuttavia, le stesse linee-guida prevedono , in Classe IIA, due altre categorie di pazienti suscettibili di CRT: la prima, con livello di evidenza B, è quella dei pazienti in fibrillazione atriale (FA) e con restanti caratteristiche identiche a quelle dei soggetti con indicazione di classe I; la seconda categoria, con livello di evidenza C, è quella dei pazienti in Classe NYHA III-IV e con F.E.≤ 35% e che abbiano dipendenza frequente dal “pacing” per un blocco atrio-ventricolare avanzato ( il QRS largo di base non è una condizione necessaria per questa indicazione). Nel primo caso, benchè un trend verso il miglioramento della sopravvivenza e la riduzione delle riospedalizzazioni sia stato dimostrato in pazienti con FA trattati con CRT (14), vi è necessità di una maggiore quantità di studi randomizzati per dimostrare che tale terapia possa produrre un significativo beneficio in questa categoria di pazienti.
Nei pazienti che necessitano di
elettrostimolazione permanente, una strategia “ minimamente
desincronizzante”, soprattutto in quelli con segni di
compromissione funzionale del ventricolo sinistro, sarebbe una
scelta desiderabile (15) ; due studi controllati inerenti questo
argomento, il BIOPACE ed il BLOCK-HF Study, daranno delle
risposte più sicure nel giro di qualche anno. Nell’attesa, la
CRT potrebbe essere applicata ai pazienti anche senza BBS, che
necessitino di “pacing” permanente per blocco atrio-ventricolare
totale e che rispondano alle caratteristiche previste dalle
linee-guida ACC/AHA/HRS, che, a questo proposito, coincidono con
quelle dell’ESC. In un recente studio di Shimano e Coll., la
CRT si è rivelata efficace nel risolvere segni clinici e
strumentali di insufficienza cardiaca, sviluppatasi dopo un
lungo periodo di stimolazione apicale destra in 19 pazienti
stimolati per blocco atrio-ventricolare (BAV) primitivo (16).
La CRT trova una indicazione emergente nelle cardiopatie congenite, laddove la correzione chirurgica abbia dato esito ad un BAV completo o ad un prolungamento patologico dell’intervallo HV ( situazione che può esitare nello sviluppo successivo di morte improvvisa), o anche come ponte al trapianto cardiaco, quando ci si trovi in presenza di evidenti manifestazioni cliniche di insufficienza cardiaca (18).
BIBLIOGRAFIA
1) Cowie MR, Mosterd A, Wood DA et Al. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J 1997; 18: 208-225. 2) Massie BM, Shah NB. Evolving trends in the epidemiologic factors of heart failure: rationale for preventive strategies and comprehensive disease management. Am Heart J 1997; 133: 703-12. 3) Achilli A, Patruno N, Pontillo D et Al. La terapia di resincronizzazione cardiaca per il trattamento dello scompenso cardiaco. Ital Heart J Suppl 2004; 5(6): 445-456. 4) The SEOSI Investigators. Survey on heart failure in Italian hospital cardiology units. Results of the SEOSI Study. Eur Heart J 1997; 18: 1457-64. 5) Uretsky BF, Sheahan RG. Primary prevention of sudden cardiac death in heart failure: will the solution be shocking? J Am Coll Cardiol 1997; 30: 1589-97. 6) Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T et Al. For the Multisite Stimulation in Cardiomyopathies (MUSTIC) Study Investigators. Effects of multisite biventricular pacing in patients with heart failure and intraventricular conduction delay. N. Engl J Med 2001; 344: 873-80. 7) Grines CL, Bashore TM, Boudulas H et Al. Functional abnormalities in isolated left bundle branch block. The effect of interventricular asynchrony. Circulation 1989; 79: 845-53. 8) Cazeau S, Ritter P, Bakdach S et Al. Four chamber pacing in dilated cardiomyopathy. Pacing Clin Electrophysiol 1994; 17(Part2): 1974-9. 9) Daubert JC, Ritter P, Lazarus A et Al. Permanent left ventricular pacing with transvenous leads inserted into the coronary veins. Pacing Clin Electrphysiol 1998; 21(Part 2): 239-45. 10) Abraham WT, Fisher WG, Smith Al et Al for MIRACLE Study Group, Multicenter InSync Randomized Clinical Evaluation. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med. 2002; 346: 1845-1853. 11) Chung E.S., Leon A.R., Tavazzi L. et Al Results of the Predictors of Response to CRT (PROSPECT) Trial. Circulation 2008; 117: 000-000 12) Rossi A., Rossi G, Piacenti M et Al. The current role of cardiac resynchronization therapy in reducing mortalità and hospitalization in heart failure patients: a meta-analysis from clinical triuals. Heart Vessels 2008; 23: 217-223. 13) ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: A Report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines ( Writing Committee to revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices) Developed in Collaboration With the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons.JACC 2008 May 27 ; 51: e1-62. 14) Molhoek SG, Bax JJ, Blecker GB. Comparison of response to cardiac resynchronization therapy in patients with sinus rhythm versus chronic atrial fibrillation. Am J Cardiol 2004; 94: 1506-1509. 15) Funck RC, Kolsch S, Maisch B. Biventricular Stimulation for AV block. Herzschrittmacherther Elektrophysiol 2008 Mar; 19(1):41-7. 16) Shimano M, Tsuji Y, Yoshida Y et Al. Acute and chronic effects of cardiac resynchronization in patients developing heart failure with long-term pacemaker therapy for acquired complete atrioventricular block. Europace 2007 Oct; 9(10): 869-74 17) Haghjoo M, Bagherzadeh A, Farahani MM. Significance of QRS morphology in determining the prevalence of mechanical dyssynchrony in heart failure patients eligible for cardiac resynchronization: particular focus on patients with right bundle branch block with and without cexistent left-sided conduction defects. Europace 2008 May; 10(5) 566-71
18)
Villain E. Indications for pacing in patients with
congenital heart disease. Pacing Clin Electrophysiol. 2008 feb;
31 Suppl 1:s17-20. |