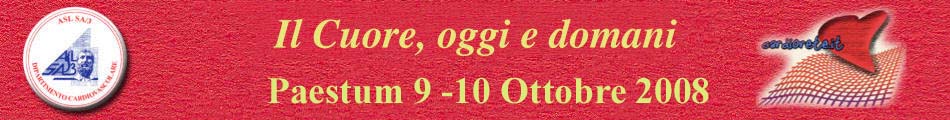
|
LE S.C.A CON ST “ELEVATO”: L’ESPERIENZA DEL REGISTRO R.O.S.A.
Aloia Antonio, Maria Maddalena, Materazzo, Igino Oppo, Filippo Gatto, Giuseppe Bottiglieri, Raffaele Rotunno, Genny Rinaldi, Giovanni Gregorio Dipartimento Cardiovascolare Asl SA 3 Vallo della Lucania
Le S.C.A. con ST elevato nel Registro R.O.S.A. Dal 1 Maggio 2007 al 30 Aprile 2008 sono stati arruolati 205 pazienti con S.C.A. con ST Elevato, pari al 27.7% di tutte le S.C.A. arruolate.
L’85,3% dei pazienti ricoverati per Sindrome Coronarica Acuta nelle nostre U.O. UTIC è residente nell’Asl SA3, il 10,4% proviene dalle restanti Asl della Regione Campania, il 3,1% proviene da altre Regioni d’Italia e l’1,2% risiede all’estero
I 205 pazienti ST “Elevation” arruolati nel Registro R.O.S.A. risultano così distribuiti nelle UTIC della nostra ASL SA/3
L’identikit dei 205 pazienti con ST “Elevation”, arruolati nel registro in questi dodici mesi, può essere così definito: età media di 67+13.8 anni, prevalenza del sesso maschile (69.8%) rispetto al sesso femminile (30.2%), modesto livello di scolarizzazione (diploma scuola elementare per il 47% dei pazienti) (Fig. 2). I pazienti in attività lavorativa sono circa un terzo, per due terzi si tratta di pazienti pensionati.
Dati Anamnestici Dei pazienti arruolati il 31.2% riferiva familiarità positiva per cardiopatia ischemica; il 14.6% affermava di essere già affetto da cardiopatia ischemica, il 6.3% riferiva un infarto del miocardio pregresso, l’11.2% episodi di angina pectoris, il 3.9% di essere già stato sottoposto a PTCA e lo 0.5% a BAC; lo 0.5% affermava storia di scompenso cardiaco; l’6.3% riferiva episodio pregresso di TIA e il 2.4% vascolopatia periferica; infine l’1.5% riferiva malattia ulcerosa, l’8.8% insufficienza renale e il 5.8% fenomeni di allergia. Solo il 4.4% riferiva ricovero ospedaliero recente.
Fattori di rischio Un ruolo di primo piano ovviamente è riservato nel Registro R.O.S.A. alla valutazione dei fattori di rischio. Dall’analisi dei dati è emerso che il 18.5% dei pazienti era obesa, il 28.8% presentava obesità viscerale; il 34.6% era affetto da ipercolesterolemia, il 6.8% da ipertrigliceridemia, il 22.9% da diabete mellito, il 38.5% da ipertensione arteriosa. Il 34.1% era fumatore di sigarette, il 25.4% dichiarava di aver smesso di fumare da oltre un anno, mentre il 7.8% riferiva di aver smesso da meno di un anno. Infine lo 0.5% riferiva di far uso di sostanze stupefacenti.
Sintomatologia di Esordio La sintomatologia all’esordio è stata: v tipica: 70.2% dei casi rispetto all’ 80 % del Blitz 1 v atipica: 6.8% rispetto all’11% del Blitz 1 v epigastralgia : 13.2 % v sincope: 4.9% v dispnea: 5.4 % v edema polmonare acuto: 1% v sintomatologia assente: 4.9% v altro: 9,1 % Di tutti i pazienti arruolati lo 0.5% ha presentato arresto cardiaco prima dell’ingresso in ospedale, l’ 1.5% prima dell’ingresso in UTIC. Di questi l’1% ha richiesto D.C. shock e 1.5% solo manovre di RCP.
Luogo di Esordio della Sintomatologia Il luogo di esordio della sintomatologia è stato: il domicilio del paziente nel 73,6 % rispetto al 75 % del Blitz 1, intraospedaliero nel 4,9%, altro 21,5%
Modalità di Ricovero Nel 46,8% dei casi il paziente decide da solo il ricovero, mediante il Medico di Medicina Generale nel 11,2%, la Guardia Medica nel 3,9%, il Cardiologo nel 10,2%, attivando il Sistema di Emergenza Territoriale 118 nel 19.5%, interpel-lando i familiari nel 5,9%
Accesso in Ospedale L’arrivo in Ospedale è avvenuto nel 58% dei casi mediante auto propria contro il 53% del BLITZ 1 e il 71 % nell’indagine svolta in Campania nel 2004 e nel 34,7% dei casi con autoambulanza rispetto al 40% del BLITZ 1 e il 17 % della Campania. Ancora il 1,6% dei pazienti ha raggiunto l’ospedale a piedi, il 2,6% con auto non propria, e il 1,6% altro. Di tutti i pazienti arruolati l’1,6% è stato trasferito da altro ospedale.
Tempo Precoronarico Il tempo precoronarico totale è stato di 150 minuti (mediana), rispetto a 238 minuti dell’indagine Campania. La mediana del tempo esordio sintomi-arrivo PS 107,5 minuti, il ritardo intraospedaliero (PS-UTIC) 20 minuti. Il tempo pre-coronarico è di 140 minuti (mediana) se a decidere il ricovero è direttamente il paziente, 135 minuti se interviene il Medico di Medicina Generale, 300 minuti Guardia Medica, 177 minuti il Cardiologo, 118,5 minuti se interviene il 118, 290 minuti se decidono i familiari. Quindi il tempo dall’esordio dei sintomi all’arrivo in Ospedale è più breve quando interviene il 118 e il Medico di Medicina Generale o a decidere il ricovero è direttamente il paziente; è più lungo quando intervengono la Guardia Medica, il Cardiologo e i Familiari. Considerando le frazioni orarie del ricovero per SCA con ST elevato, possiamo vedere che il 14% dei pazienti si è ricoverata alla prima ora, il 24,8% alla seconda ora rispetto al 34% del GISSI-1, al 49% del BLITZ 1 e il 25 % dell’indagine Campania. Tra la seconda e la sesta ora si ricovera il 38,2% dei pazienti rispetto al 29% del GISSI-1, al 28% del BLITZ 1 e al 34 % dell’indagine Campania; pertanto nella nostra ASL il 77% dei pazienti affetti da S.C.A. ST “Elevation” si ricovera entro la sesta ora, rispetto al 63% del GISSI-1, al 77% del BLITZ 1 e il 59 % dell’indagine Campana. Tra la sesta e dodicesima ora si ricovera 12,7% dei pazienti, rispetto al 14% del GISSI -1, al 10% del BLITZ 1 e il 14 % della Campania. Oltre la dodicesima ora si ricovera il 10,2% dei pazienti rispetto al 23% del GISSI-1, al 14% del BLITZ 1 e il 27 5 della Campania.
Stratificazione del Rischio. A tutti i pazienti arruolati nel Registro R.O.S.A. per S.C.A. ST “Elevation” è stata eseguita all’ingresso la stratificazione del rischio utilizzando il TIMI RISK SCORE e il TIMI RISK INDEX. Se prendiamo come riferimento il TIMI RISK SCORE abbiamo i seguenti risultati:
Se prendiamo come riferimento il TIMI RISK INDEX abbiamo i seguenti risultati:
La percentuale di mortalità in rapporto alle classi su riportate è stato: 0,6% con indice di rischio minore di 17, del 3,2% con indice di rischio tra 17-33, e del 8,3% con indice di rischio oltre 33.
Quadro clinico. Tenendo conto delle Classi Killip all’ingresso il 75,1% dei pazienti presentavano una Killip I, il 20,5% una Killip 2, il 2,9% una Killip 3 e il 2% una Killip 4. Tra gli altri parametri misurati all’ingresso: PAS: 134,2 + 28,3, PAD 80,6 + 16,6, F.C. 74,5 + 22,7, B.M.I. 27,3 + 5,4 Durante la degenza il 87,8% ha presentato una Killip 1, il 4,4% una Killip 2, il 4,9% una Killip 3 e il 2,9% una Killip 4.
Terapia Preospedaliera. Di tutti i pazienti arruolati il 58,5% già praticava a domicilio terapia farmacologica cardioattiva; rispettivamente: ASA 5,9%, Ticlopidina 1%, EBPM 0,5%, TAO 0,5%, ACEI 9%, Alfalitici 1,2%, Betabloccanti 4,9%, AATI 3,4%, Ca-antagonisti 6,4%, Diuretici 5,6%, Nitrati 1%, Statine 5,6%, PUFA 0,7%, Insulina 2,2, Antiabetici orali 5,4%, Antiaritmici 0,2%, Digitale 0,5%, Gastroprotettori 1,2%, altro 1%. Solo l’8,2% ha praticato terapia a domicilio in rapporto all’evento acuto; rispettivamente: Analgesico 7,1%, ASA 21,4%, Ticlopidina 7,1%, EBPM 14,3%, ACEI 14,3%, Betabloccanti 7,1%, AATI 7,1%, Ca-antagonisti 42,9%, Diuretici il 14,3%, Nitrati 35,7%, Statine 7,1%, Insulina 7,1%, Antidiabetici orali 7,1%. Appena il 9,4% ha praticato terapia in ambulanza, più specificatamente il 6,3% dei pazienti ha praticato Morfina, il 50 % Nitrati, il 50 % ASA, il 6,3 % Clopidogrel, il 12,5 % EBPM, il 12,5% Diuretici, il 6,3% Ca-antagonista, il 6,3% Gastroprotettori. A nessun paziente è stata praticata trombolisi preospedaliera.
Terapia Ospedaliera Quale terapia riperfusiva è stata praticata ai 205 pazienti arruolati nel Registro R.O.S.A. affetti da S.C.A. ST “Elevation” ? E’ stata eseguita trombolisi nel 54,1% e PTCA Primaria nel 4,9% dei pazienti arruolati. Al 41% dei pazienti non è stata eseguita nessuna terapia riperfusiva. La Trombolisi è risultata efficace nel 98,6% dei casi in cui è stata paticata. La mediana del tempo porta-ago è stata di 30 minuti. Se consideriamo le frazioni orarie del tempo porta-ago vediamo che il 17,2% dei pazienti arruolati presenta un tempo di 15 minuti, il 35,4% di 16-30 minuti, il 17,2% di 31-45 minuti, il 12,1% di 46-60 minuti, 12,1% di 61-120 minuti, ed il 6,1% di oltre 120 minuti. Il TNK è stato utilizzato nel 88,3% dei pazienti trombolisati, il RTPA è stato utilizzato nel 11,7% dei casi. In molti casi per svariati motivi non è stata eseguita la trombolisi, più specificamente: il 17,6% per una diagnosi incerta, il 35,1% per un tempo pre-coronarico elevato, il 5,4% per manovre di RCP o invasive eseguite immediatamente prima o durante il ricovero, il 2,7% per TAO, il 2,7% per anemia, il 1,4% per emorragia, il 13,5% per patologia cerebrovascolare, il 4,1% per ulcera gastrica o duodenale, il 2,7% per shock, il 13,5% per PTCA primaria e il 1,4% per altro. La PTCA Primaria è stata praticata nel 4,9% dei pazienti arruolati. La mediana del tempo porta-pallone è stata di 72 minuti. Se consideriamo le frazioni orarie del tempo porta-pallone vediamo che il 50% dei pazienti arruolati presenta un tempo di 1 ora, il 20% di 2 ore, il 10% di 4 ore ed il 20% di oltre 4 ore. Corre l’obbligo ricordare che di tutti i pazienti affetti da S.C.A. ST “Elevation” arruolati nel Registro R.O.S.A. nei dodici mesi presi in esame il 72,9% è stato sottoposto a coronarografia, e di questi il 32,5% è stato sottoposto a PTCA elettiva e, come già abbiamo detto, il 4,9% a PTCA Primaria. Per il resto i pazienti arruolati hanno praticato la seguente terapia in ambiente ospedaliero: Morfina 14,6%, altro Analgesico 2,3%, ASA 70,2%, Clopidogrel 45%, Ticlopidina 3,5%, ENF 37,4%, EBPM 49,1%, ABCXIMAB 1,8%, Tirofiban 21,6%, TAO 4,7%, ACEI 54,4%, Betabloccanti 61,4%, AATI 4,7%, Ca-antagonista 12,3%, Diuretici 12,9%, Nitrati 43,3%, Statine 60,2%, PUFA 4,1%, Insulina 11,7%.
Mortalità Ospedaliera. La mortalità ospedaliera totale per tutti i pazienti con S.C. A. arruolati nel Registro R.O.S.A. è del 4,7%. Il gruppo di pazienti arruolati nel gruppo delle S.C.A. con ST “Elevation” hanno avuto una mortalità totale del 9,3%. La mortalità dei pazienti a cui non è stata eseguita alcuna “terapia riperfusiva” è pari al 10,7%. Invece la mortalità dei pazienti “riperfusi” è stata del 8,3% . La terapia trombolitica, in linea con quanto osservato in altre esperienze italiane, si è mostrata in grado di ridurre drasticamente la mortalità, infatti: la mortalità dei pazienti sottoposti a trombolisi è stata del 6,3%, rispetto al 6,4% del Blitz 1, al 7,2% del Registro Mistral, al 6,9% del Registro Venere e al 7,3% del progetto GestIMA (4,5,6,7). I pazienti non trombolisati hanno avuto una mortalità del 12,8%. I pazienti che avevano eseguito una PTCA Primaria hanno fatto registrare una mortalità del 10%. Significativo è il dato della mortalità dei pazienti che hanno seguito un “percorso invasivo” che è stata del 3,1% rispetto a chi non ha seguito un “percorso invasivo” che è stata del 19,7%.
Conclusioni Lo scopo del Registro R.O.S.A. è quello di acquisire informazioni sui pazienti ricoverati per S.C.A. presso le U.T.I.C. della nostra ASL SA/3, un vasto territorio a Sud della Provincia di Salerno, con una bassa densità abitativa e con collegamenti spesso fatiscenti, in maniera da definirne l’epidemiologia, verificare i percorsi e l’outcome dei pazienti, conoscere la terapia praticata, studiare il follow up post-evento e conseguenzialmente ottimizzare le risposte organizzative ed il trattamento. I dati di questo primo anno di vita del Registro R.O.S.A., documentano che:
La sfida che la Cardiologia del nostro territorio è chiamata a raccogliere in un prossimo futuro consiste essenzialmente in una razionalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici del paziente affetto da S.C.A. e ciò può avvenire soltanto attraverso una adeguata riorganizzazione dei servizi di emergenza, sia territoriali che ospedalieri, quale quella realizzabile con un’adeguata rete integrata di assistenza cardiologia, sulla scorta di quanto indicato nei documenti di consenso e di quello che si è realizzato in diverse realtà italiane negli ultimi anni 5-10. “La fase preospedaliera, comprendente il riconoscimento, la diagnosi, il processo di precoce stratificazione del rischio e l’inizio di una appropriata terapia che contempli anche l’esecuzione di una trombolisi extraospedaliera, deve rappresentare la sfida e l’obiettivo dei prossimi anni” (Documento di Consenso ANMCO-SIC, 2002). Questo nella certezza che la sfida al trattamento delle S.C.A. in fase iniziale si combatte innanzitutto in area extraospedaliera e l’abbattimento della mortalità dovuto ai progressi compiuti dalla cardiologia moderna trova un limite nella organizzazione dell’assistenza sanitaria e nella impossibilità di assicurare a tutti i pazienti colpiti da IMA una assistenza adeguata fin dall’esordio della malattia. Ma indispensabile per poter ottenere i migliori risultati nel trattamento dei pazienti affetti da S.C.A. è quella di creare un sistematico collegamento tra le varie UTIC della nostra ASL, ma soprattutto tra la medicina del territorio e l’Ospedale, queste nostre realtà dovranno crescere e camminare insieme, realizzando tra di loro un “network operativo”, nella consapevolezza che nella concordia le piccole cose crescono, nella discordia le grandi cose finiscono. Tutto questo per poter “servire” al meglio il nostro malato ricordando quello che qualche lustro fà asseriva A. Trousseau “Non esistono le malattie, non esistono i casi clinici, esistono solo i malati”.
1) Gregorio G: Il Registro Osservazionale delle Sindromi Coronariche Acute dell’ASL SA 3 Il Cuore Oggi e Domani 2007 Paestum 4-5 Ottobre 2007 Atti
2) Di Chiara A, Chiarella F, Savonitto S, Lucci D, Bolognese L, De Servi S, Greco C, Boccanelli A, Zonzin P, Coccolini S, Maggioni AP; BLITZ Investigators. Epidemiology of acute myocardial infarction in the Italian CCU network: he BLITZ study. Eur Heart J. 2003;24:1616-29.
3) Di Chiara A, Fresco C, Savonitto S, Greco C, Lucci D, Gonzini L, Mafrici A, Ottani F, Bolognese L, De Servi S, Boccanelli A, Maggioni A, and Chiarella F on behalf of the BLITZ-2 Investigators Epidemiology of non-ST elevation acute coronary syndromes in the Italian cardiology network: the BLITZ-2 study European Heart Journal (2006) 27, 393–405
4) Gregorio G, Citro R, Chieffo C, Corsini F, Riccio C, Iacomino M., Serafino M. Epidemiologia delle Sindromi Coronariche Acute in Campania Monaldi Arch Chest Dis 2005; 64: 157-163
5) Marzegalli M., Oltrona L., Corrada E, Fontana G,Klugmann S. La rete per la gestione delle sindromi coronariche acute della Città di Milano:risultati di quattro anni di esperienza e prospettive del network cardiologico preospedaliero e interospedaliero (Ital Heart J 2005; 6 (Suppl 6): 49S-56S)
6) Olivari Z, Di Pede F,Giujusa T, et al. Epidemiologia ospedaliera e caratteristiche di presentazione dell'infarto miocardico acuto con ST sopraslivellato: dati dal registro VENERE. Ital Heart J 2004 suppl 5: 136S .
7) Oltrona L, Mafrici A, Marzegalli M, Fiorentini C, Pirola R, Vincenti A. La gestione della fase iperacuta dell’infarto miocardico con sopraslivellamneto del tratto ST nella Regione Lombardia (Gest-IMA). Ital Heart J Suppl 2005; 6: 489-497.
8) FIC-ANMCO-SIC Documento di Consenso Infarto Miocardio Acuto con ST elevato persistente: verso un appropriato percorso diagnostico-terapeutico nella comunità. Ital Heart Suppl. 2002,3(11): 1127-1164
9) F. I. C. –S. I. C. I. Documento di Consenso La rete interospedaliera per l’emergenza CoronariCa (Ital Heart J 2005; 6 (Suppl 6): 5S-26S)
10) Gregorio G. S.C.A, dalle dimensioni del problema alle risposte organizzative. Atti del Convegno Le Sindromi Coronariche Acute. Paestum 11 novembre 2004. |