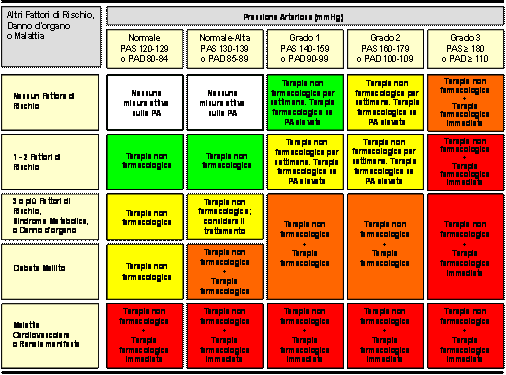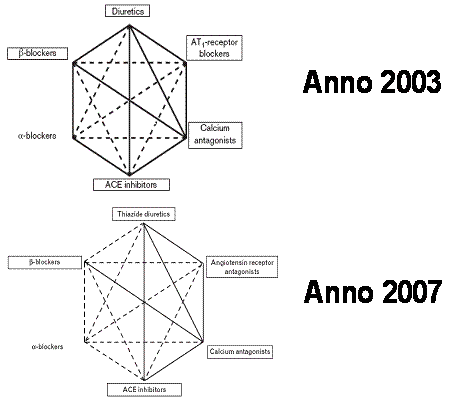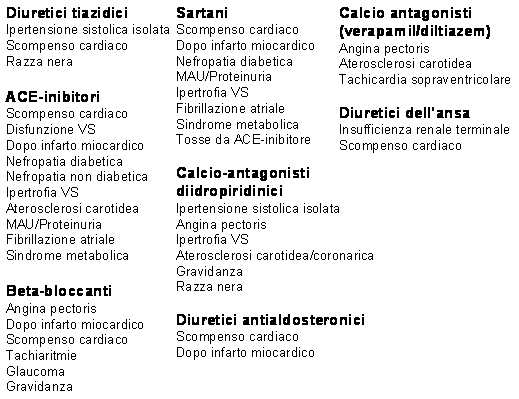La GESTIONE DEL PAZIENTE CON IPERTENSIONE Arteriosa: Dalle Linee Guida alla Pratica Clinica
Paolo Verdecchia Fabio Angeli
Struttura Complessa di Cardiologia, Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia.
Nel Giugno 2007, a distanza di circa 4 anni dalla loro ultima edizione, sono state presentate le nuove linee guida congiunte della Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa e della Società Europea di Cardiologia sulla diagnosi e il trattamento dell’ipertensione arteriosa1. Naturalmente, queste linee guida hanno recepito i messaggi più innovativi provenienti dai principali studi pubblicati negli ultimi anni in termini di diagnosi, prognosi e terapia del paziente iperteso. Per quanto riguarda il trattamento del paziente con ipertensione arteriosa, saranno qui discussi, in estrema sintesi, alcuni aspetti fondamentali, anche con riferimento alla loro applicabilità nella pratica clinica quotidiana. Trattamento non farmacologico. Le linee-guida ribadiscono che tutti i pazienti con ipertensione arteriosa, includendo quelli con pressione arteriosa (PA) “normale-alta”, (130-139/85-89 mmHg) debbono essere sottoposti a misure igienico-dietetiche a lungo termine. Tra queste vanno annoverate: (a) l’abolizione del fumo di sigaretta, (b) la riduzione del sovrappeso corporeo, (c) la riduzione dell’apporto di bevande alcoliche, (d) l’aumento dell’attività fisica, (e) la riduzione del consumo di sale, (f) l’aumento del consumo di frutta e vegetali, (g) la riduzione dell’apporto di grassi totali e saturi. In particolare, è estremamente ben noto l’effetto antiipertensivo legato alla riduzione del peso corporeo nei soggetti sovrappeso o obesi, così come l’effetto legato alla cessazione del fumo di sigaretta nei fumatori e legato alla dieta a basso contenuto di sale. Da un punto di vista pratico: è evidente che queste misure non dovrebbero mai ritardare l’inizio di un trattamento farmacologico nei soggetti più a rischio (vedi sotto), ma è altrettanto evidente che l’inizio troppo frettoloso di un trattamento farmacologico non dovrebbe distogliere l’attenzione del medico e del paziente dalle misure igenico-dietetiche, come purtroppo accade in molti casi.
Quando iniziare il trattamento farmacologico. La figura 1 mostra le indicazioni delle linee-guida su quando iniziare un trattamento farmacologico sulla base dei valori di PA e dei fattori di rischio concomitanti. In generale, le linee guida appaiono abbastanza caute sull’inizio della terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione di grado 2 (160-179/100-109 mmHg) in assenza di fattori di rischio o in presenza di 1-2 fattori di rischio. In questi soggetti, infatti, si consiglia la terapia farmacologica solo dopo ‘settimane’ di osservazione. Anche l’indicazione alla terapia non farmacologica (seppure con terapia farmacologica ‘da considerare’) in soggetti con pressione normale-alta accompagnata da 3 o più fattori di rischio, danno d’organo o sindrome metabolica potrebbe anche apparire troppo cauta. Al contrario, l’indicazione al trattamento farmacologico in soggetti in stadio I (140-159/90-99 mmHg) in presenza di sindrome metabolica senza alcun altro fattore di rischio o danno d’organo potrebbe essere giudicata eccessivamente aggressiva. Da un punto di vista pratico: Potrebbe apparire fin troppo facile affermare che ‘ogni singolo caso va valutato singolarmente’. Per essere chiari, in assenza di quadri clinici perfettamente riconducibili agli schemi delle linee guida, quanto maggiore è il rischio cardiovascolare individuale calcolato, tanto maggiore è l’urgenza di iniziare un trattamento farmacologico, ovviamente accompagnato da tutte le misure non farmacologiche più adeguate nel singolo caso. E quanto maggiore è il rischio cardiovascolare individuale, tanto più frequenti dovranno essere le visite di follow-up e gli eventuali aggiustamenti terapeutici.
I farmaci anti-ipertensivi. A differenza dalle linee guida nord-Americane, che sottolineano il ruolo centrale dei diuretici come farmaci da utilizzare nella maggior parte dei pazienti2, le linee-guida Europee persistono nella giusta collocazione ‘alla pari’ tra le cinque classi principali dei farmaci antiipertensivi (diuretici, beta-bloccanti, ACE-inibitori, calcio-antagonisti, sartani). Peraltro, le linee guida Europee hanno preso le distanza dalle recenti linee guida Britanniche3, che hanno raccomandato la sostanziale ‘retrocessione’ dei beta-bloccanti a farmaci da utilizzare solo in presenza di ipertensione resistente al trattamento con diuretici, ACE-inibitori e calcio-antagonisti, oltre che in casi selezionati3. Viene giustamente sottolineata l’importanza della cautela nell’uso dei diuretici e dei beta-bloccanti in pazienti ad alto rischio di sviluppare diabete mellito. La combinazione tra diuretici e beta-bloccanti viene comunque
Figura 1 Quando iniziare un trattamento farmacologico nel paziente iperteso sulla base dei valori pressori e dei fattori di rischio concomitanti.
declassata da ‘linea continua’ (linee guida 2003) a ‘linea tratteggiata’ (figura 2). Le linee guida Europee sottolineano l’importanza delle combinazioni fisse anche nel trattamento iniziale dell’ipertensione arteriosa. Dobbiamo essere estremamente pragmatici e riconoscere che la PA non è adeguatamente controllata in un elevato numero di soggetti ipertesi trattati. Le combinazioni fisse, qualora farmacologicamente razionali (es. ACE-inibitori + calcio antagonisti, ACE-inibitori + diuretici, sartani + calcio antagonisti, sartani + diuretici) possono contribuire al raggiungimento dell’obbiettivo
Figura 2 Posizione delle linee Guida Europee nella versione dell’anno 2003 e dell’anno 2007 relativamente ai farmaci anti-ipertensivi di prima scelta (box) e alle combinazioni consigliate (linea continua). La combinazione tra diuretici e beta-bloccanti non viene più suggerita come di prima scelta.
pressorio. Peraltro, un tale atteggiamento ‘pragmatico’ è totalmente condiviso anche dalle linee guida Nord-Americane2. Le condizioni cliniche favorenti l’uso di specifici farmaci antiipertensivi sono riportate in figura 3. Da un punto di vista pratico: Non dobbiamo mai dimenticare la considerazione, apparentemente banale, che lo scopo fondamentale dei farmaci anti-ipertensivi è quello di ridurre la pressione arteriosa. L’obbiettivo del trattamento è quello di ridurre la PA a valori inferiori di 140/90 mmHg nei pazienti ipertesi non diabetici, ed inferiori a 130/80 mmHg nei pazienti ipertesi diabetici. I pazienti ad elevato rischio
Figura 3. Condizioni favorenti l’uso di specifici farmaci antiipertensivi. Abbreviazioni: MAU=microalbuminuria; VS=ventricolo sinistro.
cardiovascolare potrebbero essere equiparati ai diabetici, sebbene siano necessari ulteriori studi in questo campo. Tutti i farmaco disponibili, e le loro combinazioni, sono da prendere in considerazione, sempre con l’obbiettivo finale della normalizzazione pressoria.
Bibliografia
1. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, Grassi G, Heagerty AM, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Schmieder RE, Boudier HA, Zanchetti A. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25:1105-1187. 2. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT Jr, Roccella EJ; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003;42:1206-1252. 3. NICE/BHS. Clinical Guideline 34: Hypertension: management of hypertension in adults in primary care: partial update: http://nice.org.uk/CG034guidance (accessed June 28, 2006).
|