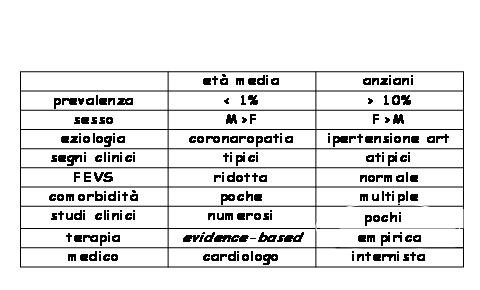|
La terapia medica dello scompenso cardiaco nell’anziano
Domenico Miceli
UOS Valutazione dello Scompenso Cardiaco e Riabilitazione Cardiologica Dipartimento di Cardiologia AO Monaldi Napoli
Lo scompenso cardiaco è ormai considerato una sindrome “epidemica”, in ragione della sua diffusione, della persistente severità della prognosi e degli elevati costi di cura ad esso associati. La maggior parte dei pazienti affetti da scompenso cardiaco è attualmente rappresentata da anziani, ovvero da soggetti oltre i 65 anni di età, e da vecchi, ovvero da soggetti oltre i 75, fenomeno, questo, in buona parte attribuibile al progressivo evidente incremento dell’età media della popolazione, ma anche ad un intrinseco maggior grado di morbilità cardiovascolare dei soggetti in età avanzata. Diversi fattori distinguono lo scompenso cardiaco nell’anziano da quello che si manifesta in soggetti di più bassa fascia di età (1,2) (fig.1), ma, in modo particolare, in tema di trattamenti terapeutici, è significativa la poca rappresentazione di questi pazienti negli studi clinici che hanno testato le categorie di farmaci raccomandati nei vari stadi della malattia, e, conseguentemente, il criterio spesso empirico con il quale questi farmaci vengono impiegati nella cura dei soggetti delle fasce di età più avanzate.
Fig.1 : fattori che distinguono lo scompenso cardiaco negli anziani rispetto ai pazienti di età media (modificata da Rich MW, Am J Med 2005)
E così, le linee guida dello scompenso cardiaco cronico, sia quelle americane che quelle europee (3,4), proprio in ragione dell’inesistenza di dati certi derivati da trial in questo tipo di popolazione, devono necessariamente limitarsi a poche, preliminari e generiche, considerazioni, raccomandando soprattutto cautela ed attenzione alla farmacocinetica e alla farmacodinamica dei principi attivi da impiegare in terapia. E’ più che evidente come l’età avanzata rappresenti di per sé un fattore di rischio per scompenso cardiaco già in condizioni di assenza di cardiopatia conclamata, al pari di tutte quelle altre condizioni, quali ipertensione arteriosa e ipertrofia ventricolare sinistra, fumo, diabete, dislipidemie, obesità ed insufficienza renale, in grado di determinare la comparsa della disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, che rappresenta la parte sommersa del “fenomeno dell’iceberg” descritto da Hoes (5) (fig.2).
Fig.2: scompenso cardiaco, il fenomeno dell’ “iceberg”
E diversi studi hanno messo in evidenza la potenzialità del corretto trattamento di tutti i fattori di rischio citati nel prevenire la comparsa della disfunzione ventricolare sinistra e dunque dello scompenso cardiaco. Il CONSENSUS (6) è stato il primo studio che ha arruolato una sufficientemente consistente percentuale di pazienti anziani, essendo i soggetti di oltre i 70 anni di età circa il 50% dei pazienti studiati, che presentavano un’età media di 71 anni. Questo studio ha dimostrato l’efficacia dell’enalapril nel ridurre la mortalità per scompenso cardiaco specie se impiegato il più precocemente possibile, anche nelle classi funzionali avanzate, e, nei lavori che hanno effettuato il follow-up a dieci anni, l’efficacia è stata confermata con un incremento di vita medio di 260 giorni. Dallo studio CONSENSUS, effettuato nel 1989, ad oggi, i risultati di tutti i trial condotti sugli ACE-inibitori (7) e i dati disponibili sui pazienti anziani nelle analisi condotte per sottogruppi di età, hanno indotto a ritenere gli ACE-inibitori uno dei cardini nel trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco cronico anche nei pazienti anziani, per la loro documentata capacità di rallentare il rimodellamento strutturale e il deterioramento funzionale del ventricolo sinistro, di migliorare il quadro clinico-emodinamico e, soprattutto, di ridurre il rischio di ospedalizzazione e di morte. Alcune ricerche, inoltre, sembrano attribuire agli ACE-inibitori anche una certa attività di miglioramento della capacità cognitiva dei pazienti anziani con scompenso cardiaco (8). Negli anziani è necessario che la titolazione degli ACE-inibitori sia fatta con maggiore attenzione, partendo da dosaggi bassi, che vanno raddoppiati ad intervalli di due settimane, e, nei casi in cui non sia possibile raggiungere le dosi “target”, fino al dosaggio massimo tollerato. Numerosi studi, effettuati negli ultimi anni, hanno messo in evidenza anche l’efficacia degli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II, e il loro ruolo nel trattamento dello scompenso cardiaco è ormai accertato non solo come scelta alternativa nei casi di intolleranza ( tosse, rush cutaneo, alterazioni del gusto ), ma anche come trattamento “additivo”. In particolare il candesartan, valutato nei diversi bracci dello studio CHARM (9), ha dato risultati efficaci su mortalità totale e cardiovascolare sia in alternativa che in aggiunta alla terapia con ACE-inibitori, e il valsartan, in base ai risultati dello studio Val-He-FT (10), ha di recente ottenuto dall’Agenzia Italiana del Farmaco l’approvazione della indicazione terapeutica nello scompenso cardiaco cronico. Accanto ai farmaci inibitori dell’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, i betabloccanti rappresentano l’ altra strategia farmacologica che si è dimostrata in grado di contrastare efficacemente la progressione della malattia cardiaca e di migliorare l’outcome clinico in uno spettro di pazienti con scompenso cardiaco cronico, fino alla IV classe funzionale. Una metaanalisi alquanto recente dei principali studi condotti su questi farmaci (BEST, US CARVEDILOL, CIBIS II, MERIT-HF e COPERNICUS) (11) ha confermato che l’entità del beneficio e il grado di tollerabilità di questa categoria di farmaci nell’impiego terapeutico per lo scompenso cardiaco cronico, sono sostanzialmente indipendenti dall’età, purchè, al pari di quanto è necessario fare con gli ACE-inibitori, la selezione dei pazienti sia appropriata e la terapia venga effettuata nel rispetto di un rigoroso schema di titolazione. E, anche negli anziani così come in tutte le altre fasce di età, la presenza di malattie bronchiali non associate a severa ostruzione delle vie aeree non rappresenta una controindicazione al trattamento con betabloccanti, così come, nonostante la presenza di potenziali effetti avversi metabolici, questi farmaci hanno mostrato di fornire un beneficio clinico anche nei pazienti diabetici. Riguardo all’uso dei diuretici, indubbiamente non esiste una classe di farmaci per lo scompenso cardiaco cronico in grado di contrastare così efficacemente il sovraccarico di volume e i sintomi di congestione polmonare e periferica con un rapporto costo/beneficio così favorevole. Negli anziani in trattamento cronico i diuretici dell’ansa, furosemide e torasemide, vanno adoperati alle dosi più basse efficaci, in modo da ridurne al massimo gli effetti collaterali, ma, nei casi di marcata ritenzione idrica, specie se in concomitanza con insufficienza renale, può essere necessario adoperare anche alte dosi, eventualmente, e per brevi periodi, in associazione con metolazone, che agisce a differente livello tubulare. Sicuramente molto utile, e anche validata dai risultati dello studio RALES , che ne ha dimostrato l’efficacia nelle classi funzionali avanzate, è l’utilizzo dello spironolattone in associazione (12). I principali problemi legati all’uso dei diuretici negli anziani sono, come è noto, i disturbi elettrolitici e l’ipotensione, per cui saranno necessari frequenti controlli dei parametri di laboratorio e clinici, al fine di modulare la terapia in base alla risposta e alla tolleranza. Naturalmente l’utilizzo ottimale dei diuretici deve essere accompagnato dalla restrizione dei liquidi e del sale con il controllo quotidiano del peso corporeo, che, nel paziente anziano, per raggiungere un compenso accettabile, dovrebbe mantenere un’oscillazione di 1 kg in più o in meno rispetto al peso ideale. Infine, ma non certamente in ordine di importanza, merita un cenno la digitale, che, anche impiegata nel paziente ultraottantenne, ha efficacia documentata nel miglioramento dei sintomi e nella riduzione delle ospedalizzazioni, come dai risultati del noto studio DIG (13), e i cui effetti collaterali sono ben controllabili se la digossinemia viene mantenuta al di sotto di 1 ng/ml. Il farmaco è sicuramente indicato nei casi di fibrillazione atriale permanente per un migliore controllo della risposta ventricolare, ma anche nei pazienti in ritmo sinusale se sintomatici nonostante terapia “massimale”. Un aspetto peculiare, in tema di terapia medica dello scompenso cardiaco nell’anziano, è rappresentato dallo scompenso cardiaco diastolico, ovvero a funzione sistolica conservata, che ha una prevalenza rilevante proprio nella popolazione oltre i 65 anni. Non vi sono linee guida sui trattamenti raccomandati per lo scompenso diastolico, neppure per i pazienti non appartenenti alle fasce più alte di età, ma la terapia è differente, rispetto a quello sistolico, riguardo all’ utilizzo di alcune classi di farmaci, dal momento che lo scopo è, in questo caso, non il rimodellamento del ventricolo sinistro o l’incremento dell’inotropismo, bensì soprattutto la riduzione della frequenza cardiaca. In particolare, vanno sottolineati i seguenti punti: - il dosaggio dei diuretici, che vanno usati in proporzioni ridotte - la titolazione dei betabloccanti, che appare meno necessaria - la differente indicazione della digitale (poco utile nello scompenso diastolico) e dei calcioantagonisti (indicati nello scompenso diastolico ma non in quello sistolico)
Conclusioni Esiste di fatto, pur essendo riconosciuta la validità di tutti i trattamenti terapeutici di cui sopra, un diffuso sottoutilizzo dei trattamenti farmacologici raccomandati per lo scompenso cardiaco cronico, specie negli anziani e specie per quanto riguarda i betabloccanti, che, anche se prescritti, lo sono spesso in maniera sottodosata: i dati dello studio osservazionale TEMISTOCLE (14) dimostrano infatti come nelle Divisioni di Medicina, tra le cause di mancata prescrizione dei betabloccanti, nel 43,8% dei casi vi fosse l’età superiore a 75 anni. Riguardo ai pazienti anziani con scompenso cardiaco, poi, e specificamente a causa della frequente concomitante presenza di patologie a carico anche di altri organi, poiché un limite delle linee guida è quello di affrontare i problemi delle singole patologie, l’aderenza a queste raccomandazioni espone a possibili indesiderati effetti. E’ pertanto necessario che vengano effettuati trial specificamente dedicati ai pazienti anziani, pur riconoscendone la intrinseca difficoltà, sia per l’arruolamento che per la gestione. Ma come favorire la partecipazione della popolazione geriatrica agli studi sperimentali? Probabilmente sollecitando la creazione di collegamenti tra strutture di ricerca clinica ed accademica e istituti di cura ed assistenza per anziani, realizzando grandi trial che possano includere una popolazione più eterogenea con comorbidità multiple e differenze nella progressione delle patologie, e che permetta poi delle valutazioni di sottogruppi. Ciò si realizza anche coinvolgendo le famiglie o i volontari nella spiegazione del consenso informato, possibilmente stampato in caratteri grandi e reso più intelligibile, e facilitando i trasporti o effettuando, quando possibile, visite cliniche a domicilio. Ma occorre anche prestare attenzione agli aspetti regolatori, allo scopo di incentivare lo studio dei farmaci nell’età avanzata: la FDA americana ha incluso una sezione “ uso geriatrico ” nelle specialità medicinali, obbligando ad inserire informazioni riguardanti l’impiego specifico nell’anziano, anche se, sotto il profilo dello sviluppo dei trial, non si sono rilevati grandi benefici, poiché si è limitata a indicare come fornire informazioni sui farmaci ad uso geriatrico non obbligando a svolgere necessariamente studi supplementari nell’anziano. Una possibile proposta potrebbe essere quella di incoraggiare l’applicazione, anche in geriatria, dell’equivalente della “Pediatric Rule”, applicata in USA per i farmaci di uso pediatrico dal 1997, ipotizzando pertanto analogamente una estensione dell’esclusiva di mercato (che è di sei mesi per la pediatria) per i farmaci ad utilizzo geriatrico che abbiano evidenziato uno specifico sviluppo in questa popolazione.
Bibliografia
1) Badano L, Di Lenarda A, Bellotti P et Al Patients with chronic heart failure encountered in daily clinical practice are different from the “typical” patient enrolled in therapeutic trials Ital Heart J 2003;4:84-91 2) Rich MW Office management of heart failure in the elderly Am J Med 2005;118:342-348
3)
ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management
of Chronic Heart
Failure in the Adult: A
Report of the American College of Cardiology/American
Heart Association Task
Force on Practice Guidelines
(Writing Committee to Update the 2001
Guidelines for the
Evaluation and Management of
Heart Failure)
4)
Executive summary of the
guidelines on the diagnosis and treatment of acute
heart
failure: The Task Force
on Acute Heart
Failure of the European
Society of Cardiology 5) Hoes AW, Mosterd A, Grobbee DE An epidemic of heart failure? Recent evidence from Europe Eur Heart J 1998, 19, suppl L2-9 6) The CONSENSUS Trial Study Group Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS) N Engl J Med 1987 , 316, 1429-1435 7) Flather MD, Yusuf S, Kober L et Al Long-term ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left ventricular disfunction: a systematic overview of data from individual patients Lancet 2000;355:1575-1581 8) Zuccalà G, Onder G, Marzetti E et Al for the GIFA study group Use of angiotensin- converting enzyme inhibitors and variations in cognitive performance among patients with heart failure Eur H J 2005,26,226-233 9) Pfeffer Ma, Swedberg K, Granger CB et Al Effects of candesartan on mortality and morbidity in patients with chronic heart failure: the CHARM-Overall programme Lancet 2003;362:759-766 10) Cohn JN,Tognoni G for the Valsartan Heart Failure Trial (Val-HeFt) Investigators. A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure N Engl J Med 2001;345:1667-1675 11) Dulin BR, Haas SJ, Abraham WT et Al Do elderly systolic heart failure patients benefit from beta blockers to the same extent as the non-elderly?Meta-analysis of >12,000 patients in large-scale clinical trials Am J Cardiol 2005; 95:896-898 12) Pitt B, Zannad F, Remme WJ et Al The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure N Engl J Med 1999;341:709-717 13) The Digitalis Investigation Group (DIG) The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure N Engl J Med 1997;336:525-533 14) Di Lenarda A, Scherillo M, Maggioni AP et Al Current presentation and management of heart failure in cardiology and internal medicine hospital units: a tale of two worlds – the TEMISTOCLE study Am Heart J 2003;146:E12
|