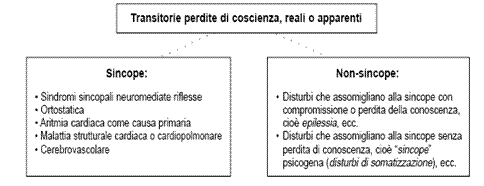|
La diagnosi di sincope cardiogena
Andrea Campana
Dipartimento Medico-Chirurgico di Cardiologia Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”. Salerno
La sincope, secondo la definizione della Società Europea di Cardiologia (ESC), è caratterizzata da perdita transitoria dello stato di coscienza, a risoluzione spontanea, generalmente accompagnata da caduta al suolo; il meccanismo fisiopatologico è rappresentato da ipoperfusione cerebrale. Lo studio Framingham, basato su un ampio campione di popolazione, riportava una incidenza di 7.2 casi/anno per mille abitanti (1); tuttavia, in popolazioni selezionate come gli anziani, l’incidenza annuale può essere più alta del 6%, con un tasso di recidive del 30%. Benché la sincope abbia una prognosi generalmente benigna, quando la causa sia di origine cardiaca, il tasso di mortalità ad un anno oscilla tra il 18 ed il 33% (2). Non trascurabile è l’impatto negativo che la sincope esercita sulla qualità e sullo stile di vita dei pazienti: in uno studio di Linzer et Al. il 76% dei soggetti con sincope aveva limitazioni nelle attività quotidiane, il 64% sperimentava difficoltà nella guida di autoveicoli ed il 39% nell’attività lavorativa (3); inoltre, la sincope rappresenta un importante fattore di morbilità, causando traumi di varia entità nel 17-35% dei pazienti che ne sono affetti. In Italia, la sincope è causa dell’1.1% di accessi al pronto soccorso (4); dati ufficiali del Ministero della Salute relativi all’anno 2003 parlano di 52.130 ricoveri (ordinari e in day-hospital) con diagnosi principale di “sincope e collasso”.
Valutazione iniziale.
Di fondamentale importanza nell’iter diagnostico del paziente con sincope è l’approccio iniziale, basato su una accurata raccolta anamnestica, sull’esame clinico comprensivo della misurazione della pressione arteriosa anche in ortostatismo, nonché sulla registrazione di un elettrocardiogramma standard (5,6). Le tre domande che il Medico deve porsi di fronte al paziente sincopale sono: 1) La perdita di coscienza è attribuibile a vera sincope? 2) E’ presente una cardiopatia? 3) Vi sono importanti aspetti anamnestici che indirizzano la diagnosi?
La prima domanda riguarda la distinzione che va sempre fatta tra la sincope “vera” ed alcune condizioni ( Tab I) che la possono simulare (7) :
TAB. I
E’ utile, a questo punto, rammentare, in maniera più dettagliata, le cause di sincope, facendo riferimento alla tabella riassuntiva sotto riportata (TAB II) (7):
Numerosi studi condotti negli anni ’80 hanno dimostrato, come si è già accennato sopra, che la mortalità a un anno dei pazienti con sincope cardiogena è sensibilmente più alta di quella dei pazienti con sincope da causa non cardiaca o indeterminata (2,6); per tale motivo, appare di cruciale importanza dare una risposta alla seconda domanda: difatti, la presenza di cardiopatia sospetta o accertata impone particolare attenzione nella valutazione del paziente sincopale, rendendo, nella maggior parte dei casi, necessario il ricovero per indagini di secondo livello e/o a scopo terapeutico. Per quanto riguarda gli aspetti clinico-anamnestici che possono indirizzare per una diagnosi eziologia, ed in particolare per l’origine cardiogena della sintomatologia, l’assenza di prodromi, benché più frequente nella sincope da causa cardiaca (41%), non è assolutamente determinante, in quanto presente circa nella stessa misura nella sincope neuromediata (33%) ed in quella da causa indeterminata (37%) (5); possono costituire elementi diagnostici di una certa importanza la presenza documentata di una grave affezione organica cardiaca, la manifestazione della sincope durante sforzo o in posizione supina, oppure preceduta da palpitazione o dolore toracico; non va trascurata, nella raccolta anamnestica, l’ eventuale storia familiare di morte improvvisa, che potrebbe orientare per la presenza di una cardiopatia aritmogena a trasmissione genetica. Aspetti elettrocardiografici che possono far sospettare con maggiore o minore fondatezza l’origine cardiaca della sincope sono i seguenti (TAB III) (8) :
TAB III
Impiego degli esami strumentali. La valutazione iniziale può condurre ad una diagnosi certa della origine della sincope, basata sui sintomi o sui segni clinici ed elettrocardiografici; quando, invece, il meccanismo della sincope non è evidente, nei pazienti che presentino le caratteristiche clinico-elettrocardiografiche indicative della presenza di una cardiopatia, poichè questa è associata ad un maggior rischio di aritmie e di mortalità, viene raccomandata una completa valutazione cardiologica, consistente in monitoraggio elettrocardiografico prolungato (Holter o loop-recorder esterno o impiantabile), stress test, ecocardiogramma, ed eventualmente studio elettrofisiologico. Nell’ipotesi di una genesi cardiaca della sincope, l’ esecuzione di un ecocardiogramma serve a confermare o escludere la presenza di una malattia strutturale del cuore (9). Un test da sforzo diagnostico ed un ecg dinamico sono da prendere in considerazione nei casi già con ecocardiogramma anomalo o in pazienti con alta probabilità pre-test di coronaropatia o aritmie (10); tra l’altro, benché l’ecg dinamico (Holter) sia un test largamente disponibile con costi relativamente ridotti, ciò non è sufficiente per definire la metodica ad elevato grado di apppropriatezza (classe I) nei pazienti con sincope (11). Secondo le linee guida europee (8), l’Holter è indicato nei pazienti con episodi sincopali e presincopali molto frequenti e che presentino caratteristiche clinico-elettrocardiografiche suggestive per la presenza di una genesi cardiaca della sintomatologia; il test è diagnostico quando viene rilevata la correlazione tra il manifestarsi della sincope e l’anomalia elettrocardiografica. Un test elettrofisiologico invasivo è indicato quando la valutazione iniziale suggerisce una causa aritmica della sincope e nessuna aritmia di rilievo sia stata evidenziata al monitoraggio elettrocardiografico, oppure al fine di valutare l’esatta natura di una aritmia già identificata come causa di sincope; il test è anche indicato nei pazienti che svolgano attività ad alto rischio, nei quali deve essere compiuto ogni tentativo per individuare una possibile causa cardiaca di sincope (8); un risultato normale dello studio elettrofisiologico non può completamente escludere una causa aritmica di sincope e, quando essa sia molto probabile in base agli elementi clinico-elettrocardiografici, è necessario ricorrere ad ulteriori indagini ( es. loop-recorder). Tuttavia, lo studio elettrofisiologico endocavitario risulta assolutamente diagnostico nei casi seguenti: a) bradicardia sinusale marcata e tempo di recupero del nodo del seno molto elevato b) blocco bifascicolare e HV>100 msec basalmente o sviluppo di blocco A-V di 2°-3° grado sottohisiano durante esecuzione di stimolazione atriale incrementale o dopo somministrazione e.v. di Ajmalina. c) induzione, mediante stimolazione programmata, di tachicardia ventricolare monomorfa. d) induzione di una aritmia sopraventricolare rapida che riproduca i sintomi spontanei o provochi grave ipotensione.
Il valore diagnostico dello studio elettrofisiologico è, invece, minore (classe II) quando ci si trovi di fronte alle seguenti condizioni: a) intervallo HV >70 e <100 msec b) induzione di tachicardia ventricolare polimorfa o fibrillazione ventricolare in pazienti con sindrome di Brugada (12) , cardiomiopatia (displasia) aritmogena ventricolare destra, pazienti resuscitati da arresto cardiaco (8). L’induzione di tachicardia ventricolare polimorfa o fibrillazione ventricolare in pazienti con cardiomiopatia ischemica o primitiva con funzione contrattile depressa ha un basso valore predittivo ( classe III) ( 13, 14). Quando il meccanismo eziologico della sincope rimanga misconosciuto anche dopo una valutazione completa, l’impianto di un “loop recorder” è indicato nei pazienti che presentino un pattern elettrocardiografico suggestivo per l’origine aritmica della sintomatologia e che abbiano una storia clinica caratterizzata da sincopi ricorrenti determinanti conseguenze traumatiche (classe I) (8). Vengono considerate come indicazioni di classe II all’impianto di un “loop recorder” le seguenti : a) In una fase iniziale del “workup” diagnostico, in luogo degli esami convenzionali, in pazienti con funzione ventricolare conservata e che presentino un aspetto dell’elettrocardiogramma di base suggestivo per una origine aritmica della sincope (15). b) Al fine di stabilire il contributo della bradicardia prima di procedere all’impianto di un pace-maker, in pazienti con sincope neuro-mediata certa o sospetta, che presentino episodi frequenti o complicati da traumi (16).
Il monitoraggio elettrocardiografico, nelle sue varie forme di attuazione, appare inutile nei pazienti sincopali che non presentino gli aspetti elettrocardiografici suggestivi per una causa aritmica di sincope riportati nella TAB III; è importante sottolineare che , al fine della correlazione diagnostica tra anomalia elettrocardiografica e sintomo, la presincope non costituisce un adeguato surrogato della sincope vera e propria: essa non dovrebbe pertanto essere usata come guida per la definizione della terapia (17).
BIBLIOGRAFIA:
1) Soteriades E. et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002; 347: 878-85 2) Kapoor W.N. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine(Baltimore) 1990; 69(3): 160-75 3) Linzer M, Pontinem M, Gold DT et al. Impairment of physical and psychosocial function in recurrent syncope. J Clin Epidemiol 1991; 44: 1037-43. 4) Brignole M, Menozzi C, Bartoletti A et al. A new management of sincope: prospective systematic guideline-based evaluation of patients referred urgently to general hospitals. European Heart J 2006; 27: 76-82. 5) Alboni P, Brignole M, Menozzi C et al. The diagnostic value of history in patients with sincope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1921-8 6) Martin GJ, Adams SL, Martin HG et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med 1984; 13: 499-504. 7) Linee guida per la diagnosi ed il trattamento della sincope. Task force della Sincope, Società Europea di Cardiologia. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione Vol 5 N° 1 Marzo 2002. 8) Guideline on Management of Syncope-Update 2004. The Task Force on Syncope, European Society of Cardiology. European Heart J 2004; 25: 2054-2072. 9) Recchia B, Barzilai B. Echocardiography in the evaluation of patients with syncope. J Gen Intern Med 1995; 10:649-55. 10) Kapoor WN. An overview on the avaluation an management of syncope. In: Grubb RP, Olshansky B. eds. Syncope: mechanisms and management. New-York, NY: Futura Publishing 1998:1-13. 11) Bartoletti A. Elettrocardiogramma dinamico e sincope: una coppia definitivamente in crisi? Ital Heart J Suppl. 2001; 2(2):155-157. 12) Brugada P, Brugada R, Brugada J, Priori SG, Napolitano C. Should patients with asymptomatic Brugada electrocardiogram undergo pharmacological testing? Circulation 2005; 112: 279-292. 13) Mittal S, Hao S, Iwai S et al. Significance of inducile ventriculr fibrillation in patients with coronary artery disease and unexplained sincope. J Am Coll Cardiol 2001; 38: 371-6. 14) Menozzi C, Brignole M, Garcia-Civers R et al. Mechanisms of sincope in patients with heart disease and negative electrophysiologic testing. Circulation 2002; 105: 2741-5. 15) Brignole M, Sutton R, Menozzi C et al. Early application of an implantable loop recorder allows effective specific therapy in patients with recurrent suspected neurally mediated syncope. Eur Heart J 2006, May 27(9):1085-92 16) Ammirati F, Colivicchi F, Santini M et al. Permanent cardiac pacing versus medical treatment for the prevention of recurrent vasovagal sincope. A multicenter, randomized, controlled trial. Circulation 2001; 104:52-7. 17) Nierop P, Van Mechelen R, Elsacker A et al. Heart rhythm during syncope and presyncope. Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23:1532-8
|