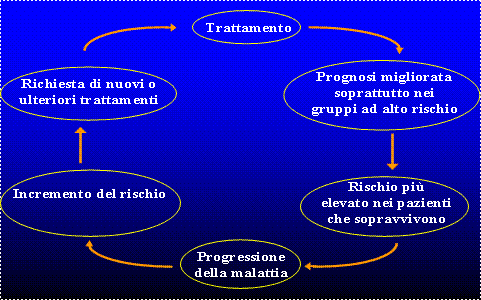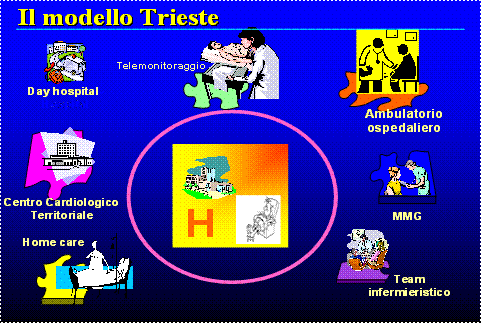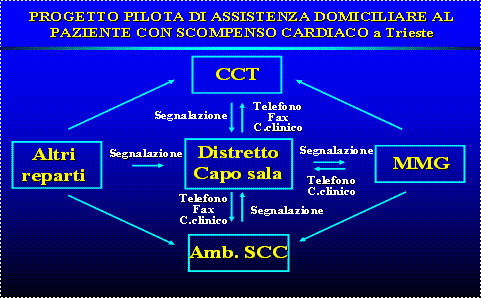|
LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE -TERRITORIO per i pazienti con scompenso cardiaco
Sabino Scardi, Franco Humar, Andrea Di Lenarda Dipartimento Interaziendale di Cardiologia, Trieste
Si afferma che le epoche esaltanti della vita siano piene di sfide, quella in cui viviamo é un’epoca esaltante per la cura a lungo termine del cardiopatico, è necessario però…eliminare alcune barriere che ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo.
In questi ultimi anni la domanda di salute dei cittadini si è evoluta, infatti, sono emerse dall’epidemiologia nuove esigenze di cura e di assistenza legate alla cronicità e lo scompenso cardiaco rappresenta forse l’esempio più eclatante. Nel mondo occidentale, compresa l’Italia, la popolazione sta invecchiando, ciò condizionerà un’epidemia di malattie cardiovascolari degenerative (in particolare dello scompenso cardiaco) che richiederà modelli organizzativi ed assistenziali nuovi. La sanità pubblica perciò deve adeguare il sistema di cura ai nuovi bisogni legati alla cronicità. Pertanto anche gli interessi della cardiologia devono rinnovarsi perché il cardiopatico cronico è un problema reale.
Gli attuali punti di criticità Gli attuali trattamenti “efficaci” migliorano la prognosi soprattutto nei pazienti a più alto rischio, pertanto il rischio diventa più elevato in quelli che sopravvivono che poi vanno spesso incontro alla progressione della malattia che, a sua volta, incrementa ulteriormente il rischio. Questi malati richiedono perciò nuovi ed ulteriori interventi diagnostico-terapeutici che attivano una “spirale” che si conclude solo con il decesso del paziente (Fig 1). Nonostante che numerosi trial abbiano dimostrato l’utilità di alcune terapie, il loro utilizzo rimane particolarmente basso nei cardiopatici non seguiti da uno specialista cardiologo , mentre i pazienti che sono seguiti dai cardiologi ricevono molto più frequentemente le cure suggerite dalle linee guida cliniche. Le nuove strategie di gestione rendono non più necessarie degenze prolungate negli ospedali per acuti,e se il cronico non deve essere curato negli ospedali per acuti, la sanità pubblica deve adeguare i sistemi di cura ai nuovi bisogni assicurando modelli assistenziali efficaci ma meno costosi e a minor rischio di iatrogenesi. Tutto ciò implica la necessità urgente di migliorare la qualità della cura cardiologica nel territorio. Se un malato dal territorio viene ad esempio ricoverato in terapia intensiva per uno scompenso cardiaco acuto e dall’unità coronarica passa alla degenza subintensiva e a quella ordinaria ed infine alla riabilitazione cardiologica, una volta tornato nel territorio deve trovare una continuità assistenziale ( Fig 2 ). Lo studio TEMISTOCLE dell’ANMCO ha analizzato i percorsi extraospedalieri dei pazienti con scompenso cardiaco. Dall’indagine é emerso che nel nostro Paese non esiste un follow-up sistematico per questi pazienti, non vi sono programmi che assicurano la loro continuità assistenziale
Figura 1: La spirale del cardiopatico cronico
Figura 2: La continuità ospedale territorio
Tabella I Le tante problematiche dello scompenso cardiaco
Tabella II Le problematiche sociali
nonostante che il 40% dei fattori precipitanti la recidiva è rimovibile ( terapie inappropriate, scarsa compliance, stili di vita inadeguati ecc ) , né sono disponibili percorsi diagnostico-terapeutici integrati fra Ospedale e Territorio. Non sorprende perciò che a 6 mesi dalla dimissione la mortalità ( 16% ) e la morbidità ( 45 % ) siano molto elevate. I pazienti con scompenso cardiaco sono complessi da gestire sia trasversalmente sia longitudinalmente ( Tabella I ) perché non sono stabili ma tendono ad evolvere e richiedono la rivalutazione periodica e multidimensionale da parte di personale esperto in cardiologia. A ciò si aggiungono tutte le altre problematiche della vita sociale giornaliera ( TabellaII ).
Quale l’impatto e i costi del servizi cardiologici ? La spesa ospedaliera consuma la maggior parte delle risorse economiche della sanità, mentre molto scarse sono quelle riservate alla gestione dei malati nel territorio indispensabili per assicurare la continuità assistenziale. Perciò i risultati brillanti della cura nella fase acuta di molte patologie cardiovascolari,compreso lo scompenso cardiaco, possono diventare “poco efficaci” per l’insufficiente gestione territoriale della cronicità. Inoltre le cure delle malattie cardiovascolari croniche nel territorio sono attualmente relativamente costose ma poco utili per raggiungere obiettivi di salute in quanto gravate da un circolo di “ crisis menagement “che comprende le visite dei Medici di medicina generale (MMG), le consulenze degli specialisti, i frequenti accessi al pronto soccorso e le riospedalizzazioni spesso superflue per patologie che possono essere risolte nel territorio se adeguatamente trattate da personale esperto. Pertanto nonostante il costante aumento dei costi, la qualità delle cure e gli esiti delle malattie cardiovascolari non sono migliorati sensibilmente. La continua lievitazione dei costi richiede modificazioni sostanziali dell’organizzazione sanitaria specialistica territoriale, attualmente caratterizzata dalla frammentazione degli interventi che deve essere superata dalla “ continuità assistenziale “.
Ma cos’è la continuità assistenziale ? A livello internazionale c’è una gran confusione nella sua definizione. Infatti, sono spesso usati come sinonimi: continuità della cura, coordinazione della cura, piano di dimissione, case management, integrazione dei servizi, patient/client care, cure condivise, integrated care, seamless, streamlined ecc. E’ necessario finirla con i facili slogan privi di contenuti. Nella realtà attuale uno scompensato dimesso dall’ospedale ha a sua disposizione quattro possibilità: il MMG, lo specialista SUMAI, l’ambulatorio ospedaliero (dove spesso turnano i medici più giovani o gli specializzandi), il cardiologo personale. Ognuna di queste soluzioni assicura non una “cura” ma una semplice consulenza spesso incompleta e non somministrata al momento del bisogno reale ma dopo un’attesa di giorni, di settimane o persino di mesi. Gli ambulatori ospedalieri non possono gestire tutti i cardiopatici cronici, mentre gli ambulatori specialistici territoriali, salvo rare eccezioni, offrono prestazioni più che assistenza.
Quale futuro per la continuità assistenziale:prendersi cura o presa in carico ? La continuità assistenziale è un progetto unitario di “care” cioè di prendersi cura e di presa in carico delle persone che deve essere personalizzato, multidisciplinare, con coinvolgimento non solo del personale medico (MMG e specialisti) ma anche di quello non medico e a volte anche dei servizi sociali. Essa deve attivare un progetto di salute, preordinato, articolato e condiviso e di presa in carico del paziente da parte dei servizi ( sanitari e sociali ) per assicurare la continuità di un percorso coerente. Se i bisogni degli utenti devono essere al centro del sistema assistenziale, le Aziende devono organizzare un’offerta sanitaria per consentire la presa in carico globale dello scompensato cronico assicurando: - un programma centrato sulla persona, ma con integrazione fra specialisti diversi - la standardizzazione del processo di cura con interventi di provata efficacia - la classica organizzazione patient/client oriented. In altre parole un paziente con scompenso cardiaco non può avere la stessa gestione se giovane o anziano, se vive solo o in famiglia, in città o in montagna, in una casa a piano terra o al quinto piano senza ascensore.
Come garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio? Il problema della continutà assistenziale è molto complesso e richiede da parte delle associazioni culturali e del legislatore un ripensamento ed uno sforzo diretti ad assicurare una più razionale organizzazione dell’assistenza ambulatoriale e domiciliare nel territorio. Come hanno affermato le autorità inglesi è necessario proiettarsi in avanti (moving forward). Infatti, il working group della società inglese di cardiologia già nel 1997 raccomandava al governo che la priorità nazionale doveva essere rappresentata dall’aumento del numero degli specialisti cardiologi con una loro più larga presenza negli ospedali distrettuali che , a loro volta, dovevano essere collegati in rete con quelli ad alta specializzazione per ridurre la mortalità e la morbilità legate alle malattie cardiovascolari. L’attuale rapporto ospedale territorioNel nostro Paese l’attuale rapporto ospedale territorio è caratterizzato da insufficiente comunicazione ospedale-MMG-specialista ambulatoriale per mancanza di linguaggio comune che provoca difficoltà di discussione e di partecipazione reciproca anche per assenza di condivisione di protocolli diagnostici e terapeutici e per difficoltà di contatti tra gli operatori. Tutto ciò causa un inadeguato monitoraggio della cardiopatia e dei trattamenti pos-dimissione, con follow-up ritardati e diluiti e con ricorso spesso superfluo al pronto soccorso o alla riospedalizzazione. In Italia, grazie all’azione dell’ANMCO, è stata realizzata la “ rete “ regionale per il trattamento di alcune patologie cardiovascolari acute. Ma accanto alla riorganizzazione della rete ospedaliera, emerge la necessità urgente di riorganizzare anche la cura cardiologica delle malattie croniche degenerative nel territorio, perché, in opposizione alle tradizionali strutture che prevedono “l’intervento crisi”, le malattie cardiovascolari hanno necessità di una organica cura continuativa che prevede un “ approccio olistico “, adattato al singolo paziente. Per non rendere vani gli sforzi profusi nella cura acuta, il cardiologo ospedaliero deve occuparsi anche della gestione di quella cronica, ipotizzando una rete ospedale territorio.
La rete integrata ospedale territorio: chi fa, cosa fa, quando fa, dove fa . Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ha ipotizzato diverse soluzioni assistenziali per le cure continuative di alcune patologie croniche quali: la degenza postacuzia, l’ospedale di comunità, l’ospedalità domiciliare, l’assistenza domiciliare, la residenza sanitaria (assistenziale, protetta, hospice). Per il futuro della continuità della cura cardiologica (e non solo) è necessario ridisegnare il confronto alla pari fra MMG e specialista con funzioni diverse ma necessariamente integrate per costruire insieme la continuità assistenziale. Il MMG, ordinatore di prestazioni e titolare del budget (gatekeeper and case manager) è l’elemento fondamentale del processo della continuità assistenziale. Ma come questo medico può partecipare alla gestione del suo malato ? Anzitutto leggendo attentamente la lettera di dimissione che, se ben fatta, gli permette di avere un quadro clinico preciso del decorso intraospedaliero e della futura prognosi del paziente. Una volta valutata la gravità dell’episodio in termini prognostici deve: - stabilire il follow-up mirato in rapporto alla gravità della malattia - osservare gli effetti indesiderati dei farmaci prescritti “ acutamente “ in ospedale -valutare la situazione delle comorbilità -coordinare le consulenze specialistiche e gli operatori infermieristici e sociali dell’assistenza domiciliare. Tuttavia una “ vera” continuità assistenziale per lo scompenso cardiaco si potrà realizzare solo se, al MMG si affiancherà personale medico ed infermieristico realmente esperto in cardiologia. Infatti, la presa in carico di pazienti complessi (ad esempio con scompenso cardiaco cronico con defibrillatore e/o stimolazione biventricolare), la cronicizzazione, le comorbilità, la sofisticata diagnostica, alcune terapie “ difficili “ richiedono competenze ad elevato tenore culturale specialistico e professionalità multidisciplinare per patologie che un MMG non può affrontare da solo. Pertanto per stabilire un’efficace continuità assistenziale è necessario individuare un “ nuovo” rapporto tra le strutture ospedalierie, quelle specialistiche del territorio e il MMG che devono svolgere un’attività integrata. Il territorio però ha in campo cardiologico un vuoto specialistico, è impreparato culturalmente e strumentalmente ed infine é ancora “ scollegato” dall’ospedale. La situazione attuale richiede perciò un rivoluzionario cambiamento dell’organizzazione sanitaria specialistica territoriale, modificando il sistema di cura con la creazione del “ multidisciplinary teamwork “, ridisegnando i servizi specialistici in rapporto a criteri epidemiologici e ripensando alcuni ruoli dei cardiologi ospedalieri. In primis, in base alle realtà locali, è necessario definire il bacino di utenza che può essere limitato all’area dell’Azienda o, come si auspica da più parti, allargato all’Area Vasta. L’organizzazione specialistica territoriale deve prevedere la creazione di strutture munite di opportune apparecchiature e di un team adeguato, possibilità di rotazione periodica del personale dall’ospedale al territorio e viceversa per mantenere un adeguato livello di aggiornamento cultuale con l’istituzione di dipartimenti interaziendali e l’incremento dei cardiologi ospedalieri che a turno devono occuparsi anche dell’attività specialistica nel territorio. Solo in questo modo si potrà realizzare la sussidiarietà fra le strutture e garantire qualità ed appropriatezza delle procedure operative. In altre parole accanto alla “rete ospedaliera” è necessario programmare una “rete ospedale territorio “ che assicuri un programma di assistenza territoriale che, se efficace, riduce i ricoveri ospedalieri identificando precocemente eventi minori “prodromici” di quelli maggiori, migliora la prognosi prevenendo aggravamenti con interventi diagnostico-terapeutici tempestivi e in definitiva migliora non solo la quantità ma anche la qualità della vita di molti cardiopatici cronici. Una sinergia vincente deve favorire : -l’aggregazione fra i due servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni cardiologiche stabilendo percorsi condivisi ed idonei a migliorare la cura a lungo termine - l’appropriatezza dei ricoveri e delle cure - la soddisfazione dei pazienti e dei medici - l’utilizzazione più razionale delle risorse - l’assistenza e non solo le prestazioni - l’implementazione delle linee guida e la qualità della cura - la riduzione della spesa sanitaria. Quale modello operativo ? Il modello TriesteAl momento attuale non è ipotizzabile un modello standard di gestione territoriale a livello nazionale ma è necessaria la valutazione operativa delle realtà locali che tenga conto dell’epidemiologia, della condivisione del progetto da parte di tutti gli operatori coinvolti ( direzione generale e sanitaria,divisione di cardiologia e struttura territoriale, personale infermieristico, servizio sociale ).Dal 1967 a Trieste è attivo il Centro Cardiovascolare, una struttura che pur posizionata all’interno dell’Ospedale offre la maggior parte della sua attività al territorio operando da trait-d’union fra Ospedale e territorio. La struttura ,dotata di personale proprio e di proprie apparecchiature, è collegata funzionalmente con la Divisione di Cardiologia mediante il Dipartimento interaziendale, con i distretti e con i MMG ( Fig 3 ). I pazienti che necessitano di continuità assistenziale cardiologica vengono segnalati dalla Divisione di Cardiologia e Cardiochirurgia, dalle altre divisioni ospedaliere, dal referente dei distretti e direttamente dai MMG. Questi vengono inclusi in un data base e richiamati al Centro mediante lettera o telefono o su richiesta del MMG. In particolare per i pazienti con scompenso cardiaco la struttura é collegata anche con l’ambulatorio dedicato della divisione cardiologica. Si è creato in questo modo un modello alternativo di cura per i cardiopatici in generale e per gli scompensati in particolare, assicurando una cura focalizzata sul paziente utilzzando cardiologi specialisti nella cura a lungo termine del cardiopatico cronico. Trieste Heart Failure ProjectIl THFP è un progetto sviluppato dal Centro Cardiovascolare e dalla Divisione di Cardiologia con lo scopo di affiancare il MMG nella gestione extraospedaliera dei pazienti con scompenso cardiaco cronico possibile o definito sulla base dei criteri di Boston ( Fig 4 ). Il Cardiologo Territoriale, il Cardiologo Ospedaliero e gli infermieri professionali collaborano con il MMG nella gestione dei pazienti per i quali venga ravvisata l’opportunità di un follow-up convenzionale (FUC) o che attinga a tutte le risorse dei Distretti sanitari, anche all’assistenza infermieristica
Figura 3: Il modello Trieste
Figura 4: Progetto pilota di cura domiciliare dello scompenso cardiaco
domiciliare (FUAD). Il piano di assistenza concordato tra le varie figure professionali, sulla base della gravità e dell’instabilità clinica della patologia, prevede la monitorizzazione dei parametri clinici e dell’aderenza al programma terapeutico ed un programma di educazione sanitaria e di counselling. Risultati: Dal 1/11/2002 al 15/01/2005 sono stati presi in carico 260 pazienti (124 maschi e 126 femmine; età media 77.8.9±8.03 anni). Centoventicinque (54.6%) dei 229 MMG della provincia di Trieste hanno riferito almeno un paziente. La diagnosi di scompenso cronico è stata confermata nell’80 % dei casi (NYHA 3.3±0.9; eziologia ischemica: 37.6%; eziologia ipertensiva: 20.7%; altro o multifattoriale: 41.7%). In 54 pazienti (21.1%) era già stata eseguita un’adeguata valutazione clinico-strumentale prima della presa in carico. Negli altri 206 (79.2%) è stato necessario completare gli accertamenti strumentali. La consulenza è stato eseguita in media entro 15±5 giorni (nel 53.4% a domicilio). In 183 (60.4%) ed in 77 pazienti (29.6%) è stata posta indicazione rispettivamente a FUC e a FUAD; 5 sono stati ricoverati urgentemente. Cinquantatre pazienti sono stati effettivamente avviati a FUAD dal MMG con accessi ogni 7-15 giorni (13.7±8.3 giorni; n° medio/pz: 13.3±8.8, il 19% avviati a FUC (f-u medio: 2.4+2.8 mesi) ed il 69% avviati a FUAD (f-u medio: 5.2+3.4 mesi) sono stati rinviati dal MMG a consulenza cardiologica.Dall’analisi della nostra esperienza emergono alcune considerazioni: 1) la buona concordanza tra la diagnosi dei MMG e del Cardiologo; 2) la diagnosi di scompenso da parte del MMG viene posta generalmente su base clinica, con scarso ricorso a metodiche strumentali fondamentali per un corretto inquadramento diagnostico-terapeutico;3) la frequente necessità di visite a domicilio; 4) una gestione integrata permette di coinvolgere maggiormente i MMG nella gestione della malattia e riduce il numero di recidive ( 25%) e dei ricoveri ospedalieri per tutte le cause ( 17% ). Dall’inizio del 20064 pazienti con scompenso cardiaco terminale dipendenti dalla infusione di inotropi sono stati trattati a domicilio con dobutamina. Un programma di gestione dei pazienti con scompenso cardiaco che riconosca la centralità del MMG e attinga a tutte le risorse sanitarie è fattibile ed applicabile alla realtà triestina. E’ possibile offrire tale opportunità a fasce di utenza più ampie di quelle finora riportate in letteratura. Appare comunque fondamentale una assunzione di responsabilità ed un ruolo attivo da parte di tutte le figure professionali che hanno in cura il paziente.
CONCLUSIONI Un trattamento razionale della maggior parte dei cardiopatici deve basarsi sulla continuità assistenziale che prevede il coordinamento e la condivisione dei progetti assistenziali e l’interazione tra MMG e le diverse strutture specialistiche ospedaliere e territoriali che devono realizzare una rete assistenziale integrata. Perché il dialogo fra gli operatori di queste strutture sia efficace è necessario che il personale sia preparato e aggiornato culturalmente utilizzando un identico linguaggio di comunicazione e protocolli condivisi. In particolare la realizzazione di una efficace rete integrata ospedale territorio deve prevedere nel territorio la creazione di un’organica struttura specialistica per la presa in carico globale del cardiopatico una volta dimesso dall’ospedale. La dotazione organica e le modalità di intervento devono essere programmate tenendo conto dell’epidemiologia e delle realtà operative locali.
. |