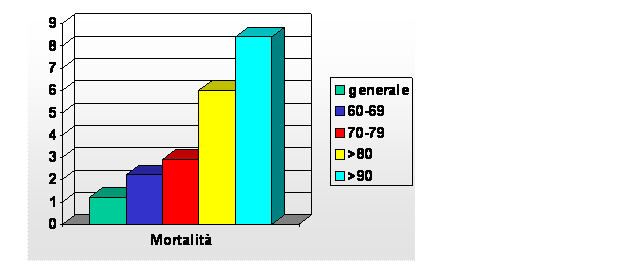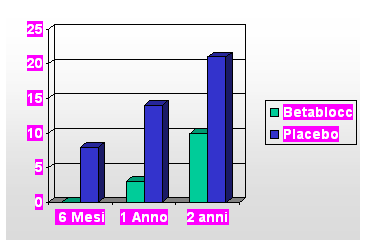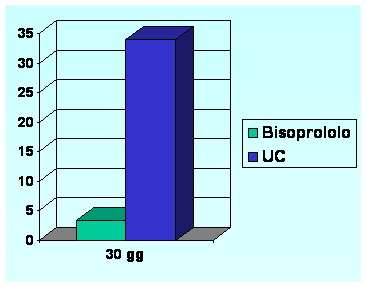|
LA CONSULENZA CARDIOLOGICA: UN’OCCASIONE DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
Carmine Riccio Divisione di Cardiologia Riabilitativa A.O. San Sebastiano Caserta
La consulenza cardiologica per il paziente candidato ad interventi di chirurgia non cardiaca rappresenta una delle attività in cui più frequentemente è coinvolto il cardiologo. Si calcola che negli Stati Uniti vengano effettuati oltre 25 milioni di interventi chirurgici non cardiaci all’anno, in molti dei quali viene richiesta una valutazione cardiologica preoperatoria . La richiesta della consulenza cardiologia è giustificata dall’alta prevalenza di soggetti a rischio di cardiopatia ischemica e della frequenza di complicanze cardiache, tra cui la più frequente è sicuramente l’infarto perioperatorio, al cui sviluppo concorrerebbero meccanismi di: · Attivazione neuroormonale · Incremento delle catecolamine circolanti · Riduzione dei livelli di attivatore tissutale del plasminogento · Aumento dello shear stress con attivazione piastrinica I 50000 casi registrati ogni anno negli Stati Uniti sono responsabili di oltre il 50% dei decessi postoperatori con drammatiche conseguenze in termini di danno per il paziente, costi sanitari e conseguenze medico-legali. D’altra parte è cambiato il profilo del paziente operato, oggi sempre più anziano e spesso cardiopatico con comorbilità rilevanti, quali diabete, insufficienza renale e deficit neurologici. Si prevede che Il numero di procedure chirurgiche noncardiache negli over 65 passi dai 6 milioni attuali ai 12 milioni, di cui un quarto ad alto rischio (addominali, toraciche, vascolari)9).
Cosa viene richiesto al cardiologo quando viene chiamato per una consulenza cardiologica preoperatoria? Fondamentalmente di: 1. Di valutare lo stato cardiovascolare del paziente, evidenziando eventuali cardiopatie sconosciute 2. Di ottimizzare la terapia nel periodo peri e post-operatorio 3. Di collaborare con il chirurgo e l’anestesista alla pianificazione della strategia chirurgica, in termini di tipologia, durata e timing dell’intervento Per quanto riguarda il primo punto, risulta ovvio che il cardiologo debba effettuare: • Un’accurata anamnesi, un esame clinico, l’ecg , al fine di valutare importanti predittori di rischio, quali l’età, una precedente cardiopatia, un eventuale stato di scompenso o presenza di ischemia in atto • Eventualmente ricorrendo ad esami strumentali. Le informazioni più utili potrebbero essere fornite da un ecocardiogramma o uno stress test. Questi esami non devono essere effettuati di routine a tutti i pazienti ma solo in casi selezionati. L’ecocardiogramma va eseguito quando l’inquadramento clinico-anamnestico e la documentazione clinica non siano esaurienti ed in particolare quando l’esame clinico evidenzia segni di precario compenso, per valutare adeguatamente la funzione ventricolare, o quando vi è il sospetto di una patologia valvolare importante. E’ chiaro che il cardiologo richiederà un ecocardiogramma anche nei casi di ecg anormale. Per quanto riguarda gli stress test, le linee guida suggeriscono di richiederli nei soggetti che presentano una scarsa capacità funzionale (<4 Mets), soprattutto quando è previsto un intervento di chirurgia maggiore. In questi paziente infatti vi è una prevalenza di complicanze perioperatorie significativamente più elevata ( 20.4% vs 0.4%). Nei pazienti che non raggiungono l’ 85% della FC max teorica al test ergometrico le complicanze periop. raggiungono il 24%. Va sempre valutata, però, la definizione del rapporto rischio-beneficio, la differibilità dell’intervento chirurgico e lo stato clinico del paziente, allettato, febbrile, disidratato, ecc. Tra gli stress test, laddove eseguibile può essere effettuato un test ergometrico. Negli altri casi un eco-stress, preferibile nei casi dei pazienti in terapia con betabloccanti, o una scintigrafia miocardica possono essere eseguiti con simili aspettative in termini di sensibilità e specificità, lasciandosi preferire anche sulla base dell’esperienza del singolo centro. Tra i punti chiave della consulenza cardiologica, sottolineato anche dalle Linee Guida, vi è quello di non porre indicazioni per un esame coronarografico se non indicato a prescindere dall’intervento chirurgico. Al di là dei rischi connessi alla procedura, va considerato che attualmente l’esecuzione di una coronarografia conduce sempre più spesso ad una procedura di rivascolarizzazione mediante angioplastica, ormai quasi sempre perfezionata dall’ausilio di stent medicati.
Poldermans D et al: N EnglJ Med 1999;341;1789-1794
Tale procedura implica la necessità di proseguire assolutamente per almeno sei mesi una terapia specifica (doppia antiaggregazione), che obbliga a differire qualsiasi procedura chirurgica. Tra l’altro nessun trial clinico randomizzato ha dimostrato una ridotta incidenza di complicanze perioperatorie nei pazienti che hanno effettuato una procedura di rivascolarizzazione mediante angioplastica o bypass. Viene pertanto esclusa l’ipotesi di avviare il paziente ad una tale procedura esclusivamente per portarlo aldilà dell’intervento di chirurgia non cardiaca.
Un
aspetto fondamentale che deve caratterizzare la consulenza del
cardiologo è la ottimizzazione della terapia. Vi sono dati
eclatanti in letteratura sul ruolo della terapia con
betabloccante nel migliorare la prognosi dei pazienti sottoposti
a chirurgia non cardiaca. Dagli studi di Polderman e di Mangano
si calcola che il beneficio di tale terapia va dal 55% al 91% di
riduzione di mortalità Addirittura gli AA concludono che il vantaggio della terapia con betabloccanti è talmente evidente da rendere inutile il ricorso ad altri accertamenti diagnostici Per quanto riguarda altri farmaci vi sono segnalazioni dei vantaggi della terapia con acido acetil salicilico e con statine Quale potrebbe essere quindi il percorso da seguire. Si deve entrare nell’ottica di una decisione condivisa con il chirurgo e con l’anestesista, in cui dopo aver valutato il rischio operatorio, in base a criteri legati all’intervento, alle caratteristiche del paziente ed al Per quanto riguarda l’intervento bisogna considerare a basso rischio gli interventi per via endoscopica, le procedure superficiali, la cataratta e gli interventi sulla mammella. A medio rischio la Endoarterectomia carotidea, gli interventi sulla Testa e collo e sulla Prostata, la chirurgia Intraperitoneale, intratoracica, ortopedica. Ad alto rischio vanno classificati gli interventi maggiori, in emergenza, la Chirurgia aortica e vascolare maggiore la chirurgia vascolare periferica, gli interventi complessi con previsione di importanti perdite ematiche. Per quanto concerne le caratteristiche cliniche del paziente saranno considerati predittori di alto rischio la sindrome coronarica acuta, lo scompenso cardiaco, la presenza di aritmie significative (BAV II-III, FA con FC alta, aritmie ventricolari complicate con cardiopatia) o di valvulopatia severa (specie se stenotica). Predittori intermedi sono l’angina pectoris, un IM pregresso, la disfunzione ventricolare sinistra compensata, Il diabete mellito o un’insufficienza renale. A rischio minore sono l’età avanzata, la presenza di un ECG alterato (IVSn, BBS, sovraccarico), la fibrillazione atriale, una storia di stroke o un’ipertensione non controllata. In base alla caratterizzazione del rischio, secondo le Linee Guida, è necessario rinviare o annullare l’intervento chirurgico in caso di rischio elevato. Nei pazienti a rischio intermedio viene suggerito di differire l’intervento, ottimizzare la terapia, eseguendo poi un attento monitoraggio perioperatorio. Nessun problema invece nei casi di rischio basso. Per quanto concerne gli aspetti medico-legali, che stanno diventando un problema rilevante e quotidiano, va sottolineato, come riferito tra l’altro da un documento della SIARTI, che « …. La scelta e la condotta dell’atto anestesiologico sono di esclusiva competenza del medico anestesista (Legge 9 agosto 1954, n. 653), che decide la tecnica di anestesia e la preparazione alla procedura, in funzione della propria valutazione e della procedura programmata, prendendo in considerazione le richieste formulate dal paziente (o dai genitori ove questo sia un minore, ovvero dal tutore se si tratta di soggetto sottoposto a tutela) e le indicazioni fornite dal medico richiedente… ». Con la dizione “valutazione anestesiologica” si intende il processo di approfondimento clinico e di previsione organizzativa che precede l’atto anestesiologico per procedure diagnostiche e/o terapeutiche. … nella valutazione anestesiologica è di conseguenza importante definire lo stato basale del paziente (valutazione clinica basale), anche attraverso indagini (di laboratorio e/o strumentali) che il medico anestesista reputi necessarie caso per caso, al fine di differenziare alterazioni preesistenti da quelle eventualmente indotte. Diversa è la valutazione del rischio, per la quale va bilanciato lo stato basale del paziente con l’entità della procedura programmata e il tipo di anestesia necessaria…». « …. La valutazione anestesiologica coordina e conclude un più articolato processo di “valutazione multidisciplinare”, teso a definire le condizioni cliniche di base del paziente, le indicazioni alla procedura e i relativi iter diagnostici, anche mediante coinvolgimento di consulenti specialisti di diverse discipline… ». Per cui si potrebbe concludere che il cardiologo abbia i seguenti compiti: • definizione della natura, della gravità e delle ripercussioni della cardiopatia su vari apparati e funzioni dell’organismo; • stratificazione del rischio operatorio, in base alla gravità della cardiopatia e alla natura dell’intervento chirurgico; • pianificazione di una strategia operativa in funzione del rischio. In defintiva lo scopo della valutazione del consulente cardiologo non è quella di fornire una “liberatoria” per l’intervento chirurgico, ma piuttosto di fornire un profilo di rischio cardiologico che possa essere utilizzato da anestesista, chirurgo e paziente per decidere le scelte successive.
|